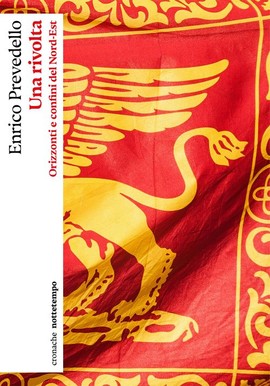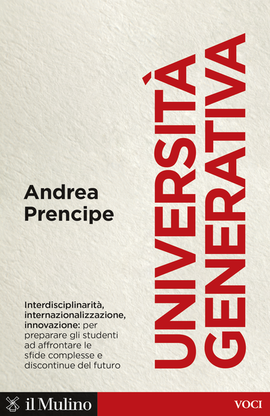Era il 21 gennaio del 2009 quando Barack Obama inaugurava la sua presidenza con quello che sarà ricordato come «il discorso di una nuova era della responsabilità». L’avvio della presidenza di questo giovane americano nero portava con sé, anche in Europa, la speranza che di lì a poco si sarebbe aperta una nuova stagione per i riformisti di tutto il mondo, in grado di cancellare il ricordo e i danni di lungo periodo che la Reaganomics aveva lasciato dietro di sé.
La nuova presidenza arrivava dopo la crisi finanziaria avviata dal fallimento di Lehman Brothers, che aveva incrinato seriamente l’ideologia della responsabilità personale. Si trattava di replicare, intensificandola ulteriormente, la retorica della responsabilità, ed evitare che i dubbi sulla reale efficacia autoregolatrice del mercato potessero diffondersi. Così, a pochi mesi dalla crisi del 2008, il nuovo presidente affermò senza esitazione: «La domanda che abbiamo di fronte a noi non è se il mercato sia una forza positiva o negativa. Il suo potere di generare ricchezza ed espandere la libertà non ha eguali […] Ciò che ci viene richiesto ora è una nuova era di responsabilità – un riconoscimento, da parte di ogni americano, che abbiamo dei doveri verso noi stessi, la nostra nazione, il mondo […]. Dobbiamo rialzarci in piedi, scrollarci la polvere di dosso e metterci al lavoro per rifare l’America».
Un chiaro e violento atto di accusa nei confronti degli eredi dell’ideologia utilitaristica, da Bentham a Bezos passando, naturalmente, per Margaret Thatcher
Non ha dubbi, Neil Vallelly, giovane economista neozelandese, nell’individuare in Obama un seguace del vangelo della responsabilità personale messo in pagina da Reagan, Clinton e Obama. Uno degli elementi cui ascrivere la responsabilità del fallimento dell’ideologia neoliberista di portare a una maggiore prosperità collettiva. Il suo libro – appena uscito tradotto dalle Edizioni Atlantide con il titolo Vite rubate. Dal sogno capitalista al futilitarismo – è un chiaro e violento atto di accusa nei confronti degli eredi dell’ideologia utilitaristica, cui dedica buona parte della prima parte, concentrandosi soprattutto sui danni derivati dall’interpretazione del pensiero utilitaristico di Jeremy Bentham. Prima di Obama, naturalmente, ci sono Margaret Thatcher e la sua idea di non-società (o meglio di una società vista unicamente come un insieme di individui e non come un tutt’uno), e con lei i suoi epigoni, come quel Boris Johnson che nel 2013, proprio nel corso di una conferenza in memoria della Lady di ferro, dichiarò che «un certo grado di disuguaglianza è essenziale per stimolare l’invidia sociale che, come l’avidità, è un prezioso sprone all’attività economica». Con loro, una serie di teorici del neoliberismo che hanno portato le nostre società un tempo definite opulente a essere tali per un numero sempre minore di individui, fornendo un supporto teorico al capitalismo per consentirgli di pretendere un principio utilitaristico chiave (la massimizzazione dell’utilità) senza doverne fornirne un altro (il benessere per la maggior parte degli individui) e consentendo in questo modo l’ascesa di quella che è la tematica al centro di tutto il libro, la «condizione futilitaria», grazie alla quale la pratica della massimizzazione dell’utilità peggiora continuamente le condizioni socio-economiche della collettività. Due secoli dopo Bentham, l’idea di massimizzazione dell’utilità è parte integrante dell’ideologia neoliberista – perché gli individui sono incoraggiati a rendersi utili per sopravvivere, con una idea di utilità che risulta però definita dai datori di lavoro e dalle imprese – mentre domina un individualismo senza una reale libertà: «un individualismo come merce; come sorveglianza; come dati; come narcisismo» (p. 57).
La condizione futilitaria è intrinsecamente legata all’idea di Homo futilitus, che si manifesta in maniera particolarmente evidente nel mondo del lavoro contemporaneo, con l’aumento del lavoro inutile
La condizione futilitaria di cui ci parla Vallelly è intrinsecamente legata all’idea di Homo futilitus, che «si manifesta in maniera particolarmente evidente nel mondo del lavoro contemporaneo, soprattutto nelle società occidentali, con l’aumento del lavoro inutile, in cui molti cittadini sono incoraggiati a dedicare quasi tutto il loro tempo a compiti che hanno poca o nessuna utilità sociale». Tutto questo mentre impera la logica del personal branding, che Vallelly fa risalire a Tom Peters (The brand called You, «Fast Company», 31.8.1997), che ci spinge a occuparci ossessivamente del nostro apparire per risultare più appetibili, per poterci convincere del potere di influenza che esercitiamo sul nostro mondo, con il paradosso che più cerchiamo di distinguerci per apparire, più nel nostro lavorìo in tal senso ci uniformiamo gli uni agli altri. Dove il successo del nostro brand (quello che Jeff Bezos,il Ceo di Amazon, ha definito come «ciò che qualcuno dice di te quando non sei nella stanza») si basa sulla logica del fallimento di tutti gli altri. In questo modo, laddove un tempo eravamo sfruttati dai proprietari dei mezzi di produzione, ora ci autosfruttiamo, in una sorta di sfrenato individualismo che sembra voler negare quanto sosteneva Marx quando (ne L’ideologia tedesca) scriveva che «solo nella comunità con altri ciascun individuo ha i mezzi per poter sviluppare le sue disposizioni» e che «solo nella comunità diventa dunque possibile la libertà personale».
La libertà, oggi, è legata a una promessa illusoria di emancipazione, poiché il capitale trasforma l’individuo da oggetto di analisi economica a partecipante attivo dell’economia. «Ma il senso principale di questa trasformazione consiste semplicemente nel trasferire il rischio inerente all’accumulazione di capitale in capo agli individui piuttosto che alle imprese» (p. 75): solo in apparenza, dunque, il «marchio chiamato Tu» rappresenta una forma di pari opportunità (richiamandosi in fondo all’idea stessa tipicamente americana del farsi da sé, quale che sia il punto di partenza) in cui tutti possono essere vincitori. Il passaggio dall’Homo oeconomicus all’Homo futilitus implica così la ricerca di una massimizzazione dell’utilità, senza che ci si sia prima domandati se tale ricerca potrà giovare alla società nel suo insieme.
Il libro, denso di riferimenti teorici a diversi livelli, non si limita a denunciare la situazione per molti versi penosa in cui tanti di noi si trovano a vivere, nonostante la fortuna di essere nati, come si direbbe, nella parte lussureggiante del pianeta. Aiuta a comprendere almeno in parte le ragioni delle profonde diseguaglianze che permeano le nostre società lussureggianti, tesi cui i teorici dei benefici del neoliberalismo e della frusta e fallimentare teoria del trickle-down oppongono l’argomento della realizzata riduzione dei divari tra Paesi ricchi e Paesi poveri a livello globale. Vallelly ci fornisce vari spunti di riflessione, molti legati alla nostra quotidianità, alcuni impossibili da non cogliere.
Di nuovo, l’applicazione del concetto di utilità ai lavori che molti di noi compiono nella società futilitaria è centrale. Con David Graeber, anche Vallelly ricorre al caso dei mesi trascorsi in confinamento durante le prime fasi della pandemia da Covid-19, dove si è iniziato a parlare di «lavoratori essenziali» ed è emerso con chiarezza quanti e quali siano i lavori la cui reale utilità è assai dubbia, quelli che, eufemisticamente, lo stesso Graeber ha chiamato «bullshit job» (lavori di merda): «Molti lavori di merda sono posizioni dirigenziali di medio livello che non hanno alcuna reale utilità, ma che esistono solo per giustificare le carriere delle persone che li svolgono. Tuttavia, se domani scomparissero, non farebbe alcuna differenza». Di questi, ci ricorda Vallelly, giusto per evitare fraintendimenti, non fanno parte ad esempio gli addetti alle pulizie, gli insegnanti, gli operatori sanitari, i muratori, gli infermieri, le ostetriche.
Un altro punto chiave è quello legato all’utilizzo della tecnologia, che ci ha illusi di poter lavorare meno a pari condizioni, ma che in realtà è servito innanzitutto per ridurre i costi del lavoro umano, aumentando enormemente la precarietà e l’incertezza della vita di molti lavoratori, che non si sono visti alleviare il peso del lavoro svolto quanto piuttosto abbassare gli standard dei lavori svolti e la loro retribuzione. Tutto questo mentre, contestualmente, si accresceva la nostra dipendenza dagli investimenti libidici e narcisistici.
Del resto, come ha scritto Jason Smith (cit. p. 83), «quando il lavoro diventa il luogo dell’investimento libidico e narcisistico, in cui tessiamo una rete di abiezioni e dipendenze che sfrutta anziché reprimere il desiderio, ci attacchiamo alla nostra stessa infelicità». Può sembrare la logica stessa del mercato, che cosa c’è di strano, in fin dei conti? Eppure converrebbe chiedersi se a questa forma di vita, che tende a riprodurre la nostra infelicità anziché liberarci da essa in cambio del tempo speso per saziare la logica del capitalismo neoliberista, non siano legate le tante insicurezze e fragilità che dominano così tanta parte di quella parte del pianeta che abbiamo sempre considerato (per lo più) lussureggiante.

Riproduzione riservata