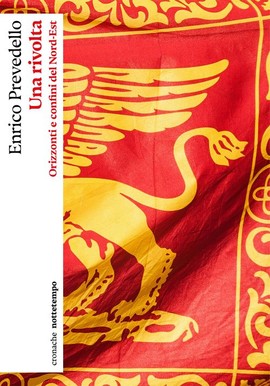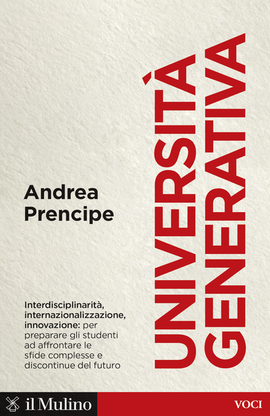Lo strumento utilizzato dai geologi per monitorare i movimenti del sottosuolo è il più delle volte associato alla paura: quando un sismografo registra una serie di valori più elevati della media c’è da stare in guardia, perché potrebbe trattarsi di avvertimenti che preannunciano disastri.
Di questo tipo di sismografi nell’ultimo libro di Francesco Erbani non si parla esplicitamente, per quanto il terremoto e le sue conseguenze siano ben presenti nel racconto di un’Italia che, altrove, vedremmo definita per sbaglio come “minore”. C’è, tuttavia, un altro tipo di sismografo, di tipo sociale, che questa volta più che alla paura può essere associato alla speranza. Un attrezzo che registra i picchi di una nuova socialità, di nuove forme di aggregazione progettuale sparse lungo questa “Italia che non ci sta”, come recita il titolo del libro. Non ci sta a osservare passivamente il progressivo decadimento di un modello che nei decenni immediatamente successivi alla seconda guerra aveva illuso, se non tutti quasi tutti, facendo credere in un’Italia che sembrava potesse solo crescere. Un’Italia che poco alla volta, ma in verità con tempi serrati, vedeva però abbandonare gli equilibri territoriali tra città e campagna, sino a rimodulare drasticamente gli stessi rapporti tra uomo e natura. I risultati di quella grande illusione li vediamo, oggi. E a poco è servito preconizzarne le conseguenze da parte di chi le avrebbe poi viste materializzarsi.
Il libro di Erbani rappresenta una lettura utile e – anche in considerazione dell’editore con cui viene pubblicato, che certo potrà garantirne un’ottima diffusione – necessaria. Non solo per il ritratto complessivo di un Paese così diverso da come viene solitamente rappresentato: si sarebbe potuto dire “un’Italia che resiste” ma, opportunamente, Erbani parla, appunto, di un Paese “diverso”. Da questo punto di vista si imparano a conoscere storie in larga parte poco note. Differenti tra loro, certamente. Ma accumunate da situazioni che fanno da sfondo alla ripresa di luoghi e territori tutte legate agli effetti deleteri dello sviluppismo e alla mancanza di visione che segnò i decenni di cui sopra. Storie, in un modo o nell’altro, segnate da quella che Vito Teti, in uno dei primi libri che andarono a toccare questi temi (Il senso dei luoghi), chiamò, riferendosi nel 2004 ai paesi abbandonati nella sua Calabria, “la ritornanza”; ovvero la ripresa di possesso dei luoghi di origine da parte di chi, venti o trent’anni prima, li aveva abbandonati.
L’abbandono dei luoghi è, nel racconto, ricorrente. Paese dopo paese si danno le cifre di uno svuotamento di vita e di vite del territorio che colpisce anche chi, più o meno, ne ha letto o lo ha vissuto in prima persona. Cito, ad esempio, il caso del Cilento, segnato sin dai primissimi anni Sessanta da un progressivo e inesorabile spopolamento, che segna ormai i tre quarti del territorio (75 comuni su 98): “Dal 1961 il calo medio è del 30%: 57.000 persone sono andate via da questi paesi, 51 dei quali hanno ora meno di 2.000 abitanti”. E il calo demografico è più alto proprio nei comuni più piccoli, in un circolo che si autoalimenta.
Allo spopolamento fa qui da contrasto il ri-abitare i luoghi, il ri-prenderne possesso, secondo forme e modi che appaiono in netto contrasto con la gran parte degli stereotipi che accompagnano il racconto più diffuso del ritorno (come l’entusiastico racconto del ritorno dei giovani alla campagna, ad esempio) o delle forme di rilancio delle tante economie locali. Questo è, a mio giudizio, uno degli aspetti più interessanti del libro, che nell’annotare in una sorta di taccuino i picchi del sismografo sociale dà conto delle forme utilizzate da chi ha deciso di provarci, senza necessariamente restare impigliato nella rete che vede “i territori” innanzitutto come fruttifere icone turistiche. Risposte, anche economiche, a quei nuovi modelli dominanti che sembrano non potere fare a meno della ristorazione tipica e dell’ospitalità di breve periodo, e che in questi casi invece si rivolgono a nuove forze generative dei beni culturali diffusi. Gli esempi nel libro sono tanti, conviene leggerseli e, magari, scoprirne il valore di persona.
È vero, resta, alla fine, la sensazione di avere incrociato grazie agli incontri dell’autore un’umanità di grande valore, seppure a volte segnata da un diffuso senso di fatica e, almeno a me pare, di sottesa malinconia. Affinché le esperienze nuove e diffuse che qui sono narrate possano allargarsi e contagiare altri pezzi di un’Italia diversa di cui tanto c’è bisogno serve, ovviamente, l’aiuto delle istituzioni. Difficile sperare, di questi tempi men che meno, in un supporto che provenga dal governo centrale, incapace di offrire qualsivoglia visione di un futuro di crescita, umana oltreché economica, al Paese che sta fuori e intorno. Un supporto che, viceversa, appare indispensabile, per allargare le singole esperienze a progetti più organici seppure senza fagocitarne il valore; e che dovrebbe fare tesoro del lavoro svolto dal gruppo di studiosi coordinato da Fabrizio Barca sulle aree interne. Quei luoghi nei quali cinque milioni di italiani devono presidiare ben un terzo dell’intero territorio nazionale. Aree che si trovano in un vero e proprio circolo vizioso, ove lo spopolamento di cui si diceva poc’anzi e il calo demografico rendono sempre più esigua la presenza dei servizi fondamentali, a partire dalla scuola, dalla tutela della saluta, dalla mobilità.
Per ora va registrato un altro apporto da parte delle istituzioni, e sono quelle locali, che vedono spesso in prima linea giovani sindaci che riescono a spezzare lo sconforto e il pessimismo diffuso nei confronti della classe politica nazionale. Anch’essi in larga parte “ritornanti”, disposti a rimettersi in gioco per la collettività: la collettività loro che, in fin dei conti, e anche un po’ la nostra.

Riproduzione riservata