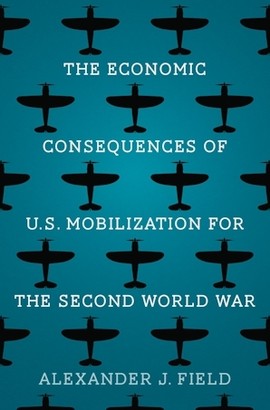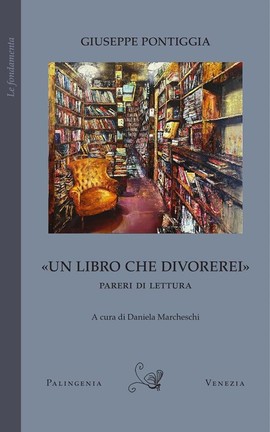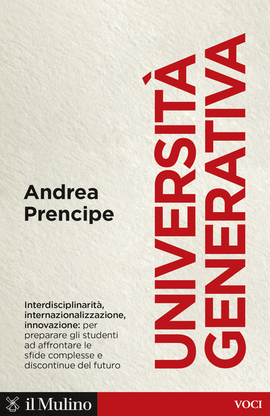Per tirar di sciabola contro il fantasma del “neoliberismo”, negli ultimi anni un’agguerrita pattuglia di studiosi ha riscoperto lo Stato imprenditore. Lo Stato che rammenda i “fallimenti del mercato” è diventato una specie di concessione alla narrazione neoliberista. Serve ben altro, si sostiene da destra a sinistra, per mettere ordine in quel bazaar scombussolato che è il mondo. È la produzione stessa che dev’essere riportata nel recinto delle scelte collettive. La si chiama “politica industriale”, si vuol dire che la decisione di che cosa produrre, in che quantità e in quale modo deve passare per la politica.
Suggerire che si fa in fretta ad arrivare ai panettoni di Stato e a “poli industriali” finiti in rovina è banale provincialismo. Gli aspiranti imprenditori di Stato guardano agli Stati Uniti. Con dovizia di aneddoti, argomentano che il capitalismo americano non solo succhia avidamente quattrini del contribuente, ma che i suoi maggiori successi sono in realtà riconducibili a grandi “missioni” frutto di esplicite decisioni politiche. Pertanto, dallo Stato imprenditore si passa inevitabilmente all’esercito imprenditore: il Gps, per intenderci, è tutt’ora gestito dal governo statunitense. Anche in Europa, ci stiamo muovendo in quella direzione. Ci siamo convinti che, pur di aumentare la spesa, vale la pena persino di accrescere la spesa militare. Conta la geopolitica ma anche i presunti spillover. Se i cannoni creano “posti di lavoro di qualità”, perché no?
In misura maggiore, questo punto di vista si fonda su una certa lettura della storia statunitense: quella per cui il grande sviluppo post-bellico sarebbe stato debitore al grande sforzo messo in campo con la Seconda guerra mondiale. In particolare, ormai è quasi un luogo comune che la necessità di vincere la guerra abbia portato a mettere a punto tutta una serie di nuove tecnologie e nuovi metodi produttivi, i quali in seguito hanno trovato più ampio utilizzo.
Alexander J. Field, della Santa Clara University, col suo The Economic Consequences of US Mobilization for the Second World War (Yale University Press, 2022), prende di petto l’ipotesi che la guerra sia stata una cavalcata trionfale per l’economia americana. Lo fa con un libro che è una miniera di informazioni ma è probabilmente troppo logico e assennato per avere fortuna.
Del resto, Field fa a pugni con un luogo comune “bipartisan”, che è entrato nell’auto-narrazione della destra come in quella della sinistra. Per quest’ultima, la guerra è lo “stimolo” keynesiano per antonomasia. Qualche anno fa, Paul Krugman, ricamando sulla trama di un vecchio episodio di Ai confini della realtà, sostenne che sarebbe valsa la pena di diffondere la paura di un’invasione aliena, se ciò “avesse spinto il governo a spendere, che so, 1.000 miliardi di dollari in telescopi e laser”. Nulla come la guerra porta lo Stato a spendere, spendere, spendere.
Alla destra, invece, la coincidenza fra la fine della Grande depressione e l’inizio della guerra consentiva di affermare che il New Deal, in realtà, non aveva fatto niente di buono. Spesso si è scritto che sarebbero state le imprese americane a “vincere” la Seconda guerra mondiale: una santa alleanza tra bombe e industria, cara ai repubblicani, invece invisa a Field.
Anche sulla scorta di quel luogo comune, negli ultimi anni abbiamo imparato a vedere nelle emergenze qualche cosa di potenzialmente vantaggioso: aiuterebbero a mobilitare risorse al servizio di un grande obiettivo, a smuovere l’economia dall’inerzia (“Guai a sprecare una buona crisi”). Più volte Elly Schlein, per esempio, ha suggerito che con la transizione ecologica dalle energie rinnovabili potrebbero spuntare addirittura mezzo milione di posti di lavoro (versione aggiornata e dimezzata della più antica promessa berlusconiana).
Se una tecnologia richiede più lavoro per raggiungere lo stesso livello di produzione sperimentato in precedenza (non è che Schlein pensi che con le rinnovabili accenderemo più luci o riscalderemo più case), significa che riduce la produttività. Cioè, abbassa la velocità di crociera dell’economia: in Italia lo dovremmo sapere bene, visto che vent’anni di bassa crescita si spiegano appunto con bassi incrementi di produttività.
Perché le emergenze tenderanno a comprimere, almeno nel breve e medio termine, la produttività? Perché esse implicano lo spostamento di risorse (umane e finanziarie) dai loro impieghi precedenti ad altri, diversi. Non necessariamente il modo in cui i fattori produttivi sono combinati in un certo momento è quello “giusto”: i cambiamenti, della tecnologia o delle preferenze dei consumatori, inducono tutti i giorni a tanti, piccoli aggiustamenti. Quelli più radicali, lo sappiamo, tendono a essere dolorosi.
Perché le emergenze tenderanno a comprimere, almeno nel breve e medio termine, la produttività? Perché esse implicano lo spostamento di risorse (umane e finanziarie) dai loro impieghi precedenti ad altri, diversi
Ma costringere, per intendersi, lavoratori che sono abituati a realizzare automobili a fare carri armati, o munizioni, per tacere della necessità di riconvertire gli impianti, ne diminuisce la produttività, semplicemente perché essi ci metteranno del tempo a imparare a far cose che prima non sapevano fare. La conoscenza che mettevano in gioco nel proprio lavoro diventa in parte anacronistica.
Per Field,
“la narrazione della produttività americana in tempo di guerra si è concentrata quasi esclusivamente sui recuperi di produttività che, alla lunga, si sono verificati. Questo significa ignorare gli shock negativi e le perdite associate all’alterazione della gamma dei prodotti e alla stasi intermittente della capacità, a loro volta dovute alla carenza e all’accaparramento di fattori scarsi quali materiali, componenti e talvolta forza lavoro”.
Né, ovviamente, si può dimenticare la natura distruttiva della guerra: che uccide persone, che rende altre inabili al lavoro, che distrugge capitale fisico, infrastrutture e stabilimenti. Il maggiore vantaggio americano, fra il 1940 e il '45, fu proprio quello di essere il Paese più lontano dal teatro degli scontri.
“Sebbene la Seconda guerra mondiale abbia lasciato all’economia del Paese fattori che hanno favorito la capacità produttiva del dopoguerra, il conflitto ha distorto l’accumulazione di beni capitali, scacciando gli investimenti nei settori dell’economia che non rivestivano un’importanza essenziale per lo sforzo bellico. […] Il Paese ottenne grandi risultati produttivi, ma essi non furono la conseguenza di un miracolo della produzione. Tra il 1941 e il 1948, in realtà, nel settore manifatturiero e in quello edilizio la produttività totale dei fattori diminuì e, complessivamente, questo indicatore crebbe più lentamente di quanto non fosse avvenuto tra il 1929 e il 1941”.
Si potrebbe ribattere che, per quanto imprenditori e lavoratori siano stati costretti ad apprendere cose nuove, queste ultime nondimeno sono servite loro in tempo di pace. Il saggio di Field dimostra con pazienza, esempio dopo esempio, che
“dopo la guerra, buona parte delle tecniche apprese per la produzione di bombardieri B-24 e carri Sherman, così come gran parte dei macchinari specializzati prodotti per agevolare la produzione di armamenti, vennero gettati alle ortiche, conteggiati come perdite nette o enormemente svalutati perché il Paese cessò di produrre gran parte dei beni del tempo di guerra”.
Qualche osservatore malizioso potrebbe sospettare che il livello, ancorché infinitamente più basso, di mobilitazione resosi necessario con la Guerra fredda si spieghi anche per continuare a sfruttare quel know how, ossia per sostenere l’industria bellica. Come ha ricordato Robert Higgs, nel 1945 e nel 1946 la rapida smobilitazione militare portava le spese per la difesa a quello che sarebbe rimasto il livello più basso dei cinquant’anni successivi, vale a dire il 4,3% del Pil (comunque tre volte il livello del 1939). Fra il 1948 e il 1989, la spesa per armamenti in media pesò per il 7,5% del Pil. Operando un po’ come una fisarmonica: a periodi di (relativa) smobilitazione seguivano momenti di rimobilitazione, come durante la guerra di Corea, la guerra del Vietnam o con le “guerre spaziali”. Field potrebbe ricordarci, a vantaggio della sua tesi, che nessuna di queste fasi di riarmo è stata considerata propedeutica a una stagione successiva di crescita economica.
Ad andarla a cercare, c’è sicuramente qualche innovazione dovuta all’esercito imprenditore, che poi ha trovato ampia applicazione civile (come il già citato Gps). Field ci rammenta qualcosa di ovvio, che di questi tempi si tende spesso a dimenticare:
“per quanto alcune innovazioni del tempo di guerra abbiano trovato applicazioni in tempo di pace, l’obiettivo preminente delle attività di ricerca e sviluppo era quello di vincere la guerra, il che, nella maggior parte dei casi, si traduceva nella realizzazione di metodi più efficienti per distruggere edifici, infrastrutture, macchinari e materie prime, oltre che mutilare, bruciare o uccidere soldati e civili nemici”.
Un concetto chiave dell’economia è quello di costo-opportunità. Che, semplificando, significa che il vero costo di un bene, di un servizio, di un’azione è la più allettante alternativa disponibile. Bisogna proprio pensare che il mondo sia hegeliano, per trovare nell’economia di guerra il segreto del capitalismo americano: perché per quanto, indubitabilmente, essa ha sviluppato alcune tecnologie che poi sono state inserite in prodotti realizzati e consumati in tempo di pace, sono molte di più le risorse che ha sottratto allo sviluppo economico.
Il libro di Field è un libro di casi, quello più rilevante è la produzione bellica di gomma sintetica, esaminato per lungo e per largo. Di norma lo si considera un miracolo dello sforzo bellico, mentre per l’economista dell’Università della California, “se prendiamo in considerazione il disegno del programma e i ritardi nella costruzione degli impianti, possiamo dire che è stato un vero miracolo che la sua attuazione non ci abbia fatto perdere la guerra”.
Nelle aree in cui maggiori sono stati gli investimenti militari durante la guerra, più alta è stata la registrazione di brevetti negli anni successivi la guerra
Particolarmente prezioso, soprattutto per i dibattiti odierni, è il capitolo dedicato a ricerca e sviluppo, anche perché altri studiosi hanno suggerito che nelle aree in cui maggiori sono stati gli investimenti militari durante la guerra, più alta è stata la registrazione di brevetti negli anni successivi la guerra. Field ricorda che, durante il conflitto, “per l’aviazione e la cantieristica, il tasso di registrazione di brevetti rimase stabile se confrontato al periodo prebellico, mentre diminuì nel caso della chimica, con riduzioni drastiche per i prodotti petroliferi, gomma e plastiche, strumentazione, metalli lavorati e altri macchinari, particolarmente se raffrontiamo il periodo 1941-1948 con il 1932-1940”. Mentre il numero di brevetti si riduce in quegli ambiti nei quali si smette di fare ricerca e sviluppo (per gli “automezzi, i brevetti concessi furono mediamente 2.411 all’anno tra il 1932 e il 1940, riducendosi a 1.393 tra il 1941 e il 1948”), nel settore dell’aviazione, in tutta evidenza particolarmente strategico, “i livelli durante la guerra e la smobilitazione furono pressoché identici a quelli dei sei anni precedenti”. I brevetti che vennero impiegati nella tecnologia bellica, sostiene Field, risalgono per la più parte agli anni Venti e Trenta.
Non è sorprendente. La produzione si svolge nel tempo, richiede nel tempo. Ci sono costi di adattamento, nel passare dal produrre un certo bene a realizzarne un altro. Bisogna risistemare i fattori produttivi, e cercare di renderli almeno altrettanto fecondi che in precedenza. L’innovazione produttiva ha bisogno di creatività quanto quella artistica o letteraria, ma non è qualcosa che si compia fra uno scrittore e un foglio di carta.
Per questi motivi, è più probabile che la guerra abbia rallentato, anziché accelerare, alcune innovazioni. “Gli Stati Uniti parteciparono alla Seconda guerra mondiale per meno di quattro anni: la mobilitazione venne attuata per 22 mesi. Per accreditare un’innovazione alla mobilitazione per la guerra, bisogna sempre chiedersi: cosa sarebbe avvenuto se la guerra non fosse scoppiata?”.
The Economic Consequences of US Mobilization for the Second World War dovrebbero leggerlo tutti quelli che tendono a pensare che la produzione sia qualcosa di facile, di immediato, per cui agli annunci da parte di una qualche autorità corrisponde necessariamente un certo esito.
Per Field, “a dispetto dell’evidente disfunzionalità, un’economia fortemente regolamentata riuscì a produrre e distribuire quello che era necessario per sconfiggere le potenze dell’Asse”. La guerra (o l’emergenza) comprimono la logica della convenienza e spingono a fare qualsiasi cosa, “costi quel che costi”, per vincere. Il problema risiede nel pensare che ciò che in qualche momento è tristemente necessario possa essere anche ricondotto in qualche modo alla categoria dell’utile. Un’economia di guerra vede, per definizione, la subordinazione di tutti i fini all’unico obiettivo di imporsi sull’avversario. Proprio per questo, peggiora il livello di vita delle persone (che sono costrette a confrontarsi col razionamento) e l’efficienza dell’economia. Anche per questo uno dei saggi del Novecento, Ludwig von Mises, sosteneva che “una guerra vittoriosa è male anche per il vincitore”.

Riproduzione riservata