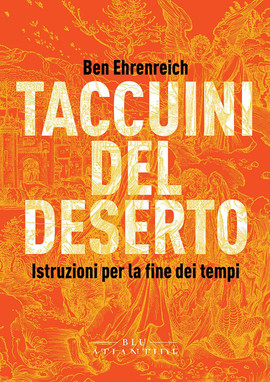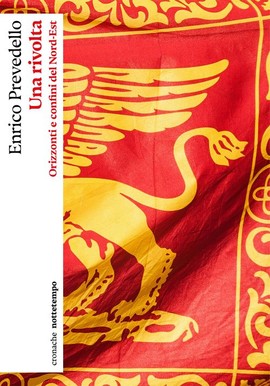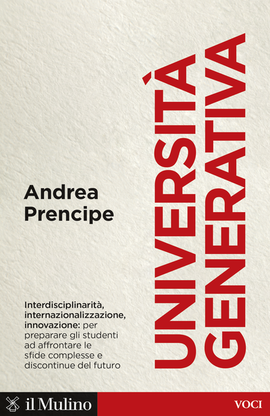È il contrasto forte e scolpito nel tempo tra un’umanità incapace di vedersi da fuori e una natura impassibile ma non immutabile a segnare le pagine di questo strano libro di Ben Ehrenreich, autore americano, romanziere, saggista e reporter. Un libro che intervalla un racconto in prima persona nell’America di oggi, per la precisione nell’America del “Rhino” Donald Trump, con ampie digressioni antropologiche a archeologiche, in un rimando continuo ad autori in diversi casi poco conosciuti al lettore.
Il deserto del titolo è quello californiano del Mojave, un’area che si estende per 130 mila chilometri quadrati a 160 chilometri da Los Angeles, sede del Parco nazionale del Joshua Tree. Deserto come ci si aspetta da un deserto: per molti versi inospitale, dove le temperature raggiungono facilmente i 50 gradi in estate e, sui rilevi, i meno 20 in inverno, seppure di una bellezza assoluta nella sua realtà naturale. Una natura che sembra impassibile di fronte al mutare delle condizioni climatiche, con una “crosta criptobiotica” fatta di microrganismi – batteri, licheni, muschi, alghe, funghi – che ricopre il suolo, con “una rete invisibile di tentacoli fibrosi che permette al suolo di assorbire la pioggia e resistere al vento, dando riparo alle radici delle piante a agli animali che scavano e si rintanano sotto”.
Come il sottotitolo esplicito lascia intendere – Istruzioni per la fine dei tempi – Ehrenreich non abbonda in ottimismo, almeno rispetto al futuro degli uomini sul pianeta; mentre sul pianeta medesimo non lascia trasparire alcun pessimismo: in qualche modo, alla fine, saprà cavarsela. Le lunghe parentesi nel racconto dedicato agli studi archeologici e alle ricostruzioni scientifiche dei mutamenti ambientali ci portano là dove l’autore vuole arrivare, mostrando che in fondo il disastro è già accaduto. È l’idea stessa di progresso e di sviluppo ad essere messa in dubbio, attraverso la decostruzione dei modelli teorici dei suoi ideatori. In questa chiave, la civilizzazione non è una conquista quanto piuttosto una grande sconfitta. Il progresso di alcuni si è fondato sulla sconfitta e l’annientamento di molti altri. L’idea di fine dei tempi è tanto vicina quanto in fondo poco dovrebbe impressionarci perché non è troppo diversa da quella che tante umanità prima della nostra hanno vissuto. Ed è proprio il deserto che consente una tale riflessione, facendoti arretrare sino a mettere in fondo alla scena ogni intervento antropico, gettando luce sull’idea stessa di eternità.
Le grandi aree controllate dai militari sono onnipresenti, macchine organizzate che danno lavoro a migliaia di americani e che qui si dividono tra enormi depositi di armi e munizioni, centri di sviluppo, zone dedicate ai test militari
Tutto impatta con ciò che c’è di antropizzato a poca distanza dalla durezza del deserto. Las Vegas è a breve distanza. Le grandi aree controllate dai militari sono onnipresenti, macchine organizzate che danno lavoro a migliaia di americani e che qui si dividono tra enormi depositi di armi e munizioni, centri di sviluppo, zone dedicate ai test militari. Tutto si traduce in grottesco loisir, anche questo. Così a Las Vegas con 2500 dollari puoi eccitarti al massimo schiacciando una macchina sotto i cingoli di un carrarmato Miai Abrams, una bestia da 60 tonnellate del tipo di quelle utilizzate per salvare l’Occidente nelle guerre in Kuwait e Iraq.
A nord dell’Oasi di Mara, ad esempio, c’è una base dei marine. All’inizio della Guerra fredda l’esercito aveva poi bisogno di un’area enorme, disabitata, per le esercitazioni e per gli esperimenti. Naturalmente atomici. Nacque così il Nevada Proving Grounds, dove tra gli anni Cinquanta e i Novanta vennero fatti esplodere oltre novecento (900) ordigni nucleari. La base dei marine c’è ancora, è il Marine Corps Air ground Combat Center Twentynine Palms, mille metri quadrati di deserto con diverse ricostruzioni di villaggi afghani per consentire esercitazioni il più possibili veritiere, sul campo. La guerra è una cosa seria da queste parti. Le sue conseguenze anche, in genere altrove.
Leggendo le pagine dedicate al Caesars Palace, ho ripensato a quando, alla fine degli Ottanta, dalla provincia americana presi un Greyhound insieme a pensionate e pensionati americani che, in un giorno, andavano a giocarsi la pensione. Il biglietto del bus includeva l’ingresso al casinò più un numero minimo di gettoni per le slot machine e una pausa pranzo, hamburger (piccolo) e lattina di coca. Ma la descrizione di Ehrenreich dell’iper realtà che sovrasta gli umani che vagano per Las Vegas supera qualsiasi ricordo: “La prima cosa che si vede – anche se probabilmente non li noterete perché i vostri occhi saranno rapiti dalle luci lampeggianti, e dalla gente, dalle luci e dalla gente, e perché sono stati pitturati con colori stravaganti per meglio confondersi con l’ambiente - sono i paletti e le barriere di cemento che bloccano l’ingresso ai furgoni che sfrecciano e alle aspiranti autobombe. […] Quasi nessuno sorrideva. La violenza – muta, camuffata, eppure palpabile – fluiva negli spazi che separavano i corpi”. C’è un che di perennemente grottesco, violentemente grottesco, nella dimensione umana che si affianca al silenzio del deserto californiano. La ricerca dell’eccesso, in sé non esecrabile, è sostituita dall’eccesso preconfezionato, spavaldamente esibito in ogni angolo, in un contrasto impietoso con la povertà e l’emarginazione. “Ho a malapena notato il colonnato di marmo bianco e rosa; le gigantesche cariatidi a seno nudo; gli enormi murales pieni di nuvole; le figure dipinte affacciate a finestre finte che si aprivano su finte terrazze sopra le finte strade lungo le quali arrancavamo a bocca aperta, trascinandoci dietro corpi che, in tutta la loro ingiustificata autenticità, apparivano improvvisamente grotteschi”.
C’è un che di perennemente grottesco, violentemente grottesco, nella dimensione umana che si affianca al silenzio del deserto californiano. La ricerca dell’eccesso è sostituita dall’eccesso preconfezionato, spavaldamente esibito in ogni angolo, in un contrasto impietoso con la povertà e l’emarginazione
La scrittura di Ehrenreich si contorce, tra descrizione piana della realtà che incontra, vuoto e silenzio, oppressione e violenza. Sullo sfondo, i cambiamenti climatici e le loro conseguenze palpabili, a lungo ignorate da tutti, a oggi ignorate da molti. Leggendo questi Taccuini del deserto viene da pensare “non ce la faremo mai”. Ma il mondo non è tutto a Las Vegas, anche se quei modelli – che visti dall’Europa ci appaiono ridicoli e del tutto irrealizzabili altrove ‑ hanno invaso buona parte degli Stati Uniti e gran parte del mondo. Il nonno dell’autore, leggendo Marx, arrivò a credere alla possibilità di un mondo migliore. Noi abbiamo deciso che Marx fosse definitivamente superato quando ci siamo accorti che c’erano modi molto più comodi di passare il tempo e abbiamo scelto di ignorare chi, dopo di lui, ha continuato ad avvertirci che qualcosa non funzionava e che avremmo dovuto darci da fare per cambiarlo. È successo anche per l’abuso dell’ambiente, in atto dai tempi della prima Rivoluzione industriale, come l’autore racconta nella prima parte del libro. Oggi ci ostiniamo a negarlo, accettando impassibili le risposte che – certamente non solo Rhino ma con lui tantissimi altri, anche nostri vicini di casa e di scrivania – danno alle domande con cui gli ambientalisti cercano di sensibilizzare le coscienze: “fa freddo, quindi il riscaldamento globale è una bufala”, “il cambiamento climatico è un processo naturale del pianeta, è capitato in diverse epoche della storia”, o altre amenità del genere. Il libro di Ehrenreich racconta un’altra storia, e lo fa in maniera convincente e senza accanimento, ricostruendo molti dei pezzi della storia dell’umanità che ci hanno portato a questo punto, anche in termini di diseguaglianze e divari tra popolazioni e all’interno dei singoli Stati, e che dovrebbero averci insegnato qualcosa.

Riproduzione riservata