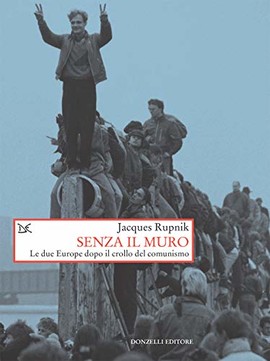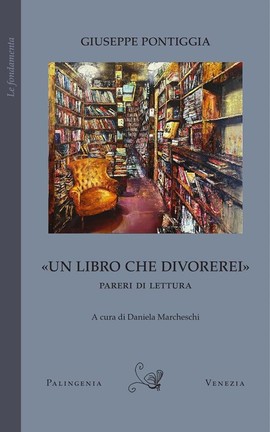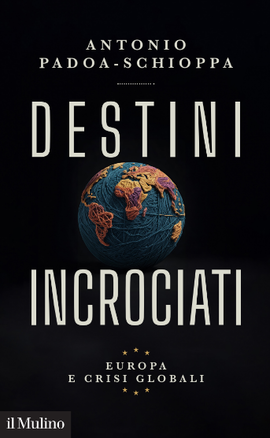Senza il muro. Le due Europe dopo il crollo del comunismo è la prima monografia edita in italiano (Donzelli, 2019, trad. di D. Scaffei) di Jacques Rupnik, politologo francese nato a Praga, professore a SciencesPo. L’opera raccoglie suoi articoli usciti nel corso di diversi anni ed è aperta da un’introduzione inedita. Il titolo, neanche a dirlo, cade a pennello con l’anniversario che ricorre quest’anno: era il 9 novembre del 1989 quando a Berlino il muro forse più famoso della storia, per lo meno europea, veniva abbattuto. Nel 1999 a Praga, ricorda l’autore, durante un incontro in occasione del decimo anniversario della fine del comunismo in Europa centrorientale, al quale erano radunati tra gli altri Vaclav Havel, George Bush, Margaret Thatcher, Helmut Kohl e Lech Wałęsa, Michail Gorbačëv affermò: “Ho dato loro la libertà senza chiedere cosa ne avrebbero fatto…” (p. 40). Il libro di Rupnik cerca di ricapitolare e analizzare proprio questo.
Qual è l’eredità di quel momento epocale per la storia dell’Europa e soprattutto di quell’altra Europa che abbracciava allora la retorica del “ritorno”?
“Il 1989 può essere considerato l’ultimo momento in cui l’Europa ha costituito lo scenario principale di un evento mondiale. Da allora il centro di gravità è andato spostandosi verso Est, dall’Atlantico al Pacifico”, scrive Rupnik. È questa la data fondamentale attorno alla quale ruotano tutti gli interventi raccolti nel volume. Qual è l’eredità di quel momento epocale per la storia dell’Europa e soprattutto di quell’altra Europa che abbracciava allora la retorica del “ritorno”? Non era forse cambiata l’Europa stessa nel corso del tempo, così come i Paesi oltrecortina? O forse, gattopardescamente, tutto era cambiato perché nulla in sostanza cambiasse? Sono molte le questioni che vengono sollevate e analizzate da Rupnik nel volume, altrettanti sono i dubbi e le riflessioni che rimangono aperti e stimolano ulteriori ragionamenti in seno al lettore – il quale, perché no, può anche obiettare alle posizioni dell’autore.
Evitare di bollare le derive nazionaliste e populiste cui si assiste in Europa centrale e orientale come semplice “nazionalismo post-comunista”, piuttosto analizzarne le caratteristiche, diagnosticarne i sintomi e le cause
È tempo di chiamare le cose con il proprio nome, sembra ribadire Rupnik nel libro, ed evitare di bollare le derive nazionaliste e populiste cui si assiste in Europa centrale e orientale come semplice “nazionalismo post-comunista”, piuttosto cercando di analizzarne invece le caratteristiche, diagnosticarne i sintomi, le cause. I leader populisti, da una parte e l’altra d’Europa e ovunque nel mondo, scrive Rupnik, “rivendicano un monopolio politico-morale sulla rappresentanza del popolo, e di conseguenza ostacolano l’espressione del pluralismo”, favorendo a un tempo forme di capitalismo “statale” basate su favoritismi riservati a un clan di persone legate a doppio filo con chi sta al potere (a questi vengono infatti concessi appalti, fondi, concessioni, ecc). Non è la crisi economica ad aver avvicinato determinati stati della regione a un’idea di leadership forte, a un modello di società “protetta” e non “aperta”, tanto che la maggior parte di essi non ne ha affatto risentito: “la Polonia è l’unico paese dell'Ue a non conoscere la recessione dopo il 2008” e “la Repubblica Ceca ha il tasso di disoccupazione più basso d’Europa (2,5%), e in termini di ricchezza la regione di Praga è al settimo posto su scala continentale”. Cosa porta allora, ad esempio, si chiede l’autore, i cittadini tedeschi dell’ex-Ddr a votare oggi candidati e partiti di destra ed estrema destra, esprimendo intolleranza e chiusura nei confronti di immigrati e popolazione musulmana, in scala maggiore rispetto ai connazionali dell’ex-Bundesrepublik?
A margine di una presentazione del libro, chiediamo al professore se, alla luce degli avvicendamenti politici e sociali degli ultimi tempi, gli anni Novanta, ossia il periodo di riforme e aperture per questa regione d’Europa, siano da considerarsi un fallimento: “Non direi che la caduta del Muro di Berlino sia stata un fallimento, anzi. Dopo 40 anni di regime, ha dato respiro a rinnovate speranze. È stato qualcosa di insperato. Prima di parlare di fallimenti bisogna prendere in considerazione la situazione di partenza e rispetto a quella è evidente che si è trattato di un cambiamento epocale. I Paesi che si trovavano una volta oltrecortina si sono trasformati e infine hanno persino aderito all'Ue. E, cosa più importante, tutto è avvenuto senza violenza, senza guerre, in maniera non traumatica. I primi 15-20 anni seguiti all’abbattimento del Muro sono stati un successo dopo l’altro, soprattutto se li guardiamo alla luce della tragedia che si stava consumando allora nei Balcani. In ogni caso, dopo aver reso omaggio al 1989, alla caduta del muro, è necessario anche gettare uno sguardo sulla situazione odierna, osservare la generazione che è venuta con il 1989 e dopo il 1989, di cui Orbán e Kaczyński sono l’epitome. Bisogna capire quali sono i motivi per cui oggi governano tali leader, perché questi Paesi hanno vissuto tale regressione democratica”. E aggiunge: “Il 1989 ha aperto un ciclo liberale che ora si può dire concluso. Quali scopi si sono perseguiti? La democrazia liberale, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, la libertà in senso lato, il passaggio all’economia di mercato, l’uscita dal dominio dell’Urss. Bene, si sono raggiunti tutti questi obiettivi, la missione è compiuta, eppure ora ogni cosa attraversa una crisi, è in crisi l’economia, è in crisi il sistema Ue. La regressione democratica si osserva sì nell’Europa centrorientale, ma è in atto anche altrove nel continente, se prendiamo il caso britannico o la figura di Matteo Salvini, ad esempio”.
Forse la dissidenza, l’intelligencija che nel 1989 invocava a gran voce la libertà non era l’espressione del desiderio collettivo della popolazione, chiediamo allora a Rupnik. “Ci sono due teorie a riguardo. Secondo la prima, i dissidenti erano la punta dell’iceberg, gli araldi di chi non poteva parlare. Si può prendere a sostegno di questa tesi il caso del presidente ceco Vaclav Havel: passò dalla prigione direttamente alla presidenza del suo Paese [Rupnik era allora suo consigliere, Ndr]. La seconda teoria è che l’intelligencija fosse completamente distaccata dalla popolazione. Orbán e Kaczyński, leader delle democrature odierne di Ungheria e Polonia, sono due ex-dissidenti. Come spiegarcelo? Ebbene, ci sono evidentemente più motivi che portano a essere dissidenti: non lo si è solo in difesa dei diritti umani, delle libertà, della democrazia; anche il nazionalismo rende dissidenti. Cosa possiamo sapere noi di cosa si nasconde dietro a una dissidenza?”.
Vi è forse allora una sostanziale incomprensione di fondo, relativa ai cosiddetti “valori europei”, propone l’autore, cercando di spiegare le derive autoritarie in Europa centrorientale. Da un lato, infatti, principalmente nella regione occidentale del continente, con l’espressione si tende a indicare universalismo umanitario, apertura, società multiculturale; dall’altro lato, invece, si sottintendono identità culturale, chiusura, difesa della civiltà cristiano-europea.
O ancora, gioca forse un ruolo non secondario il “panico demografico”: “Mentre fra il 1990 e il 2015 la popolazione dell’Europa occidentale è aumentata dell’11%, quella dei Paesi dell’Europa dell’Est è diminuita del 7%. La Bulgaria e la Romania hanno perso fra un quinto e un quarto della loro popolazione, e un milione di polacchi lavorano in Gran Bretagna”. Il timore diffuso è che la nazione stessa letteralmente scompaia.
Jacques Rupnik individua schematicamente tre traiettorie imboccate dai Paesi usciti dall’orbita comunista dopo il 1989: in Georgia, Armenia e Ucraina si è assistito, anche recentemente, a “rivoluzioni colorate” che hanno cercato ognuna a suo modo di dare avvio a un processo democratico; alcuni Paesi invece come la Bielorussia (ma Rupnik nel libro annovera, uscendo dai confini europei, anche il Kazakistan, l’Azerbaijan e il Tagikistan) hanno instaurato regimi autoritari duri; infine, si è osservato in più Stati l’avvento di forme statali ibride, di “democrature” (blend di democrazia e dittatura). Queste ultime possono essere viste o come una versione attenuata di un regime autoritario o come una versione degradata o deviante della democrazia: se la prima variante caratterizza in genere gli ordinamenti politici dello spazio post-sovietico, la seconda si identifica principalmente nell’Europa centrale.
Il “deconsolidamento” della democrazia in particolare nelle odierne democrature ungherese e polacca, ma anche nel caso di quella ceca, ha risentito fortemente, secondo Rupnik, dell’elezione del presidente Trump negli Stati Uniti: “Trump è stato salutato da Orbán, da Kaczyński e dal presidente ceco come un alleato ideologico nella contrapposizione al liberalismo europeo: l’Europa occidentale ci bolla come dei retrogradi post-comunisti, invece noi eravamo l’avanguardia dell’ondata populista e sovranista che sta arrivando”. Un’ondata che questi leader auspicano travolga tutto il continente e soprattutto l’Ue: al netto della Brexit, infatti, non è un’uscita dall’Unione quella evidentemente più auspicabile, ma una sua completa rivoluzione.
Si tratta di un'“avanguardia” populista e sovranista che, a distanza di appena trent’anni dall’abbattimento di un importantissimo muro, oggi ne invoca l’erezione di molti altri, facciamo notare all’autore. “Oggi assistiamo alla diffusione del nazionalismo e del populismo, di sistemi che scelgono di erigere sempre nuovi muri – come quello al confine con il Messico o quello ungherese al confine con la Serbia”, conferma Rupnik. “Ma il muro di per sé è un’anomalia della storia. Il titolo del mio libro L’altra Europa (Autre Europe, 1993) era stato scelto per ribadire che anche lì, oltrecortina, esisteva l’Europa. Un muro che cade implica un’apertura al mondo. In sostanza, però, il muro più difficile da abbattere resta sempre quello nelle nostre teste. Dopo il 1989 siamo vissuti credendo in un’utopia: eravamo convinti che la comunicazione globale ci avrebbe portato automaticamente all’accettazione dell’altro. È avvenuto se possibile l’opposto: siamo giunti in un’epoca post-fattuale, dove si diffonde sempre più odio anche attraverso i mezzi di comunicazione”.
Un’epoca post-fattuale in cui va di moda anche riscrivere la storia, lo incalziamo, o esasperare conflitti di memorie mai sopite: in settembre il Parlamento Ue ha votato una risoluzione che va a equiparare le vittime di comunismo e nazi-fascismo. “Sicuramente la riscrittura della storia è un fenomeno legato alla situazione politica odierna”, commenta il professore. “Ci sono innanzitutto due macro-divisioni nella visione della storia: da una parte, vi è la memoria del comunismo, che distanzia chi lo osservava da fuori e chi invece se ne sentiva "occupato"; dall’altro lato, vi è la memoria del nazi-fascismo e della Seconda guerra mondiale in generale, in riferimento alla quale l’Europa orientale si vede e si racconta come l’"eterna vittima della storia". Dopo il 1989, si parlava molto del "ritorno all’Europa": ma l’Europa era ed è divisa in maniera profonda sul comunismo, sulla sua memoria e sul suo significato. Per decenni ci siamo convinti che almeno la memoria della Seconda guerra mondiale fosse la stessa da una parte e l’altra dell’Europa, che l’esperienza del nazi-fascismo fosse condivisa. Invece, ora scopriamo che non è cosi, se prendiamo ad esempio il caso dei Paesi baltici, ma anche della Polonia. A proposito di riscrittura della storia, a Varsavia non troppo tempo fa hanno fatto un passetto in più, legiferando sulla storia: si nega per legge il collaborazionismo polacco. La storia è materiale di lavoro dello storico, non di chi scrive le leggi. Quando studiavo all’università, ci insegnarono a maneggiare le fonti, a studiarle, a verificarle: chi le ha scritte, per chi. Il contesto cambia molto una fonte”.
[Questo articolo è stato pubblicato su «Osservatorio Balcani e Caucaso»]

Riproduzione riservata