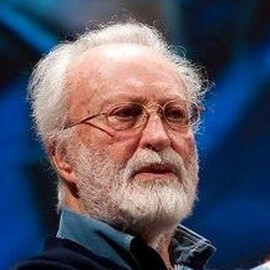Non so se sia stato il più grande giornalista italiano del Novecento. Anche perché in tutti i campi queste classifiche lasciano il tempo che trovano. Figuriamoci nel giornalismo, dove le variabili intervenienti sono tante e tali. E, peraltro, la grandezza richiama inevitabilmente giudizi personali, gradimenti che attingono a una vasta gamma di motivazioni.
Ma certamente Scalfari è stato il giornalista italiano più importante del Novecento. Lo è stato per 3 motivi, qui e là richiamati nei tanti articoli scritti in questi giorni su di lui.
Innanzitutto, perché ha cambiato il modo di fare giornalismo in Italia; in secondo luogo, perché ha riproposto negli anni Settanta del Novecento la figura del direttore-editore, ben nota a fine Ottocento, ma che un secolo dopo ha assunto tutt’altro significato, in quanto facilitava quello stretto legame fra “fabbrica delle idee” e “prodotto da vendere” che da sempre costituisce il delicato equilibrio su cui il giornalismo deve reggersi. Con sempre maggiore difficoltà, come anche la parabola proprietaria di Scalfari dimostra. Ma il motivo più importante è il terzo: nel suo percorso Scalfari ha lentamente ma progressivamente costruito un’area culturale nel Paese, sapendone leggere per tempo le traiettorie evolutive. Per questo motivo è riduttiva la definizione – peraltro ambivalente se non malevola – di giornale-partito, attribuita a “la Repubblica”, mentre è più adeguato parlare di giornale-stile di vita. Un giornale identitario, come poi sarebbero diventati tanti altri - ma mai come quello scalfariano - nel corso degli anni. Torneremo dopo su quest’aspetto, che abbiamo già definito il più rilevante perché ha permesso, in un Paese in cui il giornalismo non ha mai rivestito un ruolo di fondamentale rilevanza come invece in altri contesti nazionali, di far nascere proprio da un giornale un orizzonte di senso condensatosi poi in cultura condivisa, almeno per una parte significativa di quella che – con le solite approssimazioni del caso – viene definita la “sinistra”.
Perché si può parlare di una vera e propria rivoluzione giornalistica? Credo che lo abbia ben sintetizzato il suo successore alla guida de “la Repubblica” - Ezio Mauro - ricordando come il risultato del lavoro di Scalfari sia stata “una concezione del giornale che va ben al di là della fotografia della giornata per puntare alla ricostruzione del mondo, all’invenzione del contesto, all’intelligenza degli avvenimenti, alla comprensione dei fenomeni. Cioè la creazione di una vera e propria macchina della conoscenza: capace di aiutare il lettore a partecipare e a capire, dunque a diventare un cittadino consapevole, proprio perché informato”. Al netto della comprensibile enfasi dovuta al momento, Mauro coglie il punto centrale: Scalfari a metà degli anni Settanta colse prima di tutti come la carta stampata dovesse rassegnarsi alla maggiore velocità della Tv e puntare, quindi, sull’approfondimento, su quella che poi sarebbe stata chiamata tematizzazione; casomai a discapito della completezza. I più giovani faranno fatica a ritrovarsi in queste parole, perché ci riferiamo alla prima “Repubblica”, che “inventò” lo sfoglio, collocando a inizio giornale 3-4 fatti rilevanti, ma descritti e analizzati più approfonditamente e da varie prospettive, convocando anche soggetti sociali – i sindacati, i movimenti (particolarmente forti in quel periodo) - fino ad allora molto meno presenti. Meno interessato a occuparsi di tutto, ma teso a trattare eventi e fenomeni sociali diversamente; glissando completamente sulla cronaca e sullo sport. Ovviamente, in questa sua intuizione Scalfari fu aiutato dalla provenienza dal mondo dei settimanali, dove già aveva vissuto questa esigenza per la rivalità con i quotidiani. Una tensione innovativa che poi è riuscito a mantenere negli anni, anche quando il fulmineo successo costrinse “la Repubblica”a diventare un contenitore maggiormente onnicomprensivo.
Scalfari fece ben presto de “la Repubblica” un brand, che è molto più di una testata, perché contiene una dimensione simbolica, una dichiarazione d’appartenenza, un legame affettivo
Se si passa allo Scalfari editore, si scopre un giornalista ben consapevole, prima che in Italia diventasse evidente, come la libertà possa essere data soltanto dai conti in ordine. Una maniacale quanto sacrosanta attenzione a questi aspetti, in un periodo in cui la stampa continuava a essere per gli editori “impuri” dell’epoca una voce passiva di ben altri attivi di missiroliana memoria, facilitata dall’aspetto prima ricordato di aver creato un giornale-stile di vita. Scalfari ha fatto ben presto de “la Repubblica” un brand, che è molto più di una testata, perché contiene una dimensione simbolica, una dichiarazione d’appartenenza, un legame affettivo.
Paradossalmente, proprio questo inesorabile e implacabile successo ha costituito il lentissimo ridimensionamento della creatura scalfariana, che – arrivata a livelli di vendita inimmaginabili – si è dovuta trasformare in una testata omnibus, comunque diversa da tutte le altre, ma che proprio come tutte le altre inglobava un po’ tutto: l’alto e il basso, le dotte articolesse di Citati accanto all’introduzione dello sport e delle pagine locali. Fino ad arrivare a una dimensione industriale che non poteva restare nelle sole - seppur solidissime - mani del suo inventore.
Ma la creatura, crescendo a dismisura, non poteva mantenere quelle promesse identitarie dei primi anni, perché costretta a diventare troppe cose, un patchwork molto ben confezionato, ma comunque un’altra cosa
Per carità, Scalfari è riuscito a restare l’anima del giornale anche quando ha ceduto la direzione a Ezio Mauro; ma la sua creatura, crescendo a dismisura, non poteva mantenere quelle promesse identitarie dei primi anni, perché costretta a diventare troppe cose, un patchwork molto ben confezionato, ma comunque un’altra cosa. È dunque partito da lontano l’allontanamento del giornale dal suo inventore; più evidente, poi, con il recente cambio di proprietà e l’ingresso dei parenti più noti del suo sodale co-editore Carlo Caracciolo. Probabilmente si spiegano anche così le attuali maggiori difficoltà del quotidiano, rispetto agli affanni che la contingenza storica sta riservando a tutte le testate. Nei passaggi proprietari compiutisi, così come nei cambi di direzione, soprattutto dopo la ventennale conduzione di Mauro, l’impronta scalfariana è restata come imprinting di una generazione, come “spirito di un tempo”, ma naturalmente non ha potuto più rinnovarsi.
Il terzo motivo è rappresentato da un vero e proprio cambio di prospettiva nel presentare la società italiana. Un giornalista formatosi a “la Repubblica” e scomparso da poco – Paolo Mauri – nell’inedito pubblicato in questi giorni ricorda come la spesso rievocata abolizione della terza pagina decisa da Scalfari sia attribuibile alla volontà di far un giornale “che fosse culturale in tutto, nel trattare la politica e l’economia, la cronaca e naturalmente lo spettacolo”. Non so se Scalfari capì prima di altri che l’Italia era entrata nella modernità post-materialistica, quella scopertasi tale con il successo dei referendum sul divorzio e sull’aborto, ma sicuramente è stato il primo a tradurre quest’evoluzione in un’operazione culturale probabilmente irripetibile: far nascere un quotidiano dal niente e portarlo a diventare il più diffuso in Italia nel giro di pochissimi anni. Ciò vuol dire riuscire a leggere la società ed entrare in sintonia con essa, o almeno con una sua parte. Non soltanto, ma riuscire a guidare questo processo definendo un clima culturale e facendolo durare a lungo.
Dunque, molto di più di un giornale-partito quanto piuttosto una guida capace di leggere le principali tendenze sociali e, talvolta, inventarle. Una sintonia possibile anche per la capacità di fondere tre differenti anime nella redazione: un manipolo di giornalisti molto sintonici fra loro, integrato dai giovani della generazione postsessantottina e da tante donne. Oggi può sembrare banale, ma a “la Repubblica” le donne rappresentavano già alla fine degli anni Settanta il 25% della redazione quando negli altri giornali si contavano sulle dita di una mano. Una miscela che rendeva molto più semplice leggere e interpretare il cambiamento prima e meglio degli altri.
Non a caso, come si ricorda spesso, la carta stampata negli anni Ottanta è stata costretta a seguire il quotidiano romano. Basti pensare come un giornalista cresciuto sotto l’ala scalfariana – Paolo Mieli – sia stato il direttore della trasformazione dapprima de “La Stampa” e poi del “Corriere della Sera”.
Un successo con anche aspetti discutibili. Il principale è la ribadita e rivendicata impossibilità e inutilità di separare i fatti dalle opinioni, che ormai è diventato un must del giornalismo italiano. Una banalità sull’impossibile perseguimento dell’obiettività che, dietro il paravento di una verità filosofica, giustifica il giornalismo arrembante, libertino e un po’ guascone di Scalfari, lontano dal rigore di altri giornalismi occidentali, consapevoli di come oggettiva non possa essere la descrizione dei fatti, ma debba essere il metodo di lavoro del giornalismo. Un malinteso alla base del lento scivolare del giornalismo-guascone in un’informazione cinicamente e faziosamente piratesca, sempre più diffusa negli ultimi anni nel nostro Paese, quanto più la passione politica e la visione culturale hanno ceduto il posto alle esigenze del mercato e a una affannosa e scombinata concorrenza con i social.
Se si giudicasse Scalfari soltanto dal suo rapporto con la politica si cadrebbe in un doppio equivoco e, soprattutto, non gli si renderebbe giustizia
Insomma, se si giudicasse Scalfari soltanto dal suo rapporto con la politica si cadrebbe in un doppio equivoco e, soprattutto, non gli si renderebbe giustizia. Il primo equivoco sarebbe confinarlo nel campo del cosiddetto parallelismo fra giornalismo e politica, che da sempre ha caratterizzato il giudizio sull’informazione italiana; mentre Scalfari, per tutto ciò che abbiamo fin qui detto, è stato uno dei principali protagonisti di un parziale affrancamento del giornalismo italiano dalla politica attraverso l’indipendenza economica e la capacità di descrivere e per certi versi forgiare una società a cui la politica si è dovuta adattare, con tutti gli affanni che sempre più constatiamo. Il secondo equivoco consisterebbe nel dover ammettere un fallimento. Non solo e non tanto perché sono state molto spesso frustrate le sue proposte politiche, fino a creare la maldicenza di uno Scalfari-bacio della morte; ma soprattutto perché quelle riforme richiamate nel ricordo del suo predecessore anche dal direttore Molinari in Italia ancora le aspettiamo.
A proposito è emblematico che Scalfari sia scomparso in una data così evocativa per la sua amata Francia, il 14 luglio, ma anche nel giorno dell’ennesima dimostrazione d’impotenza della politica italiana. Una perfetta metafora per un grande italiano guidato sempre dall’ottimismo del suo frenetico attivismo – bisogna morire desiderando pare dicesse negli ultimi tempi - temperato dallo scetticismo (più che dal pessimismo) di chi ha sicuramente allargato e reso più popolare il suo iniziale riferimento azionista, elitario e minoritario, ma sapendo bene di quanto dura fosse la partita.

Riproduzione riservata