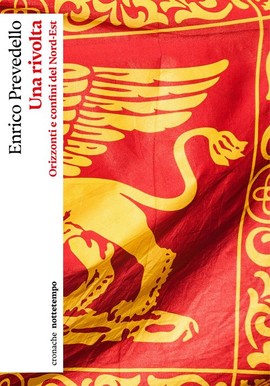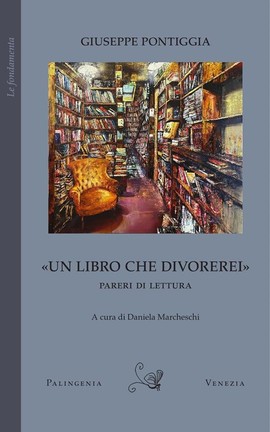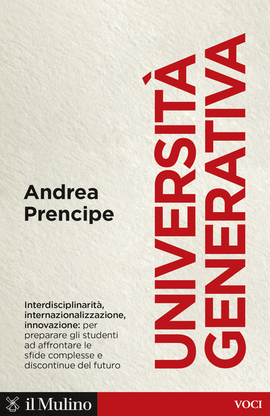Tanti anni fa, io e un mio compagno di università chiedemmo a un nostro professore il numero di telefono di Sebastiano Timpanaro (non c’erano ancora le e-mail, o si cominciava appena: si scrivevano lettere o si telefonava), perché eravamo suoi lettori e ammiratori, e volevamo andare a trovarlo a Firenze. Né io né il mio amico studiavamo le “sue cose”, nessuno dei due era un filologo classico (e mi pare di ricordare che Timpanaro al principio fosse un po’ sospettoso circa questa ammirazione imprecisata), ma il fatto è che le “cose” di Timpanaro erano parecchie, dalla storia della lingua latina alla teoria filologica, da Leopardi a Freud, alla storia della letteratura e del pensiero moderno (io avevo letto con stupefatta ammirazione la sua introduzione al Buon senso di d’Holbach nei Grandi Libri Garzanti: ancora adesso la do da leggere agli studenti perché capiscano come si fa); e insomma trovammo il modo di convincerlo del fatto che chiacchierare con lui ci sarebbe stato utile, e lui ci accolse con molta cortesia e parlò e ci fece parlare per un bel pezzo di pomeriggio.
Davvero utile forse non fu, alla fine – e che cosa mai è immediatamente utile, del resto? Quanto a me (il mio amico era più maturo), conoscevo troppo poco le discipline e gli argomenti che Timpanaro conosceva alla perfezione. Oltre al d’Holbach, avevo letto il libro sulla filologia di Leopardi e quello sul metodo lachmanniano, e qualcuno dei saggi sull’Ottocento stampati da un piccolo editore pisano, Nistri Lischi; altro avrei letto dopo, ma dei suoi studi di classicista non sapevo niente, e niente so adesso.
A parte la gentilezza e la modestia non simulata, mi sono rimasti nella memoria un paio di dettagli bizzarri e forse divertenti. Dato che studiavo letteratura del Medioevo cadde nel discorso il nome di Contini, che Timpanaro naturalmente conosceva e ammirava ma che come studioso era quanto di più lontano da lui si potesse immaginare. Nella scrittura, poi! Timpanaro era un saggista eccellente, e aveva lo stile cristallino che può permettersi solo chi padroneggia alla perfezione un argomento. Invece Contini… “Il cartellino alla cui ombra alberga il presente esercizio…”. È l’inizio dei celebri Preliminari sulla lingua del Petrarca. Dopo averlo citato a memoria Timpanaro commentò, un po’ scherzando un po’ no: “Ma scusate, ma i cartellini non fanno ombra, no? Che ombra volete che faccia un cartellino… E perché questo verbo, albergare: un esercizio che alberga?”. No, non era proprio il suo stile.
L’altra cosa che ci fece sorridere fu la sua – come definirla – visione insieme agonistica e democratica della discussione in ambito culturale. Scorrendo col dito i volumi di un’oscura rivista storica, ci raccontò di aver avuto una polemica molto accesa con uno degli altrettanto oscuri collaboratori della rivista, polemica che si era stesa in articoli e controarticoli ma che si era conclusa con un incontro chiarificatore, una stretta di mano, vera cordialità. “O gran bontà dei cavalieri antiqui!”, ci eravamo detti io e il mio amico uscendo. Però, ti pare che Sebastiano Timpanaro si mette a polemizzare con Pinco Pallino? Uno si domanda come avrebbe vissuto, uno spirito combattivo come il suo, nella conversazione ininterrotta che si è imposta tutti i giorni sui social network. Post chilometrici su Facebook? Un suo canale YouTube dedicato al debunking di “antileopardiani e neomoderati”, come suona il titolo di uno dei suoi libri sull’Ottocento?
Scherzi a parte, questo genere di considerazioni – non sugli studi di Timpanaro ma sul modo in cui pensava che la vita intellettuale dovesse essere vissuta – viene da fare leggendo questo libro magnifico, pubblicato qualche mese fa (S. Timpanaro, Ritratti di filologi, Aragno, 2023), che per la cura di Raffaele Ruggiero raccoglie appunto i profili o i tombeaux che nell’arco di una trentina d’anni Timpanaro ha dedicato a insigni filologi classici del XX secolo di cui è stato ammiratore o amico, e precisamente: Giorgio Pasquali, Nicola Terzaghi, Scevola Mariotti, Franco Munari, Giuseppe Pacella, noto soprattutto per essere il curatore dell’edizione critica dello Zibaldone leopardiano, ma classicista di formazione; in più, in apertura di volume, un celebre saggio su Graziadio Ascoli, l’unico non novecentista e non filologo.
Quanto alla scrittura, questi saggi mi pare confermino che l’eleganza e l’energia di Timpanaro non hanno quasi paragoni tra gli studiosi italiani del Novecento. Credo sia stato Montaigne a dire che la scrittura migliore è quella che ha la naturalezza della conversazione, cioè che sembra direttamente “presa dal parlato” (s’intende, dal parlato di chi sa parlare, ma senza affettazione). Ebbene, leggere Timpanaro vuol dire fare esperienza di questo stile, che al lettore di oggi suona forse più anglosassone che italiano (Orwell, Berlin), perché intimamente antiretorico, ma che degli anglosassoni non ha certamente la flemma: lui era sempre diretto, impaziente e quasi sempre tranchant non solo nei suoi scritti filosofici e politici ma anche nell’esercizio delle sue funzioni di filologo classico, dove quello che nel costume accademico si chiama “dialogo con la bibliografia” prendeva spesso i tratti di una battaglia. Timpanaro prendeva terribilmente sul serio le idee e le parole, le sue e quelle degli altri. E, immune da pregiudizi universitari, non conosceva gerarchie: per questo poteva azzuffarsi con oscuri redattori di oscure riviste di storia locale.
Questa attitudine emerge in maniera commovente nel più bello dei ritratti contenuti in questo libro, quello dedicato a Pacella:
“Un pomeriggio di un anno che non saprei più indicare esattamente – scrive Timpanaro – ma che senza dubbio era posteriore, forse di poco, al 1955 e anteriore al 1959, si presentò a casa mia […] un signore di aspetto e pronuncia leggermente meridionali, di età che non seppi definire. Ora so che, essendo nato a Casarano, in provincia di Lecce, il 5 maggio 1920, non aveva ancora quarant’anni, come non li avevo io, nato nel 1923. Allora mi parve un po’ più anziano; ma nei decenni successivi mantenne sempre lo stesso aspetto, e finì col sembrare più giovane di quanto era”.
Uno studente attempato, decisamente fuori corso, che dichiara di voler fare una tesi su Leopardi, e all’offerta di Timpanaro di lavorare insieme su Leopardi filologo risponde che no, lui vuole solo laurearsi in fretta. Commento di Timpanaro: “L’incontro, per me, perdeva d’interesse. Gli diedi qualche indicazione generica, gli prestai il mio libro su La filologia di Giacomo Leopardi che era uscito nel ’55 e di cui, nonostante la fatica che mi era costato, sentivo la provvisorietà”. Pacella si accomiata “gentilmente e timidamente”, ma ricompare poco tempo dopo. Non solo ha letto il libro di Timpanaro e tutta la bibliografia connessa, ma vi ha trovato degli errori: problemi su cui “il Cugnoni, il Piergili, il Mestica, il Flora, e anch’io che, filologo classico, avrei dovuto mostrarmi più avveduto di quegli italianisti benemeriti ma non molto filologi – tutti avevamo errato!”.
Ecco, a stringerlo in poche righe, ciò che rende caratteristico l’approccio di Timpanaro ai problemi della cultura. Negli ambiti di studio che erano i suoi, si ha l’impressione che Timpanaro non solo avesse letto tutto ma leggesse tutto, cioè continuasse ad aggiornarsi a un ritmo indiavolato anche dopo gli anni della formazione. Leggendolo, si ha un’impressione che capita di avere di rado quando si leggono gli studiosi contemporanei, anche i più rigorosi. Da un lato, un fortissimo senso di continuità rispetto alla tradizione degli studi, ossia la familiarità con i libri scritti da chi si è occupato delle questioni sul tappeto si può dire sin dal Rinascimento, ma soprattutto con la bibliografia ottocentesca, italiana e tedesca in ispecie. Dall’altro lato, la fiducia nel lavoro comune entro il perimetro di una determinata disciplina: forse anche perché la comunità scientifica aveva allora confini più stretti (meno riviste, meno libri, meno atti congressuali, insomma meno bibliografia), è come se ci si trovasse seduti in un’aula – ampia ma non amplissima – nella quale venissero via via convocati, oltre ai grandi studiosi del passato, letti nelle lingue in cui si erano espressi (le lingue di cultura europee, più il latino), oltre ai colleghi contemporanei, anche gli ultimi arrivati nel campo della ricerca, purché dotati di dedizione e di ingegno. A volte accadeva anzi che questa attitudine egualitaria gli prendesse la mano e che, anche in mancanza dell’ingegno, la dedizione gli sembrasse sufficiente. Come mi ha detto una volta un suo amico, Timpanaro era un po’ troppo generoso nel distribuire medaglie a oscuri studiosi che avrebbero meritato di restare nell’oscurità. E molti frequentatori della biblioteca di filologia classica, all’Università di Firenze, ricordano ancora la sua affabilità, la facilità con cui anche l’ultima delle matricole poteva sottoporgli problemi, idee, anche al limite della molestia.
Negli ambiti di studio che erano i suoi, si ha l’impressione che Timpanaro non solo avesse letto tutto ma leggesse tutto, cioè continuasse ad aggiornarsi a un ritmo indiavolato anche dopo gli anni della formazione
Questi Ritratti di filologi sono usciti tra il 1965 e il 1996 su “Belfagor”, che è stata una delle più intelligenti riviste culturali italiane del secondo Novecento. I pezzi furono concordati con il suo direttore, il grecista Carlo Ferdinando Russo. Nella premessa al volume, l’amicizia tra i due viene ricostruita da Raffaele Ruggiero attraverso il loro carteggio, dal dicembre del 1952 alla fine degli anni Novanta. È un saggio molto bello, che restituisce non soltanto il profilo e il carattere di questi due studiosi ma anche un segmento significativo della cultura italiana di quei decenni, sia perché a “Belfagor” collaborarono persone di intelligenza e cultura fuori del comune, che provenivano da aree diverse del sapere accademico, sia perché era l’epoca (ed erano gli uomini) delle lettere intese come micro-trattato, e certi brani citati da Ruggiero potrebbero benissimo essere stralci da recensioni o saggi accademici.
Per queste sue caratteristiche, si tratta dunque di un libro che è sin troppo facile prendere come simbolo. Di che cosa? Innanzitutto, com’è ovvio, di ciò che può essere la ricerca in campo umanistico (ma non credo che Timpanaro avrebbe gradito che la parola “ricerca” prendesse il posto della parola “studio”) quando a farla è uno studioso così dotto, intelligente e rigoroso; nonché, ripeto, dotato di quella chiarezza che è in fondo un altro nome della dirittura morale. In chi possiede o crede di possedere un sapere esoterico si avverte infatti quasi sempre il desiderio di comunicarlo esotericamente (era la ragione per cui Timpanaro s’irritava davanti alle pagine di Contini, e qui, in una nota, ho ritrovato con divertimento l’eco delle confidenze che aveva fatto a me e al mio amico tanti anni fa: l’amicizia di Contini per il filologo Walter Ferrari “gli fece scrivere lettere angosciate e desiderose, fino all’ultimo, di far qualcosa per la sua salute: lettere, una volta tanto, prive di quelle civetterie linguistiche che mi sono sempre parse intollerabili in uno studioso pur insigne come Contini e che sono state ereditate da parecchi suoi allievi, non da tutti”); invece in Timpanaro c’è sempre il desiderio di sciogliere con parole semplici e nette le questioni più ingarbugliate, e in questo senso la lezione che al lettore comune viene dal libro non è una lezione di sostanza (chi, se non una manciata di specialisti, può orientarsi nella tradizione degli Inni di Sinesio, o tra gli scolii dei grammatici d’età imperiale?) bensì di metodo, e più ampiamente ancora di atteggiamento di fronte ai fatti della cultura accademica: occorre la più larga informazione sui testi e sul lavoro che i filologi, anche i più remoti nel tempo, hanno fatto su quei testi; e occorre spiegare nel modo più trasparente possibile le questioni via via prese in esame, e la propria posizione in relazione alle tesi degli altri studiosi. Posizione che – il lettore di Timpanaro lo sa bene – viene argomentata sempre con una sincerità che a volte può suonare brutale; per esempio:
“La nuova edizione [ovidiana] di Kenney ha introdotto nel testo molte belle congetture, soprattutto sue e di George P. Goold, alcune delle quali potevano meglio essere menzionate con un fortasse nell’apparato; e ha soppresso quasi tutte le motivazioni delle sue scelte testuali, già ridotte a causa delle norme della Bibliotheca Oxoniensis. In complesso, la nuova edizione è indubbiamente superiore alla precedente, ma non in tutto. Se questo parere è errato, mi si corregga”.
Astenersi dal giudizio, su argomenti che conosceva, per lui non era mai un’opzione.
Metodo più che sostanza, dicevo, almeno per chi non professi la filologia classica. Ma questo non significa che dalle pagine di questo libro non si possano dedurre indicazioni molto concrete circa ciò che Timpanaro pensava degli studi letterari, e di come andassero condotti. Per una parte, queste indicazioni si trovano nel saggio introduttivo di Ruggiero, il quale scrive per esempio, commentando una lettera in cui Timpanaro comunica a Russo i suoi dubbi a proposito di una breve apologia di Feyerabend pubblicata su “Belfagor” da Giulio Giorello: “Il giudizio severo sulla noterella di Giorello – scrive Ruggiero – condensa tutta la battaglia culturale di Timpanaro e in gran parte la battaglia di ‘Belfagor’ nell’opporsi alle derive irrazionalistiche che hanno segnato il dibattito intellettuale alla fine del XX secolo […]. C’è un’evidente continuità e coerenza nel censurare le spiegazioni, tutte irrazionalistiche, dei lapsus proposte da Freud e nel manifestare dissenso e preoccupazione per l’epistemologico arrendersi del pensiero debole” (devoto dell’illuminismo laico e – secondo la sua ottica – progressivo, Timpanaro diffidava delle “discese nel profondo” condotte con metodi e strumenti che non possano essere sottoposti a verifica razionale, laboratoriale: di qui tra l’altro il suo grande libro su Il lapsus freudiano. Ma mentre non dubitava della grandezza di Freud, trovava nefasta “l’ondata di ciarlatanesimo, per di più oscurantista” che gli pareva avere invaso le scienze storico-sociali attorno alla metà del Novecento).
Per un’altra parte, queste indicazioni su “che fare” nel mestiere dello studioso si possono raccogliere nel corso del volume, quando la descrizione del carattere e dell’opera del filologo di cui Timpanaro sta facendo il ritratto gli offre l’occasione per digressioni come questa: “Oggi non più certamente, ma negli anni attorno al Sessantotto qualcuno avrà forse rimproverato alla critica e alla storia letteraria mariottiana una carenza di interesse per il nesso tra opera d’arte e ambiente politico-sociale. Certo tale interesse è stato più forte nel La Penna studioso di Orazio, di Properzio, specialmente di Sallustio. Ma […] esistono vari approcci all’opera letteraria, tutti validi purché non si dissolvano in vane genericità: nessuno potrà rimproverare Hermann per non essere stato Boeckh e viceversa […]. D’altra parte, vi furono negli anni sessantotteschi tentativi di ‘pan-politicizzazione’ del fatto artistico del tutto aberranti, contro i quali già gli stessi Marx ed Engels (e Labriola, e Trockij) avevano protestato” (è una delle ragioni per cui i saggi di Timpanaro restano corroboranti, anche quando non se ne condividano le tesi. Si professava “engelsiano”, e conosceva a menadito i classici del marxismo, e li adoperava per interpretare epoche e figure e testi che col marxismo non avevano rapporto diretto, ma nell’impiego di questa bibliografia filosofica non c’era nessuna civetteria, nessuno sfoggio: in generale, nessuna di quelle cattive qualità che, quando si leggono o rileggono i saggi degli “anni sessantotteschi”, lasciano spesso un’impressione di vanità se non di cialtroneria).
Dato che Timpanaro non credeva a celesti risarcimenti post mortem, voleva che almeno nella comunità degli studiosi restasse traccia di chi nei confronti di quella comunità aveva avuto dei meriti
Resta da ribadire che quelli qui raccolti non sono saggi sulla letteratura classica ma saggi sui filologi, ritratti appunto, che alle note biografiche intrecciano considerazioni puntuali sul lavoro di questi filologi (stavo per scrivere intrecciano inevitabilmente, ma in realtà no: in genere nei profili del genere non si entra quasi mai nel merito, perché farlo richiederebbe troppa fatica e troppo spazio per argomentare: Timpanaro entrava sempre nel merito, persino negli scritti “di servizio” come quelli raccolti nel volumetto Leopardi e altre voci – dove le voci sono voci di enciclopedia – pubblicato l’anno scorso da Giometti & Antonello). Perché tanta dedizione agli uomini, oltre che ai loro libri? La risposta più ovvia è che la storia della cultura è soprattutto storia di uomini, di studiosi, e che le biografie intellettuali degli individui, se si tratta di individui insigni, aiutano a comprendere i fatti e le opere che essi hanno cercato di interpretare. Ma in Timpanaro si avverte soprattutto un bisogno di memoria che è anche bisogno di umana giustizia; dato che non credeva a celesti risarcimenti post mortem, voleva che almeno nella comunità degli studiosi restasse traccia di chi nei confronti di quella comunità aveva avuto dei meriti. La parola molto abusata pietas qui torna forse pertinente. Ecco esplicitata, in una lettera a Russo del maggio 1995, la ragione per cui ha voluto scrivere di Pacella: “Ho preferito scrivere intanto questo (profittando di un breve periodo di minore nevrosi) perché Pacella è stato uno studioso intelligentissimo ma ‘irregolare’, e rischia di essere dimenticato, o ricordato fuggevolmente come editore dello Zibaldone”. Ed ecco come comincia il profilo di Munari:
“Se prendo la penna per Franco Munari, non è soltanto per l’amicizia fraterna che a lui mi ha unito per una vita intera, ma perché temo che la scomparsa di questo filologo tra i nostri migliori e di quest’uomo così schietto, così amante della verità negli studi e nella vita, così alieno da ogni intrigo e da ogni megalomania accademica, non susciti, specialmente in Italia […], quel desiderio di studiarne le opere e il metodo di lavoro che a me sembra doveroso e che finora è stato, a mio avviso, troppo scarso”.
Non sorprende, dunque, che Timpanaro fosse particolarmente sensibile al genere, e nella bibliografia dei colleghi apprezzasse molto questo tipo di esercizi:
“Di molti amici scomparsi il Mariotti ha scritto ricordi lucidi e commossi, ne ha tracciato sia pur brevemente la biografia umana e intellettuale. Non li menzionerò tutti; dirò che, a mio parere, il ricordo più bello e più acuto da lui scritto è quello dell’amico pesarese Marcello Zicàri […]. Ma si legge con commozione anche il breve ricordo di Italo Zicàri, che scrisse meno del fratello, ma fu anch’egli uomo di alto ingegno…”.
Non si possono leggere queste pagine senza provare, insieme all’ammirazione, un certo senso di colpa, perché ben poco di ciò che abbiamo scritto, forse niente, reggerebbe al paragone. E da questa considerazione personale, relativa ai propri personali limiti, ne discende un’altra altrettanto amara sullo spirito dei tempi – i nostri, non i suoi. A proposito di Timpanaro e del gruppo di “Belfagor” Ruggiero parla senz’altro della “difesa, giocata con l’estro dell’intelligenza, di una cultura non soltanto al tramonto, ma purtroppo sul punto di estinguersi insieme ai valori che l’avevano generata”. La cultura “al tramonto” è, per Ruggiero, quella universitaria per come la concepivano studiosi come Timpanaro e Russo; e più precisamente quella classicistica, per come veniva trasmessa nei licei e nelle università: quella “comunità” della quale Timpanaro – che pure non insegnò mai all’università – e i suoi maestri e colleghi sono stati parte. È davvero così?
In linea di principio, non c’è ragione di pensare che nelle università non si formino o possano formarsi, in futuro, intelligenze come quelle di Timpanaro (o degli altri grandi studiosi di appena ieri che questo libro convoca: Eduard Fraenkel, Mariotti, La Penna, Campana): non mancano i giovani bravi che nel contesto giusto possono diventare bravissimi, o dei fuoriclasse. Ma da un lato è la struttura, il meccanismo stesso dell’università contemporanea a rendere arduo, e persino indesiderabile, questo genere di formazione. Per sperare di fare carriera occorre specializzarsi presto, scegliere una disciplina (chi riuscirà ormai a padroneggiare insieme latino e greco?), scegliere un tema di ricerca, e su quello passare anni, e pubblicare tanto e presto, e far valere la propria micro-competenza nei congressi, nei gruppi di ricerca: e s’intende che l’estrema specializzazione è nemica non solo di quella latitudine d’interessi ma anche di quella – ripeto la parola – intelligenza di cui l’opera di Timpanaro è testimonianza.
Dall’altro lato, questo malessere, che tocca tutte le discipline universitarie non applicative, le scientifiche non escluse, investe con particolare forza le materie del curriculum classico, che richiedono un lungo apprendistato linguistico e filologico. Anni fa è uscito su una rivista scientifica un articoletto dello storico della filosofia antica Jonathan Barnes che s’intitolava Bagpipe Music, e che lamentava appunto questa crisi. L’abstract suonava così: “La filosofia antica è messa male. Come tutte le altre discipline accademiche, patisce l’abbraccio della burocrazia. Come altre parti della filosofia, soffre il contagio di mode sciocche. In più soffre terribilmente il declino della filologia classica. Non ci sono cure per questa malattia”. Si sa, il compianto sulla crisi delle humanities è antico quanto le humanities; ma non è, credo, solo di Barnes o di Ruggiero o mia l’impressione che qualcosa, negli ultimi decenni, non sia soltanto cambiato ma sia caduto, come cade il testimone della staffetta: e basta pensare – se non a quella cosa immateriale che è il prestigio culturale – al numero sempre più esiguo di iscritti ai corsi di laurea in Lettere classiche.
Infine, legato a quest’ultimo problema, c’è da riflettere su tutto ciò che di non-filologico s’impara leggendo il filologo Timpanaro. Sin da giovane – scrive da qualche parte – aveva nutrito una grande passione per la filosofia: “passione non ricambiata”, aggiungeva ironicamente. Ma non è vero. Da quasi tutte le sue pagine, e in particolare da quelle dedicate alla cultura e agli scrittori del Settecento e dell’Ottocento, traspaiono una padronanza della storia delle idee e una capacità di situare sé stesso in relazione a quella storia che non mi pare abbiano paragoni tra i letterati italiani dello scorso secolo, men che meno tra i filologi. Anche per questo egli è stato probabilmente, come ha scritto Alfredo Stussi, “la più singolare figura di intellettuale italiano del secondo Novecento”. Singolare anche nella sua irripetibilità, se vale quanto ho detto sopra circa il modo in cui è mutata, intorno a noi, l’aria del tempo – e speriamo non valga (ma nell’attesa non sarebbe male se qualche grande o medio editore trovasse il coraggio di ristampare almeno alcuni dei suoi libri: se c’è un saggista degno dei Meridiani, per dire, è chiaramente lui).

Riproduzione riservata