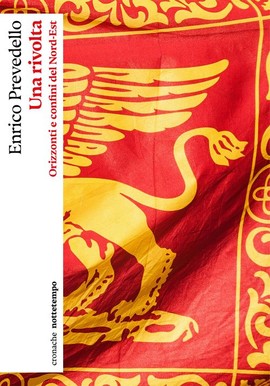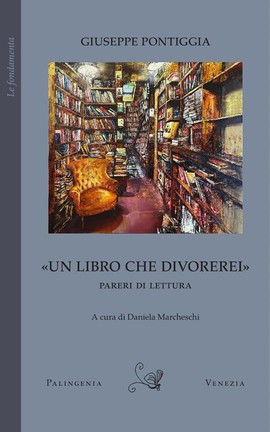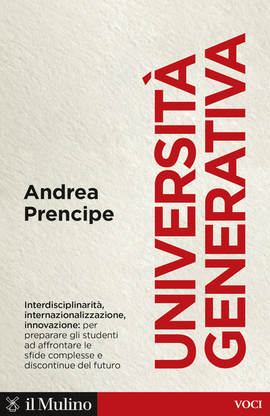Sono vicende grandi ma non sempre note quelle narrate, anche dando voce ai protagonisti, da Gabriele Polo e Giovanna Boursier in Lavorare manca. La crisi vista dal basso (Einaudi, 2014). Un libro che risulta forte senza che, da parte degli autori, vi sia bisogno di ricorrere ad alcun tipo di drammatizzazione. I drammi sono lì, individuali e collettivi, pronti all'uso, componenti sempre meno marginali della storia industriale italiana.
Dall'apice della crescita industriale negli anni Sessanta alla crisi che, in certi comparti, già si mostra in tutta la sua complessità e durezza sin dalla metà dei Settanta, la vicenda industriale italiana emerge in tutte le sue contraddizioni. Frutto della rivoluzionaria riscrittura degli stessi parametri di riferimento, dovuta al confronto sul mercato del lavoro globale, la crisi che emerge dalle vicende riprese da Polo e Boursier si mostra anche nell'incapacità dei dirigenti e soprattutto dei proprietari, sempre e comunque “padroni”, che non sanno e non vogliono individuare vie diverse da quelle note, né ricorrere al confronto aperto e franco con chi in azienda lavora da decenni. C'è dunque una gran parte delle ragioni che hanno portato l'Italia alla carenza cronica di lavoro documentata anche pochi giorni fa dagli ultimi dati sull'occupazione, complessiva e giovanile in particolare (e va notato come le percentuali della disoccupazione giovanile riportate, già impressionanti quando il libro uscì un anno fa, siano state superate di slancio: il dato medio è ormai al 43% ). La ricerca del profitto prima di tutto, anche ricorrendo a smantellamenti a tappe forzate, senza la ricerca di riconversioni possibili. La complicità della politica, anche a livello locale, che spesso vede profilarsi, nello smantellamento di distretti industriali nuovi, significativi ricavi dal cambio di destinazione delle aree in residenziali e commerciali. E poi questioni e ambiti che toccano non solo la grande e la media industria ma molti comparti del nostro mercato del lavoro. I nuovi manager che non sanno nulla dell'azienda e che non considerano il sapere degli operai non sono certo caratteristici di una o due imprese fra tante.
Le storie raccontate insegnano molto, anche grazie alla scelta di dare voce direttamente ai lavoratori coinvolti. Lo scenario di storia industriale in cui viene collocata la vicenda delle singole aziende è fondamentale per comprenderne meglio le peculiarità.
Era il 1940 quando Benito Mussolini inaugurò a Faenza la Orsi Mangelli Società Anonima. Settant'anni dopo, il 10 agosto 2010, la Omsa, che dalla Orsi derivava, chiude, salvo poi riaprire a Valijevo, Serbia centrale, dove lo Stato finanzia il lavoro con molto denaro: “La motivazione ufficiale del trasloco ricalca i cahiers de doléances con cui gli imprenditori italiani giustificano ormai tutto, anche la propria inconsistenza: crisi del mercato, tasse e costo del lavoro troppo alti, Paese assente nel sostegno all'impresa” (p. 113).
La storia dell'Omsa è emblematica e nelle parole delle operaie c'è quasi più tristezza che disperazione. Come emblematiche del resto sono la vicenda Innocenti e il suo ultimo atto andato in scena sulla piattaforma di una gru alta 18 metri, o il quadro tratteggiato dei cantieri navali di Monfalcone e dei suoi “cantierini” (“li uccise la polvere, li tradì il profitto”, recita una lapide) e delle logiche senza vincoli di alcun tipo che stanno dietro il reclutamento della forza lavoro, solo per citare altri due degli otto capitoli di cui il libro si compone. Scene di un mondo in decomposizione, dove gli operai appaiono come “un residuo ostinato, duro come il ferro e l'acciaio delle loro grandi macchine fresatrici, torni, gru, dentatrici e rettifiche. Pesanti tonnellate, gigantesche” (p. 5).
Un mondo dove il conflitto, piuttosto che la collaborazione tra capitale e lavoro, ancora oggi domina la scena. Recente la notizia, tra le tante, dello stabilimento che produce capi spalla di alta gamma per il gruppo Zegna. La proprietà vuole chiudere lo stabilimento alle porte di Padova per trasferire tutto a quattrocento chilometri, Novara o Biella non si sa ancora. Come se per le 230 operaie, sarte qualificate che operano in un settore ad altissima professionalità, fosse semplice trasferire armi e bagagli a quattrocento chilometri dalle proprie famiglie di appartenenza. Mentre in Parlamento è stata depositata un’interrogazione urgente da due senatori Pd, tra i sindacati c'è chi prefigura uno scenario inquietante ma purtroppo non del tutto privo di credibilità. Il timore è che si tratti di una scelta speculativa, non di tipo industriale. Nella nuova sede l'azienda si troverebbe “costretta” a ricorrere a nuove assunzioni. E in questo caso, secondo i sindacati, si gioverebbe delle decontribuzioni previste dal Jobs Act, grazie alle quali “potrebbe guadagnare sino a cinque milioni di euro”, oltre alle minori tutele previste per i nuovi assunti.
È un altro capitolo della stessa storia. Che la scarsità di occupazione e l'efficace “lavorare manca” di pavesiana memoria che dà il titolo a questo libro possono, però, spiegare solo in parte.

Riproduzione riservata