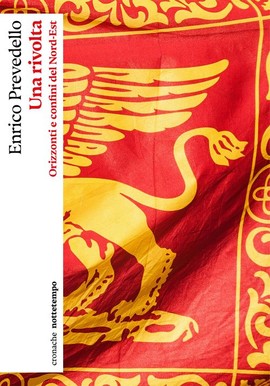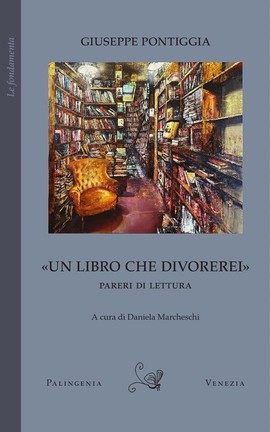Racconta Marco Revelli nel suo viaggio eretico nell’Italia che cambia (Non ti riconosco, Einaudi, 2016) di quando si trova ad attraversare, verso i territori del «Far East», la cosiddetta «BreBeMi», la nuova autostrada ignorata da chi deve spostarsi in quei sessanta chilometri di Lombardia da Ovest a Est e viceversa (8.000 veicoli transitati nel 2016 contro i 60.000 previsti a regime dal progetto dell’opera). Il project financing anche in questo caso non ha funzionato, e i pedaggi sono talmente alti da rendere preferibile nonostante il traffico la vecchia A4. Ma la costruzione di questa «lama di asfalto», che ha tagliato «come un coltello una delle aree agricole più belle, e più ricche, del Nord» non è stata del tutto inutile. L’autostrada ha fatto da cava per lo sversamento di un volume impressionante di rifiuti non trattati: polveri di fonderia, amianto, plastiche. Scorie industriali altamente tossiche: i carotaggi effettuati dai tecnici dell’Arpa di Brescia hanno riscontrato in falda concentrazioni di cromo esavalente sino a 1.400 volte oltre i limiti di legge (per la falda il limite è di 5 microgrammi/litro). «In un caso come questo si può dire senz’altro che un’opera pubblica è stata costruita in buona parte con i rifiuti», ha dichiarato al «Corriere della Sera» il procuratore generale di Brescia Pier Luigi Maria Dell’Osso.

Quello ripreso da Revelli nel tratteggiare il nostro panorama postindustriale verso il Nordest tra case, chiese e capannoni è solo uno dei tanti casi di sconfitta del bene comune a vantaggio del capitale privato e della morte di migliaia di persone, con cui molti casi di inquinamento colposo si sono conclusi. Fra i tanti studi, un libro curato da Antonello Petrillo (Il silenzio della polvere, Mimesis, 2015) riporta il caso poco noto al grande pubblico di uno dei più grandi inquinamenti da amianto mai fatti in Europa, quello che si realizzò presso gli stabilimenti della Isochimica di Avellino nell’Irpinia del dopo terremoto. Una storia in una città di 60.000 abitanti che vide coinvolti circa 400 operai, cui venne affidato il compito, senza i minimi requisiti di sicurezza necessari, di procedere alla bonifica dall’amianto di carrozze delle Ferrovie dello Stato. L’ennesimo episodio di conflitto tra salute e lavoro: serve lavoro, lo si accetta a qualsiasi condizione, a costo di perdere la salute se non la vita stessa.
Come scrive lo stesso Petrillo nella sua introduzione, «l’Isochimica di Avellino avrebbe garantito quasi da sola il diritto al futuro degli italiani a viaggiare in sicurezza all’interno di carrozze prive di amianto: grazie a essa 1.740 vagoni e 499 locomotori potranno essere “scoibentati”». La storia, terribile, appare paradigmatica delle relazioni industriali nel Mezzogiorno tra arretratezze modernità. Ricorda Anna D’Ascenzio nel suo saggio, è «il capitalismo straccione che si impadronisce di risorse umane e materiale, senza vere cognizione del reale processo di ripartizione di tali risorse». Una vicenda ancora più tragica, se si pensa che l’occasione fu la «narrazione» del terremoto del 1980 come la «tragica, ma giusta, occasione per un intervento contro la miseria nel Mezzogiorno». Quale migliore panacea del lavoro ai mali della miseria? Fu proprio in Irpinia che in quegli anni le Ferrovie sperimentarono nuove forme di «flessibilià» lavorativa, avviando i primi processi di outsourcing. Quello tratteggiato nei diversi capitoli del libro fu uno dei primi casi di outsourcing da parte di un’azienda statale a una privata. Flessibilità, outsourcing: parole magiche, che quando non accompagnate da un progetto condiviso e da tutele adeguate da lì in avanti faranno molti danni all’economia e al lavoro.
Quello dell’Isochimica non è un caso isolato. Per limitarsi a Bologna, tutti o quasi dovrebbero conoscere l’«altra strage», vale a dire il dramma che ha coinvolto centinaia di lavoratori delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato, su un terreno oggi di proprietà di Trenitalia e in dismissione, esposti alle operazioni di bonifica dell’amianto con cui un tempo si isolavano le carrozze ferroviarie. E dire che lo Stato fin dal 1973 (d.m. 18/4/1973) ribadiva che l’esposizione all’amianto poteva provocare tumori (si consideri che fu negli anni Cinquanta che a Casale Monferrato cominciarono le malattie e le morti degli operai che lavoravano all’Eternit). Anche alle Officine Casaralta si lavorava senza alcuna protezione. Ci si occupava di coibentare e ristrutturare le carrozze ferroviarie. «Gli operai lavoravano nell’amianto. Non solo lo raschiavano dalle carrozze, ma lo impastavano. E d’amianto era rivestito il capannone». «L’azienda non ne parlava. Noi non sapevamo nulla». Solo intorno al 1990 emerse il problema. «Gli amici morivano di mesotelioma, io ho assistito fino all'ultimo Gianfranco. Piangeva come un bambino e tremava per il dolore. Mi chiedeva di aiutarlo». Sono le parole con cui Nando Cicchelli, in Casaralta dal settembre 1977 al 1988, ha raccontato la vicenda a Lettera43.
In tutti questi casi responsabilità pubbliche e private si intrecciano, ma spesso sono occorsi decenni per fare chiarezza giudiziaria e in alcuni casi ancora questa manca. A venticinque anni dalla messa al bando dell’amianto, è impossibile avere un’idea sufficientemente precisa del numero complessivo delle vittime, anche se alcune stime parlano di circa 4.000 decessi ogni anno per tutte le malattie correlate.
Le storie raccontate da chi prova a tenere viva l’attenzione sul tema, come fa da diversi punti di vista, non ultimi quello giudiziario e sociale, il libro curato da Petrillo, sono emblematiche, del rapporto alterato e gravido di conseguenze a volte terribili tra capitale e lavoro.
Le parole di Stefania, sorella di uno degli operai della Isochimica di Avellino, Giovanni, sono emblematiche:
«Giovanni è stato uno dei primi a protestare e anche uno dei più esposti, ha smesso di farlo quando è stato assunto come vigile urbano. Tu capisci… però non sta bene di salute, ma ha famiglia! Ha cominciato a lavorare all’Isochimica da giovanissimo, spinto dai genitori e dal parroco del quartiere. Aveva bisogno di un lavoro perché la fidanzatina era incinta. Il parroco, per dare una mano a questa giovane coppia, lo aveva raccomandata a un capo-stazione delle FFSS. Fu il barista della stazione – a cui aveva ordinato caffè e cornetto – a indicargli che il suo posto di lavoro era il binario morto della stazione ferroviaria di Avellino. Giovanni vide i suoi colleghi sul binario che grattavano amianto da vecchie carrozze. Nonostante l’angoscia per quanto visto, accettò il lavoro perché, come molti dei suoi colleghi, aveva creduto a quanto veniva raccontato e cioè che quel sacrificio di grattare amianto sarebbe servito a portare ad Avellino l’intera attività di progettazione e di manutenzione delle FFSS. E quindi molto lavoro».
Che si trattasse di una menzogna Giovanni e i suoi colleghi sopravvissuti lo scopriranno solo molto dopo. Nel frattempo, in soli cinque anni, 1.195.000 chilogrammi di amianto vennero depositati all’interno del perimetro della fabbrica e nei luoghi limitrofi.

Riproduzione riservata