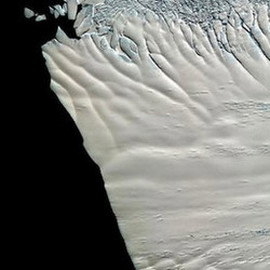Erano tanti, non meno di duemila, i delegati della Cgil che il tam-tam di un’estemporanea autoconvocazione ha radunato a Bologna, la mattina di sabato della scorsa settimana. Non spetta a me dire se la realizzazione dell’iniziativa abbia corrisposto alle aspettative dei promotori. Suppongo però che costoro sapessero le due o tre cose che il dibattito avrebbe messo in luce. La prima è che il gesto è di per sé significativo, perché testimonia che la ristrutturazione del sistema sindacale è troppo importante per lasciarne decidere finalità e modalità ai vertici confederali senza confronti né chiarimenti. Confronti e chiarimenti che, opportuni sempre, in questo caso erano più necessari che mai, se si considera che l’abnorme ritardo accumulato nella sedimentazione degli elementi di un sistema che i suoi principali attori per decenni si sono accontentati di tenere insieme con poco più che spago e chiodi non si concilia con l’ampiezza del non-detto che ha permesso ai rappresentanti confederali dei lavoratori di superare le laceranti tensioni di questi ultimi anni. Se si considera che i medesimi hanno riattivato unitariamente la risorsa dell’autonomia collettiva nel vivo della crisi di sistema aperta dalla contrattazione separata che disorienta tuttora moltitudini di rappresentati senza curarsi di esplicitare le ragioni né della contrapposizione né della ritrovata volontà di porvi fine. Se si considera che il male oscuro della quarta confederazione senza nome e senza bandiera che ha governato le relazioni sindacali nel dopo-costituzione e cui si devono le maggiori conquiste – a cominciare dallo statuto dei lavoratori – era proprio l’ambiguità; un’ambiguità che vizia anche il trittico confederale disegnato tra il 2011 e il 2014.
In secondo luogo, all’origine dell’autoconvocazione c’è la consapevolezza che non basta prendere atto che analoga iniziativa non è stata adottata (né consta che possa esserlo a breve) dai delegati di Cisl e Uil. Anche il loro assordante silenzio va interpretato. Nessuno può onestamente credere che possa equivalere seccamente a una ratifica ex post del trittico confederale. Piuttosto, fornisce la misura dell’avanzamento del processo di mutazione antropologico-culturale che ha visto un sindacato di militanza che ci tiene ad esibire di sé l’immagine di un agente del cambiamento (come è stata certamente la Cisl e, a tratti, la stessa Uil) trasformarsi in un sindacato di servizio con propensione ideologica più a subire che a riprogettare l’esistente. Al tempo stesso, costituisce l’indizio meno controvertibile della durezza di una prassi che fa del sindacato un mandatario sui generis, più un tutore che un rappresentante, e dei suoi rappresentati altrettanti soggetti sui generis, a metà tra il capace e l’incapace.
Infine, tutti gli autoconvocati hanno mostrato di rendersi conto che il trittico confederale si situa nel contesto della più virulenta crisi del modello democratico della rappresentanza politica e sociale del lavoro attraversata dalla Repubblica e che, ciononostante, le parti contraenti si sono accordate per approfittarne piuttosto che per rimuoverne le cause. Infatti, l’esuberante testo contrattuale è dominato dalla logica di apparati guidati dall’istinto dell’autoconservazione che si risveglia e si eccita soprattutto se presagiscono il dissenso. Non a caso, il trittico celebra l’apologia della “piena esigibilità” del contratto collettivo, lasciando così intendere che la funzione del contratto collettivo non si esaurisce affatto nella composizione del conflitto d’interessi in atto ed invece si estende alla messa in sicurezza della sua fase applicativa durante la quale la pace nei luoghi di lavoro deve essere chiusa in cassaforte. Dunque, la ragion d’essere della contrattazione collettiva sta nell’impedire l’insorgenza di conflitti futuri.
L’arricchimento del lessico sindacale – che risale agli accordi Fiat, da quello di Pomigliano in poi – potrà anche far gioire gli appassionati di semantica. Tuttavia, resta che “piena esigibilità” è una terminologia che si compone di un significante tanto suggestivo ed eufonico quanto nebuloso ed incerto ne è il significato. Toccherà ai contratti nazionali di categoria precisare fino a che punto essa possa predire una compressione della conflittualità non del tutto priva di ricadute sulla titolarità individuale del diritto di sciopero. Per adesso, si sa soltanto che le federazioni di categoria “dovranno” (sic) definire i meccanismi sanzionatori che presidieranno la fase successiva ai rinnovi in funzione di prevenzione di “azioni di contrasto di ogni natura” imputabili alle strutture in cui è articolata l’organizzazione sindacale. Come dire: le federazioni sono obbligate a co-determinare le sanzioni che gli imprenditori associati alla Confindustria sono legittimati ad infliggere alle medesime. Il che è senz’altro interpretabile come una maniera per far capire che per Cgil, Cisl e Uil l’autodisciplina non è un optional e che, tutt’al contrario, l’obbligo di pace è affidabile. Però, tutto questo rigore stride non poco con il rispetto della libertà e dell’autonomia delle federazioni cui le case-madri si sono attenute a proposito delle modalità di definizione delle piattaforme dei rinnovi contrattuali. Mentre l’asciutta prosa dell’allegato intersindacale al primo accordo del trittico confederale (quello del 28 giugno 2011) racconta che “le piattaforme vengono proposte unitariamente dalle Segreterie” federali, nel secondo accordo (quello del 31 maggio 2013) la narrazione è più blanda e permissiva: “le organizzazioni sindacali”, si legge, “favoriranno in ogni categoria la presentazione di piattaforme unitarie” e, dal canto suo, “la parte datoriale favorirà che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% + 1”. Così, l’organizzazione che in ipotesi pesa il 49% non solo resta vincolata al contratto nazionale concluso dal 50&+1 e anzi è tenuta a garantirne con ogni mezzo l’esigibilità. Per soprammercato, come si affretta a precisare l’accordo del 10 gennaio 2014, la mancata partecipazione alla trattativa ovvero l’esclusione dalla delegazione trattante le precluderà il godimento del diritto di cittadinanza nell’impresa previsto dal tit. III dello Statuto dei lavoratori. Il che, a tacer d’altro, è un modo piuttosto arrogante per riscrivere in chiave restrittiva il dispositivo della sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale il 31 luglio 2013; una sentenza che, come si vede, deve avere fatto venire l’orticaria a molti esponenti del mondo confederale.

Riproduzione riservata