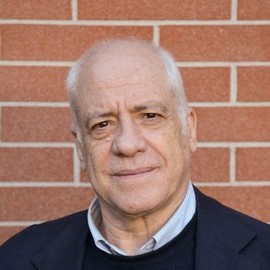Non è un caso che Ezio Raimondi amasse citare, assumendolo quale personale parola d’ordine, un detto di Lucien Febvre, secondo cui corre a tutti l’obbligo di bussare alle porte del vicino, ossia di non precludersi nessuna avventura culturale, abbattendo confini e superando di slancio le faglie e i crepacci innaturali e immotivati che separano le discipline finitime, spalancatisi per l’azione corrosiva di uno specialismo parcellizzato. Probabilmente le sue mobilissime esplorazioni critiche, gli incontri con i testi più imprevedibili, i dialoghi ininterrotti con la cultura non solo letteraria o umanistica derivano dai particolarissimi Lehrjahre del Raimondi ventenne, vissuti in un dopoguerra rigoglioso di fermenti, confuso ma solerte, con tanta voglia di vivere, ma anche di leggere, di conoscere, di discutere. Nei ricordi, più picareschi che elegiaci, di Raimondi, fu quella una stagione di «generosa goffaggine», retrospettivamente allietata dalla constatazione «di non essere andato lontano dal segno» nel riconoscere gli accordi e gli scambi fra discipline contigue e nel saggiare le concordanze dei metodi alle frontiere di scienze diverse, proprio là dove i sentieri, nel biforcarsi, si fanno più sinuosi e i libri, a dirla con Borges, s’identificano con i labirinti. Vivendo a Bologna che, tra Enriques e Mondolfo, è sempre stata periferica rispetto all’idealismo, c’era modo di frequentare maestri eccentrici e, nell’occasionalità del loro coesistere, ritrovarne, ma solo a posteriori, una sorta di complementarità.
Virtualmente la formazione di Raimondi si colloca all’incrocio tra l’erudita «sodezza» (un termine caro non meno a lui che a Muratori) appresa alla scuola di Carlo Calcaterra e la genialità percettiva di Roberto Longhi, l’uno capace di trasmettergli l’operosità febbrile di chi era stato scolaro di Arturo Graf, l’altro sorprendente nelle sue rivelazioni critiche sporgenti da un fitto reticolato di memorie, a formare una simbiosi tutta ideale fra testo e contesto, avendo di rincalzo l’eleganza comparatistica di un Vittorio Lugli e, un po’ più tardi, negli anni fiorentini della Crusca, la «critica verbale» di Gianfranco Contini. L’esattezza del rigore filologico si è potuto allora sposare con l’ardimento sperimentale. E, accanto alle esperienze più inamidate dell’Università, ecco poi le amicizie con il gruppo nascente del «Mulino», dove, in un clima più franco e meno diplomatico, c’era spazio per nutrire la curiosità sempre insoddisfatta. Entrando nella consorteria spesso stagnante della letteratura italiana Raimondi l’ha innovata con le sue interpretazioni, favorite dalle competenze a tutto campo che, applicate ai suoi lavori, hanno ampliato l’accezione meramente umanistica o bellettristica della letteratura. Le sue letture corsare, le sue scorribande nei territori di altrui competenza, sono state ininterrotte. Negli ultimi anni di guerra, in Germania, si era imbattuto nelle opere di Heidegger, leggendole di prima mano quando ancora in Italia nessuno conosceva nemmeno il nome del filosofo di Sein und Zeit. Quando negli anni Cinquanta, in un dopoguerra gravido di avvenire, impaziente di riguadagnare di slancio il tempo perduto e di colmare le lacune prodottesi nella quiete provinciale dell’Italia crociana, le «Annales» non erano ancora diventate una sorta di mito per gli storici, Raimondi leggeva le opere di un Febvre non ancora tradotto in italiano. Intanto attraverso due strade diverse come la romanistica e la storia dell’arte prese l’abitudine, con la mediazione di Ernst Robert Curtius e Henri Focillon, di considerare il testo letterario come sistema di relazioni. Nella seconda metà degli anni Sessanta, solo leggendo un articolo di Julia Kristeva apparso su «Critique», intuì l’importanza di Bachtin e del suo pensiero dialogico, garanzia di una testualità polisemica e complessa.
[…]
Riproduciamo qui l'incipit del Profilo di Ezio Raimondi tracciato da Andrea Battistini, pubblicato sul “Mulino” n. 3/14, pp. 505-510.

Riproduzione riservata