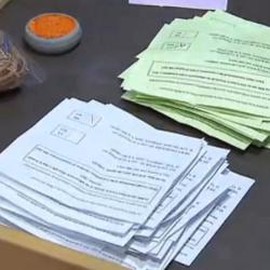La peste. I due referendum che si sono svolti in Irlanda venerdì 4 ottobre hanno confermato diverse cose sul rapporto tra eletti ed elettori al tempo di Facebook.
La prima consultazione, che ha attirato praticamente tutta l’attenzione dei media è stato quello sull’abolizione della camera alta del parlamento irlandese, il Seanad, bocciato dalla consultazione popolare. Il secondo, che chiedeva agli elettori se fossero d’accordo sulla creazione di una Corte d’appello da affiancarsi alla Corte suprema e all’Alta corte e sgravarne la mole di lavoro è stato invece approvato a larghissima maggioranza.
L’affluenza è stata bassa: 39,17% per il referendum sul senato e 39,38% per quello sulla Corte d’appello. I “sì” all’abolizione sono stati il 48,3% contro il 51,7% di coloro che hanno respinto la consultazione promossa dal premier Enda Kenny e dal suo partito di centrodestra, il Fine Gael, fin dai tempi della campagna elettorale del 2011. A guardare la grafica della testata online The Journal, l’ex Tigre Celtica appare spaccata in due tra aree urbane e aree rurali, con le popolose contee dell’Est (in particolare Dublino, che raccoglie attorno al 40% della popolazione), la contea di Cork nel sud e la sola contea di Galway nell’ovest (rispettivamente seconda e terza città irlandese per abitanti) in massa per il “no”, ossia per il mantenimento del senato.
La spiegazione più in voga di questo comportamento elettorale sostiene che alla popolazione urbana, fatta tipicamente di pendolari e stacanovisti frettolosi, non sono stati comunicati in maniera efficace i motivi del no, mentre invece ha funzionato benissimo lo slogan del “power grab” lanciato dal fronte del sì: il referendum era una “presa di potere” da parte della camera alta (e quindi del governo), che abolito il senato sarebbe rimasta l’unica. Ragioni di comunicazione insomma non molto diverse da quelle ipotizzate per spiegare il fallimento del primo referendum sul trattato di Lisbona nel 2008.
Ma perché è nata la proposta di abolire una camera parlamentare? Per capirlo si può guardare a come è composta e ai compiti che ha: dei suoi 60 senatori, 43 vengono eletti tra cinque vocational panels, liste di esperti nei campi di amministrazione pubblica e servizi sociali, agricoltura e pesca, cultura e istruzione, industria e commercio e infine lavoro. I candidati inseriti in queste liste sono nominati da parlamentari, senatori e consiglieri locali. Altri sei senatori vengono poi eletti dalle università irlandesi, e i restanti undici nominati direttamente dal primo ministro. I poteri sono molto blandi rispetto a quelli riservati alla camera dei deputati, il Dáil Éireann, e non c’è il potere di veto per le leggi approvate dall’altro ramo del parlamento, per le quali può solo proporre un rinvio di 90 giorni – facoltà che in 75 anni ha esercitato due sole volte.
Naturale dunque pensare a una riforma per renderlo più efficiente. Il punto è che il premier Kenny, dopo aver lanciato in grande stile la sfida costituzionale calcando la mano sui “20 milioni di euro l’anno di risparmio” in caso di vittoria del sì, se n’è pressoché disinteressato, disertando anche il dibattito televisivo con Micheál Martin, leader del principale partito d’opposizione, il Fianna Fáil. Come spiega un commento del Journal, ormai la comunicazione politica non si può limitare alle sedi istituzionali – Kenny ha spiegato le sue ragioni soltanto in parlamento e non facendo campagna – ma il cittadino-elettore vuole capire i motivi della scelta che è chiamato a compiere, altrimenti lascia tutto com’è nel dubbio che si tratti di un accentramento di potere: “Who watches the watchers?” chiede giustamente la passante di Galway.
Ma un’altra cosa che lascia perplessi riguardo questa “strana” consultazione popolare è l’atteggiamento post-voto del premier. Già da tempo circola un disegno di legge dei senatori di opposizione Quinn e Zappone, che permetterebbe di dare qualche potere in più alla camera alta e di allargare la platea elettorale agli irlandesi all’estero senza modificare la costituzione e quindi il metodo di composizione del senato. Dopo aver ribadito in tutti i modi che non c’era spazio per riforme e quindi tanto valeva abolirlo, appena smaltito il rossore della “sberla” elettorale (parole sue) il primo ministro si è affrettato a dichiarare la sua disponibilità a includere la riforma del senato nell’agenda del governo.
Alla luce di questo, il no degli elettori è forse anche il frutto di una stanchezza da inconcludenza politica che ormai ha contagiato tutta l’Europa con poche eccezioni. Come ha ben sintetizzato un elettore citando Romeo e Giulietta su una scheda elettorale annullata per protesta: “A plague to both your Houses”, la peste a tutte e due le famiglie (o camere parlamentari).

Riproduzione riservata