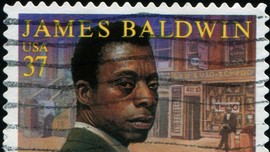«Si potevano vedere i miei amici a gruppetti di due, tre, quattro in un vicolo che si dividevano una bottiglia di vino o di whiskey e chiacchieravano, imprecavano, litigavano, a volte piangevano: perduti e incapaci di dire cosa li opprimeva tranne che sapevano essere "l’uomo" - l’uomo bianco. E pareva non esserci modo di rimuovere questa nuvola che stava fra loro e il sole, fra loro e l’amore, la vita, il potere, fra loro e qualunque cosa volessero. Non occorreva essere molto intelligenti per capire che c’era ben poco da fare per cambiare la situazione. Non bisognava avere un buon senso fuori dal comune per sentirsi divorati dalle incessanti e gratuite umiliazioni e dal pericolo che ognuno incontrava ogni giorno, per tutto il giorno... Il crimine allora diventava per la prima volta reale non una possibilità, ma la possibilità. Non si sarebbe mai riusciti a uscire dalla propria situazione col lavoro e il risparmio. Nessuno avrebbe mai guadagnato col lavoro quanto era necessario per riuscirci e, come non bastasse, il trattamento accordato anche ai Negri di successo provava che, per essere liberi, ci voleva più di un conto in banca. Ci voleva una leva, qualcosa che facesse paura. Né la civiltà e la ragione, né l’amore cristiano avrebbero fatto sì che quella gente ti trattasse come loro presumibilmente volevano essere trattati. Solo la paura del tuo potere di vendicarti li avrebbe portati a farlo o pareva che li portasse a farlo, e questo bastava - e basta».
Qualche giorno fa il “New Yorker” ha ripubblicato un lungo saggio del 1962, Letter from a region in my mind, di James Baldwin, uno dei principali scrittori e attivisti afroamericani del Novecento, dove partendo dalla propria biografia schizza la paranoia in cui gli afroamericani precipitano per la condizione deumanizzata nella quale i bianchi li tengono. Baldwin non era un rivoluzionario e si avvicinò, ma non si unì ai musulmani neri di Elijah Muhammad perché non voleva un’America di neri, ma di uguali come dice il Sogno americano e come predica il cristianesimo «di quell’ebreo poco raccomandabile e bruciato dal sole che gli ha dato il nome, non il cristianesimo di quel fanatico ipocrita senza pietà di San Paolo» e il racconto di sé che ci propone è il racconto della vicenda di tutti i Negroes, che per lui esistono solo in America perché solo in America sono «senza terra», sospesi a metà, in un luogo in cui non possono che adeguarsi alla civiltà dei bianchi, ma non debbono neppur provarci. Quel racconto giunge al fondo della questione, ci dà la chiave per entrare nella storia americana di sempre e dei giorni che stiamo vivendo.
Oggi la grande maggioranza degli americani bianchi non si dice razzista; ma ci sono correnti profonde, inestirpabili parrebbe, che percorrono la cultura e la società americane che occorre vedere avvinghiate a quelle positive che le strutturano
Oggi la grande maggioranza degli americani bianchi non si dice razzista, il suprematismo bianco è un fenomeno numericamente marginale e anche giornali e blog conservatori stigmatizzano l’uccisione di George Floyd ad opera della polizia di Minneapolis e difendono l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Non è più il 1962 della lettera di Baldwin; ma ci sono correnti profonde, inestirpabili parrebbe, che percorrono la cultura e la società americane che occorre vedere avvinghiate a quelle positive che le strutturano. Gli Stati Uniti sono la punta di diamante della civiltà europea. Il liberalismo che vi nacque assieme alla Costituzione del 1787, la democrazia impostasi negli anni Trenta dell’Ottocento, la società multietnica che vi sorse con la continua immigrazione, sia pure fra ingiustizie ed esclusioni e attraverso lotte durissime, la società dei consumi che consentì alla maggioranza degli americani di giungere alla prosperità, la difesa della liberaldemocrazia che salvò l’Europa dai totalitarismi sono cose grandi. Sono il sogno europeo nato dall’Illuminismo prima ancora che il sogno americano. Ma quel sogno era anche un sogno di conquista travisato da fardello civilizzatore dell’uomo bianco. La storia statunitense comincia tanto nel 1776 quanto nel 1619 quando i primi africani vennero portati in Virginia quasi per caso da una nave negriera e nel giro di pochi anni se ne capì l’utilità come schiavi e comincia anche, sempre nel Seicento, con le guerre contro i nativi dei pii puritani del New England giunti in America «alla ricerca della libertà».
Tutto questo non è il passato o, meglio, lo è in quanto dimenticato ovvero ricordato con le lacrime agli occhi come un passato da condannare, non come un retaggio che incide ancora. È il caso dell’ideologia che «non guarda al colore», color blind, di tanti bianchi che esalta il diritto di tutti gli americani a realizzarsi indipendentemente dal colore nelle condizioni uguali per tutti che gli Stati Uniti offrono. Lavoro, fatica, onestà e finalmente la riuscita. È quello che hanno fatto i bianchi e che gli afroamericani sono in grado di fare. Ma Baldwin ce lo dice, il crimine nelle condizioni vere degli afroamericani diventa non una possibilità, ma la possibilità e il far paura nelle strade la leva per ottenere rispetto. E questo continua a essere molto spesso vero nonostante l’affermarsi negli ultimi decenni di una solida borghesia nera, perché quella borghesia cooptata dalla società bianca non è riuscita a rompere la color line, l’invalicabile confine del colore fra neri e bianchi. Ha fatto proprio il meraviglioso individualismo americano e non si è accorta che è l’altra faccia della callousness, l’indifferenza pubblica per gli sconfitti che trafigge con la sua violenza tanta parte della società e della storia americane. Un’indifferenza che riguarda anche il white trash, la spazzatura bianca, i bianchi marginali ai quali si chiede di ammazzarsi di lavoro mal retribuito e mal protetto o di lasciarsi andare nei vicoli delle città. Ma sono bianchi e questo ha l’effetto patetico di farli sentire superiori e di renderli non pericolosi. Si può non parlarne, allora, come non si parla di un piccolo difetto fisico nascosto dai vestiti. Gli afroamericani dei ghetti, invece, sono davvero l’altro da sé, una società altra a cui è possibile non dare protezioni sociali e cure mediche o dargliele più o meno scarse a seconda della politica bianca. E che fa paura. Fa paura perché il far paura, ancora Baldwin, è l’unico strumento che i neri hanno a disposizione.
In questi giorni l’America brucia e come ai tempi di Baldwin nei riots compaiono saccheggiatori e violenti così come bianchi e neri si mescolano nella protesta. Un film già visto che il mondo conservatore tratta, guardate i suoi media, come un problema di ordine pubblico – e più o meno nient’altro. Lo schema è sempre lo stesso per i conservatori mainstream, lasciamo perdere i radicali. Ci sono episodi di violenza da parte della polizia o di privati cittadini che possono avere esiti mortali e che vanno puniti. Ci sono anche proteste pacifiche che rientrano nei diritti costituzionali degli americani. Poi ci sono i distruttori violenti da contrastare con la forza della legge per riportare l’ordine.
Quando la linea del colore diventa tenue, perché gli Stati Uniti non riescono più ad avere un primato indiscusso mondiale e milioni di americani bianchi temono di diventare marginali, ecco che può nascere – ed è nato – un leader che incarna le loro fantasie apocalittiche trasformando il suo personale narcisismo in un narcisismo nazionale
Sarebbe un quadro eccellente, il law and order di un liberalismo perfetto, se non fosse un quadro che nasconde lo sporco sotto il tappeto e lo sporco è la violenza fisica e morale con cui la società afroamericana formatasi nella marginalizzazione - e quindi a sua volta spesso violenta e pericolosa - così come il white trash vengono tenuti. E quando la linea del colore diventa tenue, perché gli Stati Uniti non riescono a darsi un ruolo in un mondo in cui non hanno più un primato indiscusso e milioni di americani bianchi temono di precipitare fra i marginali, ecco che può nascere, è nato, un leader che incarna le loro fantasie apocalittiche trasformando il suo personale narcisismo in un narcisismo nazionale. Vedere il presidente che tiene in mano la Bibbia senza dire una parola, incarnandola e facendosi immagine sacra, e con la sua sola presenza riconsacra la chiesa episcopale di St. John a cui si è appiccato un incendio dopo aver fatto sgombrare a forza da una protesta pacifica il cammino dalla Casa Bianca alla chiesa quasi aprendo le acque del Mar Rosso ‑ un nuovo Mosè che guida il popolo in marcia verso Canaan ‑, vederlo è uno spettacolo potente; ma non è più il reality show televisivo che fece di Trump un personaggio nazionale. È una fantasia salvifica tutta bianca, un’ossessione perturbante senza esame di realtà. Purtroppo un altro passo che allontana gli Stati Uniti da quell’illuminismo concreto e da quell'accettazione del pluralismo che ne sono stati l’ideale civilizzatore.

Riproduzione riservata