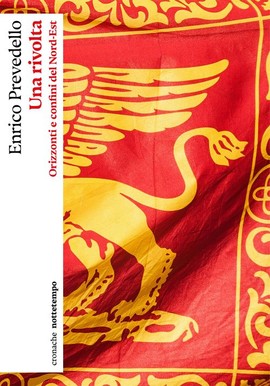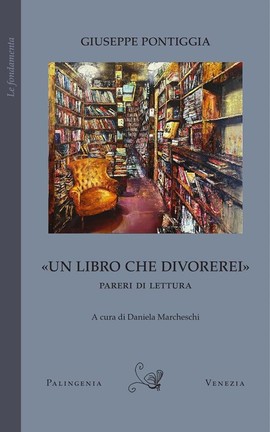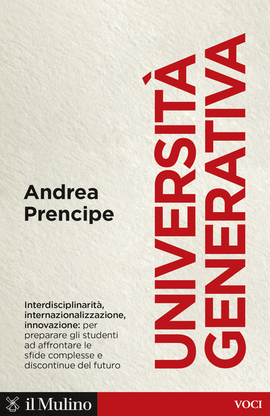Impietose come un bollettino di guerra, le ultime rilevazioni Istat restituiscono un quadro dell’occupazione nazionale nel quale campeggiano la cronica disoccupazione giovanile (29,8%, terzultimi in Europa, dopo Grecia e Spagna) e un nuovo «record di occupati precari», schizzati a 3 milioni e 123 mila (Rosaria Amato, Dicembre nero per il lavoro, «la Repubblica», 31.1.2020). Cade dunque particolarmente opportuna la pubblicazione di Lavorare tutti? Crisi, diseguaglianze e lo Stato come datore di lavoro di ultima istanza del giornalista e ricercatore Martino Mazzonis (Ediesse, 2019).Il senso del libro lo riassume, come meglio non si potrebbe, nella premessa Gianna Fracassi, vicesegretario generale della Cgil: «L’unica chiave capace di arrestare l’avvitamento è il lavoro». Nelle poco più di 150 pagine che seguono, con il sostegno di un'appassionata introduzione teorica di Laura Pennacchi della Fondazione Basso e di una postfazione di Riccardo Sanna, capo area delle politiche per lo Sviluppo sempre della Cgil, l’autore mette a frutto la propria lunga conoscenza diretta della realtà statunitense per disegnare un denso percorso di indagine e di proposta. Che, partendo dagli Stati Uniti dell’ultimo decennio, sospesi fra recessione e ripresa, approda a «un Paese decisamente in difficoltà» (p. 127) come il nostro.
Mazzonis a questo punto prova a immaginare un’applicazione da noi dei progetti emersi di recente nel mondo progressista d’oltre Atlantico, all’insegna del cosiddetto Green New Deal e del rilancio della parola d’ordine di «lavoro garantito», grazie agli sforzi congiunti di pubblico e privato e soprattutto a un ruolo decisivo dello Stato come creatore di occupazione.
Nella lucida e spietata analisi del quadro economico e soprattutto del mercato del lavoro statunitense del post-2007 spiccano quei processi di polarizzazione sociale e crescita delle disuguaglianze, tristemente noti alle cronache del capitalismo del mercato finanziario emerso negli ultimi quattro decenni e persistenti, nonostante le misure obamiane e l’andamento positivo per tutte le fasce di reddito segnalato dall’Economic Policy Institute nel 2018.
Ecco allora il rinnovarsi della forbice, di redditi e distribuzione di ricchezza, per cui «tra il 2007 e il 2016 le famiglie più ricche sono più ricche di circa 70.000 dollari», mentre «i redditi medi sono diminuiti di circa 50.000 dollari l’anno» e «quelli più bassi sono quasi dimezzati, fermandosi a quasi 10.000 dollari l’anno» (p. 61). Ed ecco soprattutto un mercato del lavoro segnato, a dispetto della ripresa in cifre assolute (da 140 a 158 milioni fra il 2010 e il 2018), da una bassa partecipazione, il 73,3%, al di sotto della media Ocse; e con un tasso di disoccupazione (3,7%) che è ufficialmente al livello più basso dal 1995, ma che più che raddoppia (7,6%), se ci mettiamo dentro le forze marginali, i lavoratori scoraggiati e il part-time involontario.
Che fare? Riandare ai grandi progetti di lavori pubblici del New Deal. Per ripensarli, con uno sguardo sgombro dai pesanti stigmi di razza che li caratterizzavano, frutto dell’influenza del notabilato sudista bianco sulla coalizione rooseveltiana, e ritararli opportunamente sul presente. Di qui le ipotesi di Job Guarantee elaborate dagli economisti del Levy Institute, sostenitori della Modern Monetary Theory (Mmt), con al centro Stephanie Kelton, chief economist per la parte democratica della commissione Bilancio del Senato e dal 2015 consigliera economica di Bernie Sanders. E quelle del Green New Deal, nate, sempre sotto l’influenza degli economisti della Mmt, a opera dell’ala dichiaratamente socialista del Partito Democratico, che trova nella giovane deputata newyorkese Alexandra Ocasio-Cortez la sua più agguerrita portabandiera.
In maniera essenziale, ma efficace, Mazzonis tratteggia gli elementi chiave di queste proposte, che puntano alla creazione di occupazione in ambiti cruciali quali la lotta al cambiamento climatico e il lavoro di cura in società avanzate e complesse come quelle occidentali, trasformando due gravi sfide del presente in occasioni di riequilibrio dell’economia rispetto alla deriva neoliberista e finanziaria e ripianamento delle sperequazioni in caduta libera dell’ultimo quarantennio.
Con la stessa sobrietà l’autore volge lo sguardo alla nostra realtà nazionale, sottolineandone i problemi cronici («lavoriamo in pochi, troppi lavorano poco») e la polarizzazione su più piani (nella divisione internazionale del lavoro, sui singoli mercati interni, in termini geografici nazionali, lungo l’asse Nord-Sud). Senza dimenticare naturalmente i limiti di provvedimenti recenti come il Jobs Act, che «non ha ridotto in maniera significativa la disoccupazione né determinato un sostanziale aumento della partecipazione al mercato del lavoro» (p. 131), o il Reddito di cittadinanza, rispetto al quale «i dati sulla partecipazione al mercato del lavoro e quelli sull’occupazione rendono improbabile l’ipotesi secondo la quale le persone che riceveranno il reddito possano trovare lavoro» (p. 153). Il che giustifica l’urgenza di «misure non convenzionali capaci di portare il Paese fuori da una lunga crisi» (p. 141).
Utile sul terreno del dibattito corrente, il libro sollecita anche chi lo legga con gli occhi dello storico di professione. A cominciare dalla necessità di un esame più contestualizzato del New Deal rooseveltiano che ne sottolinei anche gli aspetti di soggettività operaia e popolare, qui solo indirettamente evocati da Mazzonis quando accenna alle «spinte dal basso» (i sindacati, gli agricoltori) (p. 87) o al fatto che «per trasformare la macchina burocratica servono grande consenso ed energie che forse era più facile mobilitare negli anni Trenta» (p. 121).
Mentre la riflessione teorica operaista, prima, e la ricerca storica più avanzata, poi (vedi Steven Attewell, People Must Live by Work: Direct Job Creation in America, from FDR to Reagan, University of Pennsylvania Press, 2018), collocano al centro di quella vicenda proprio il ruolo svolto dalle lotte operaie, dei disoccupati e delle tante associazioni popolari di base nel difendere il New Deal dai suoi nemici e nel stimolarlo a essere più audace.
Un analogo discorso di analisi della concreta soggettività di classe vale per la difesa del valore del lavoro, quale perno dell’identità individuale e collettiva cui ancorare i progetti esplorati nel libro, riaffermata con forza da Pennacchi. I suoi argomenti, in larga misura di natura teorica, andranno evidentemente discussi alla luce delle indagini storiche e sociologiche sulle drammatiche e penose condizioni in cui si è lavorato e si lavora (vedi da ultimo Anna Wiener, Uncanny Valley, Farrar, Strauss and Giroux, 2019). Analisi che forse aiutano a capire perché tanti agognino la pensione o si aggrappino a ogni opportunità per sottrarsi a condizioni insostenibili.

Riproduzione riservata