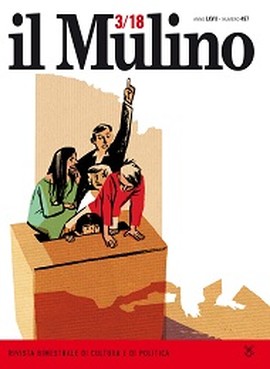Già nel 1995 Predrag Matvejević aveva utilizzato il termine «democrature» per descrivere i regimi, formalmente costituzionali ma nei fatti oligarchici, emersi dallo smembramento della Jugoslavia. A oltre vent’anni di distanza, la definizione aiuta a cogliere le contraddizioni delle transizioni nei Paesi del Sud Est Europa, di cui la Serbia rappresenta un caso per molti versi paradigmatico: formalmente tra i primi della classe nelle riforme europee, nei fatti è in caduta libera per quanto riguarda gli standard democratici.
Il Partito progressista serbo (Sns), che governa dal 2012, ha fatto della crescita economica la sua carta vincente all’interno del Paese e della stabilità nella regione il suo cavallo di battaglia nelle relazioni con i partner europei. Con continui esercizi di equilibrismo tra dichiarazioni di impegno verso Bruxelles e conferma del legame storico con la Russia, l’attuale presidente Aleksandar Vučić e il «suo» Partito progressista possono contare su un solido supporto sia all’interno del Paese sia nelle relazioni estere, forti dell’apparente mancanza di alternative percorribili. La coalizione di governo può così consolidare il controllo sulle istituzioni e ridurre lo spazio del dissenso tramite continui attacchi agli oppositori politici, alla stampa libera e alla società civile, facendo scivolare il Paese verso un regime che molti osservatori non esitano a definire di stampo autoritario e populista.
[L'articolo completo, pubblicato sul "Mulino" n. 3/18, pp. 408-415, è acquistabile qui]

Riproduzione riservata