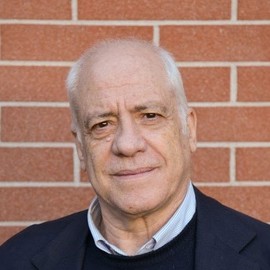Non avrebbe potuto reggere un intero set, le condizioni di salute non glielo permettevano. Appena dimesso dall’ospedale, Paolo Pietrangeli aveva comunicato al Club Tenco che, venendo a Sanremo a ritirare il premio alla carriera, avrebbe cantato una sola canzone, di più non era in grado di fare. Ma, una settimana prima della manifestazione, il bollettino sanitario si aggravò, un viaggio era sconsigliato. A ritirare il suo premio sarebbe stato l’amico Piero Brega, ex frontman del Canzoniere del Lazio e ora cantautore, partecipante alla Rassegna.
Ma nessuno poteva prevedere il precipitare della situazione. E, a un mese esatto di distanza, Paolo se ne è andato.
Del club Tenco è stato un fedele compagno di viaggio, approdando già nel 1975 alla seconda edizione. Alla fine del suo set, il pubblico chiese a gran voce Contessa che era pur sempre la colonna sonora della protesta giovanile del tempo… Paolo tentennò molto e tentò di giustificarsi: «In una manifestazione dedicata alla canzone d’autore, io non la posso più cantare. Ormai non mi appartiene più, è della gente che la intona per le strade…». Ma dal pubblico si rispose: «la cantiamo tutti insieme, allora».
Di quella canzone sarebbe rimasto prigioniero per tutta la vita e, alla fine, infilò in arpeggio i tre accordi iniziali mi/do/si7 tirando così giù, come suol dirsi, la sala. I duemila presenti fecero partire un grande boato che coprì quell’incipit «Sapesse contessa, all’industria di Aldo…»: ecco che l’inno dei cortei e delle manifestazioni, che in quegli anni riempivano le città italiane, entrava prepotentemente in un grande ed elegante teatro dalle poltrone di velluto rosso.
Ecco che l’inno dei cortei e delle manifestazioni, che in quegli anni riempivano le città italiane, entrava prepotentemente in un grande ed elegante teatro dalle poltrone di velluto rosso
Dietro le quinte, il patron Amilcare Rambaldi, fondatore e presidente del club Tenco, si precipitò da Giovanna Marini che si era esibita poco prima, pregandola di imbracciare la chitarra e di entrare in scena unendosi a Paolo. Aggiustandosi la tracolla dello strumento, Giovanna entrò sul palco di corsa, proprio nell’istante in cui il brano era arrivato al fatale refrain: «Compagni dai campi e dalle officine…». L’apparizione improvvisa e il suo contagioso controcanto scatenarono quello del pubblico e così il «prendete la falce, portate il martello» sembrava davvero «illuminare l’aria» come le fiaccole dell’epica rivoluzionaria ottocentesca. Dopo gli entusiasmi raccolti da La locomotiva eseguita la sera prima da Francesco Guccini, il teatro Ariston di Sanremo, non ancora sede del Festival che vi sarebbe approdato due anni dopo, sembrava davvero un grande covo di cospiratori pronto alla rivolta.
Passò il Sessantotto, ma non scomparve Contessa. Per ironia dei cicli storici, Paolo Pietrangeli è morto proprio in un periodo in cui, dalla Whirpool e dalla Hitachi di Napoli alla Riello di Villanova Cepagatti fino alla Saeco di Gaggio Montano, si ritorna a occupare le fabbriche. Anche se, stavolta, non «per avere i salari aumentati», ma per continuare ad averli, i salari.
Ogni apparizione sembrava fissare i punti della sua traiettoria artistica, scandita dalla sintonia tra la percezione politica e quella sentimentale
Paolo tornò nuovamente al Tenco nel 1981, nel 1988 e nel 2015. E ogni apparizione sembrava fissare i punti della sua traiettoria artistica, scandita dalla sintonia tra la percezione politica e quella sentimentale o, volendo scomodare immagine un po’ abusata, tra il «pubblico» (Contessa, Valle Giulia e Il vestito di Rossini) e il «privato» che era poi un’indagine sul dubbio, grande motore della sua poetica (Era sui quarant’anni, Vizi privati e pubbliche virtù, La notte in cui mi tolsi l’armatura). Si trattava, in fondo, di osservare una duplice evoluzione: quella della baldanza giovanile di Contessa, scritta a soli ventun anni, e le relative braci da lui osservate con la consueta ironia (È finito il Sessantotto, Il riflusso, Ho insultato il movimento) e quella della propria coerenza personale, che è poi l’analisi necessaria a un’intera generazione.
Nelle sue canzoni politiche (che tali sono quasi tutte) non c’è la spietata satira di costume di Fausto Amodei né la lucida analisi intellettuale di Giovanna Marini, non ci sono protagonisti o fondali proletari come in quelle di Ivan Della Mea o di Gualtiero Bertelli. Il personaggio delle composizioni di Paolo Pietrangeli (militante in formazioni politiche o semplicemente simpatizzante) è il rappresentante di quella borghesia attratta dalla predicazione marxista, non fideistica per natura seppur sostenuta da un impegno continuo (in Disimpegno, a una riunione politica partecipa perfino una fotomodella). Il suo è un personaggio privo delle certezze granitiche del realismo sessantottardo cui, però, non volta le spalle in segno di delusione. Con il suo stralunato «eravamo marxisti, ci sentiamo marziani», appare molto più simile a un eroe della continua ricerca, come il Bobo di Sergio Staino interpretato proprio da Paolo negli sketch televisivi di Drive In, curati dallo stesso Staino.
Diventa un bersaglio molto facile, quindi, per gli strali dell’inflessibilità ideologica e dell’intollerante purezza (sia quella per difetto che quella per eccesso, come canta la Marini in Viva Voltaire e Montesquieu). Un’intransigenza che trova incompatibile l’appartenenza a formazioni di sinistra, come Rifondazione Comunista prima e Potere al Popolo poi, da parte di un borghese presumibilmente toccato da una certa agiatezza. Ancor di più, se questa gli arriva dal mestiere di regista delle trasmissioni di Maurizio Costanzo e della consorte Maria De Filippi: l’etichetta Mediaset, paradossalmente l’azienda che con i suoi nuovi miti e i suoi lustrini ha seppellito lo spirito del Sessantotto, gli resta così appiccicata addosso. Un virus mentale, questo, capace di sollevare non solo l’indignazione del barricadero a oltranza o quella del benpensante più spietato, ma anche di alcuni coraggiosi intellettuali, sia quelli che si possono permettere la scelta dell’editore, sia i nemici dichiarati dell’omologazione.
Hai voglia di focalizzare lo spartiacque tra lavoro e scelte politiche: vince la lotta tra marchi, Mediaset vs Contessa, in un clima da muro di Berlino, da «moro o cristiano». Figuriamoci, uno che prende i soldi da Berlusconi…
La regia e il cinema hanno comunque segnato l’intera esistenza di Paolo Pietrangeli. Innanzitutto in quanto figlio di Antonio, cineasta cui si devono film come La visita, Adua e le compagne, Io la conoscevo bene e La parmigiana. E poi perché lui stesso è stato regista (I giorni cantati e Porci con le ali, oltre a diversi documentari) sceneggiatore, attore e perfino direttore della fotografia.
Nella attività di cantautore, la presenza del cinema ricorre, più o meno direttamente, in molte sue canzoni (Cinema, Cinema 2, Cinecittà, Tarzan, Esther Williams) tanto da fargli cantare: «C’è chi come me, vi assicuro ho finito, / ha due miti soltanto: Marlon Brando e il partito». Anche la costruzione dei soggetti e delle scenografie hanno tagli prettamente cinematografici, partendo proprio dalla stessa Contessa dove il dialogo iniziale ha il sapore della commedia all’italiana e poi, con un montaggio velocissimo da Ėjzenštejn, l’impetuoso ritornello sembra intonato dal trombettiere del settimo cavalleria. Dietro all’iperbolica quartina «Mio caro padrone domani ti sparo / farò di tua pelle sapon di somaro / ti stacco la testa ch’è lucida e tonda / così finalmente imparo il bowling» appare la sagoma di un Bud Spencer con tutta la sua bonomia. Lo stracchino, da lui incisa ben tre volte, è caratterizzata dall’incipit «avendo delle difficoltà nel mio linguaggio» che ricorda stilisticamente un verbale di denuncia dei carabinieri: pare di essere in una pellicola di Steno con Totò. Ma, soprattutto, l’immagine della commessa che dall’alto della scala mostra generosamente il proprio sottogonna, rimanda all’Antonelli di Malizia.
Non sempre, però, i fondali sono di cartapesta: non lo sono quando, insolitamente in romanesco, scava nelle miserie morali delle borgate, quasi fossimo in Sporchi, brutti e cattivi di Scola: «Mamma, nun te ce mette a pecoroni, / gli schiaffi de papá so’ de mattoni / mamma vorrei sape’ si er cazzo delle iene / è fatto a strisce o de un colore che nun me viene / finiscila de disegnà animali prima / pensa a fa’ i compiti pe’ scola / prima che torni tu’ padre ‘mbriaco».
Con quest’ultima canzone, ho un rapporto personale. L’ascoltai al Teatro Officina di Milano nel 1974. Era inedita e chiesi a Paolo il testo. Me lo spedì con la consueta gentilezza. Poi il brano scomparve dai suoi spettacoli, quando mi capitava di vederlo gli chiedevo notizie. E, sulla copertina dell’album Tarzan e le sirene del 1988, mi fece una dedica con la scritta: «Il cazzo delle iene al prossimo». Di «prossimi» ce ne furono altri dieci finché, all’inizio di quest’anno, arrivò l’undicesimo, Amore un… stampato solo in vinile, come un ritorno alle origini. Con mia grande sorpresa conteneva la canzone in questione, con il titolo Mamma vorrei sapé. Quando si decise di assegnargli il Premio Tenco, lo chiamai parlandogli di quel brano. «Come fai a conoscerlo?», mi chiese. S’era scordato di tutto.

Riproduzione riservata