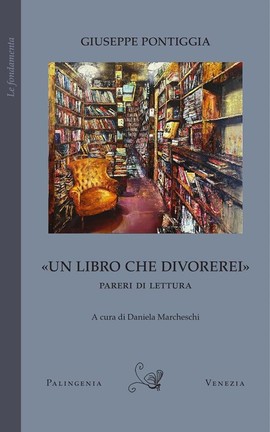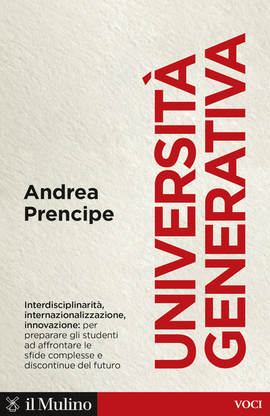È un libro un po’ sghembo ma pieno di stimoli, Paesaggio con rovine di Generoso Picone (Mondadori). Pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario (23 novembre 1980) del terremoto in Irpinia, quando l’autore era un giovane cronista del “Mattino”, il volume è molto più che una rievocazione della più grande tragedia dell’Italia repubblicana con 2.914 morti, 8.848 feriti e circa 280.000 sfollati. Picone, giornalista culturale e critico letterario, sa mescolare con grande sapienza e bella scrittura, ricordi, ragionamenti, storie, incontri, sopralluoghi. Cosa tiene insieme questa opera fuori dagli schemi? “Mi accorgo che in questi quarant’anni – ne avevo ventidue il 23 novembre 1980, oggi ne ho sessantadue – in ogni libro letto, romanzo o saggio che sia stato, in ogni pagina che potesse contenere riferimenti anche distanti nello spazio e nel tempo, in ogni luogo che abbia registrato una simile esperienza, io ho ricercato risposte alle domande scaturite da quella sera”. Il libro è quindi l’esplorazione di un trauma che parte dalle Selle di Conza, in Alta Irpinia, là dove si è rotta la faglia, con l’autore che si interroga perché non esiste un memoriale del terremoto. Coincidenza vuole che il volume sia stato pubblicato nell’anno della pandemia, quando un trauma collettivo ha investito il pianeta, e il comportamento di molti, tra prima e seconda ondata, è stato l’immediata rimozione di ciò che è accaduto. Picone rammenta, a confronto, un libro uscito proprio nel 1980, Un paese senza di Alberto Arbasino e ne cita l’incipit: «Un Paese senza memoria collettiva, con perdita generale e capillare di sapere collettivo, di storia collettiva, realtà collettiva, conoscenza collettiva? Un Paese senza “presa di coscienza” nei confronti della propria antropologia, con un rigetto deciso delle proprie abitudini; e un rifiuto diffuso di riconoscere i propri corsi e ricorsi storici nell’atto stesso di viverli e riviverli come tragedie che si replicano come farse o viceversa?». Un Paese continuamente in bilico tra Caporetto e Vittorio Veneto. In occasione di ogni dissesto idrogeologico, di ogni terremoto, di qualunque disastro naturale, viene ripetuto che manca la cultura della prevenzione, ma poi si prosegue come se niente fosse.
L’Irpinia del 1980, come tante parti del Sud, era una regione povera, a forte emigrazione, con una civiltà contadina di cui si intravvedeva il crepuscolo, ma con qualche fermento di novità. Simbolico il concerto che Lou Reed tenne allo stadio Partenio di Avellino, dove giocava la squadra che aveva raggiunto per la prima volta la serie A, nell’estate del 1980. Quell’Irpinia, quel Sud, non erano in ogni caso un’Arcadia, un luogo mitico a cui qualcuno oggi vorrebbe ritornare. È stata una terra di emigrazione, a partire dal suo cittadino più illustre, Francesco De Sanctis, che ne fornì un’antropologia spietata in un suo aureo libretto (Un viaggio elettorale, 1876), quando vi ritornò in visita. Gli irpini che si sono illustrati nel mondo sono tanti, dal caso recente di Aldo Dragone, fondatore del Cirque du Soleil, a Salvatore Ferragamo, Ettore Scola, Carlo Muscetta e molti altri. “Semilavorati intellettuali” li definisce l’autore. Attorno al 1980 si intravvedeva la possibilità di non perdere le energie migliori, un rivolo di benessere era arrivato anche a Sud, il Sessantotto aveva smosso qualcosa anche nella stagnante società meridionale. Così Picone rievoca gli anni della sua giovinezza ad Avellino, ma al tempo stesso ricorda che la pratica politica, il clientelismo, non accennava a mutare. Emblematica la figura di Fiorentino Sullo, politico di razza della Dc riformatrice, firmatario della prima legge urbanistica italiana, più volte ministro, ma attento organizzatore delle clientele nella propria provincia. Sullo fu “ucciso” politicamente da Ciriaco De Mita che ne ereditò i metodi. Riguardando le immagini del terremoto riproposte in tv in occasione dell’anniversario, penso a quei morti come alle prime vittime del boom economico e ripenso a quelle case tirate su in fretta tra gli anni Sessanta e Settanta, ora ripiegate su di sé e piene di cadaveri. Erano state le case, “i palazzi”, così li chiamavano, attesi a lungo da chi era vissuto fino ad allora con servizi igienici provvisori, col solo riscaldamento del camino, ed era finalmente pronto ad entrare nella modernità, a vivere in abitazioni non diverse da chi era emigrato a Torino o a Milano. Picone ricorda come dopo il terremoto si misero in moto energie straordinarie, come lo sdegno del presidente Pertini mobilitò l’intero Paese, in un afflato di solidarietà che aveva un precedente remoto solo nel terremoto di Messina del 1908. Scrisse allora Manlio Rossi Doria, forse il nostro più grande meridionalista: “Questo incontro civile tra settentrionali e meridionali va rispettato, aiutato e stabilizzato, perché ne può venire per tutti un bene comune; importante, in particolare, è che esso si prolunghi nel tempo”. Aggiunse Leonardo Sciascia: “non ricostruire, ma costruire”. A tutti era chiaro che la ricostruzione poteva essere una grande occasione per l’intero meridione e dare una svolta a una politica meridionalistica che allora veniva identificata nel Ministero delle partecipazioni statali e nella Cassa del Mezzogiorno. Scrisse a caldo Antonio Cederna: “La guerra alla speculazione, al clientelismo, alla camorra: questo è il vero intervento straordinario di cui il Mezzogiorno ha disperato bisogno”. Così non avvenne. A un anno dal terremoto così Eduardo De Filippo commentò quell’Italia sulla prima pagina del “Mattino”: “Lotte tra i partiti per il potere, crisi di governo, riforme restate lettera morta, leggi anacronistiche, ignoranza, corruzione, confusione, terrorismo, malavita, rapimenti, droga nelle scuole, assenteismo sul lavoro e disoccupazione, scandali pubblici e scandali privati, strafottenza, superficialità, e un pozzo sempre più profondo tra ‘e professure e il popolo, è così che vogliamo far passare la nuttata? Abbiamo sbagliato”. I grandi investimenti di denaro in un’area del terremoto che venne allargata a dismisura furono intercettati dai maneggi dei politici locali, da imprese del Nord e soprattutto dalla malavita organizzata. Picone fa il caso del comune di Quindici, il cui posto di sindaco, una carica divenuta importante perché finalmente c’erano soldi da spendere, aree da assegnare, indennizzi da stabilire, venne conteso nel sangue tra clan rivali. La questione meridionale divenne questione morale e i pregiudizi mai dimenticati sui meridionali furono l’humus su cui crebbe la Lega. A dieci anni dal terremoto fu istituita una commissione parlamentare, presieduta da Oscar Luigi Scalfaro, che constatò le malefatte, gli alloggi ancora provvisori per molti, ma rappresentò più che altro un momento di cupio dissolvi della prima Repubblica. Gli intrallazzi continuarono fino a che non esaurì il fiume di denaro, in un equilibrio precario tra interessi criminali e politici, alimentando “un’emergenza continua”, come la definì Giorgio Bocca.
Come si ricostruì? Picone è tornato tra i luoghi amati dall’alta Irpinia, là dove l’Appennino meridionale si allarga tra altipiani e dolci panettoni. Le eccezioni a una ricostruzione dissennata, alle fantasie di architetti anche celebri e più modesti geometri, sono state molto poche. Sono avvenute per iniziativa di singoli come Mario Antonio De Cunzo che considerava l’intero paesaggio dell’area terremotata un unico bene culturale e ambientale, seguendo la lezione quasi sempre inascoltata di Antonio Cederna, Elena Croce, Giovanni Urbani, Antonio Iannello, che si trasferì in Irpinia per un certo periodo, e pochi altri. Si è ricostruito bene, grazie a Iannello, il centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi, ma tornare a Bisaccia, Conza, Teora vuol dire fare i conti con un’identità smarrita, con paesi in via di continuo spopolamento, con i cartelli “vendesi” fitti fitti nelle case dei centri storici. Picone chiama “i figli del vuoto”, le generazioni che sono cresciute dopo il 1980 in quei luoghi. È un mondo che hanno trovato già così e ci si sono adattati, quando non hanno deciso di partire.
E chi resta cosa può fare? Basta il sentimento di “restanza”, come lo chiama l’antropologo Vito Teti? Davvero la pandemia offre una nuova chance a questi luoghi? L’autore è giustamente scettico perché, osserva, che senso ha parlare di decrescita in luoghi mai cresciuti. Oggi qualcuno almeno sta pensando a cercare una soluzione, a partire dagli stimoli di Fabrizio Barca che fu ministro della coesione territoriale nel governo Monti. Dal suo gruppo di lavoro è nato il movimento Riabitare l’Italia. Ritornare o andare ad abitare in luoghi così remoti, dove l’ospedale più vicino è comunque lontano, è una scelta di vita, una scelta di singoli, speriamo una scelta generazionale, ora che la rete offre nuove possibilità. Ma prima di tutto è necessario un cambio di mentalità, affrancarsi da antichi vincoli di appartenenza per arrivare a una vera emancipazione. Accadrà? Gaetano Salvemini amava ripetere: “Fa’ quello che devi, avvenga quello che può”. Picone sceglie di concludere un’opera destinata a restare con un finale lirico e, nonostante tutto, di fedeltà ai luoghi amati.

Riproduzione riservata