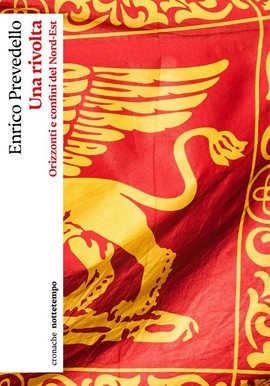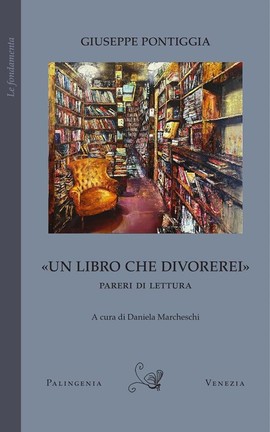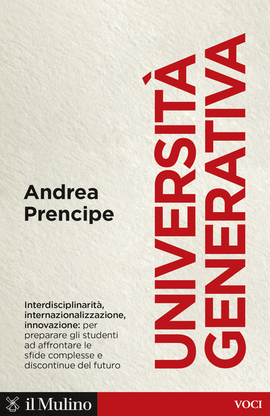La storia consiglia prudenza e suggerisce caldamente di non dare per scontato l’ordine. L’illusione post-bipolare di un mondo prevedibile e pacificato si scontra oggi con una realtà internazionale segnata dalla guerra in Ucraina, dal Medio Oriente di nuovo in fiamme, dal ritorno della competizione tra grandi potenze e dal drammatico permanere di una conflittualità diffusa, sebbene spesso dimenticata.
Nel suo ultimo libro (La mente tragica. Paura, destino, potere nella politica contemporanea, Marsilio, 2023), Robert D. Kaplan ritiene che solo “pensando tragicamente” possiamo davvero evitare la tragedia, dopo i decenni della “guerra al terrore” e i fallimenti in Iraq e Afghanistan. Una “lungimiranza apprensiva”, come presupposto dell’azione morale, dovrebbe guidarci (in primis i leader politici), insegnando a coltivare l’insicurezza e a rifuggire ambizione e vanità.
Kaplan elabora così un’opera volta a diffondere la tragedia non come una teoria ma come “sensibilità” rispetto a un mondo nel quale non tutto può essere risolto e sistemato. A tal fine l’autore statunitense propone un viaggio narrativo fatto di costanti rimandi e citazioni al “canone greco e shakespeariano” nonché alle sue esperienze di inviato di guerra.
A partire delle lezioni dei drammaturghi della Grecia classica, Kaplan definisce i contorni di una “sensibilità tragica”, nella quale colpa e coscienza sono fattori cruciali. Coscienza e conoscenza dell’esistenza del male e dei limiti dell’individuo nonché colpa, riletta in chiave personale dall’autore, la cui riflessione prende avvio proprio dall’errore di valutazione commesso nel sostenere la sciagurata invasione dell’Iraq del 2003, e dal dolore e dalla depressione collegata a tale scelta. Da qui Kaplan sviluppa la necessità di evidenziare i pericoli mortali dell’anarchia e il valore dell’ordine attraverso la tragedia, intesa non con come tormento o come “trionfo del male sul bene” ma come accettazione di un male minore, come consapevolezza di una conoscenza finita. Tragedia, quindi, come battaglia tra un bene e un altro bene, che provoca comunque sofferenza. Di nuovo l’Iraq ben illustra questo scontro tragico: la rimozione del tiranno è stato “un bene che ha sostituito un bene maggiore”: una parvenza di ordine senza la quale il Paese è piombato nel caos e nell’anarchia. Kaplan, per il quale l’ordine è una necessità suprema, scrive così un libro volto a promuovere una “mente tragica” in un mondo imperfetto. Nello stimolare una riflessione non banale, il volume ha due principali meriti.
Il primo è l’invocazione, costante e continua, alla prudenza. Il “fallimento devastante” in Iraq e Afghanistan rappresenta in tal senso una vera “ossessione” per l’autore, desideroso che gli errori del passato (personali e nazionali) non si ripetano in un contesto segnato da sfide più impegnative di quelle affrontate a Kabul o Bagdad. Nell’ottica della potenziale sfida futura tra Washington e Pechino, ogni richiamo a una politica accorta e prudente – specialmente in relazione al comportamento della potenza egemone – non può che essere prezioso. A fronte di quella che ritiene una “gestione approssimativa dell’Impero americano” dopo l’11 settembre, Kaplan enfatizza la saggezza dell’amministrazione di Bush senior nei primi anni Novanta, capace di fermarsi nell’impeto bellico e di non rovesciare Saddam, aprendo così le porte all’anarchia. Un caos scatenato anni dopo dalle scelte del figlio George W. Bush. Proprio l’anarchia e la violenza che l’autore ha visto in prima persona tra le macerie di Falluja rappresenta uno dei motori della riflessione. Il valore dell’ordine – come bene superiore rispetto alla pur positiva rimozione del tiranno – appare quindi assoluto.
Il “fallimento devastante” in Iraq e Afghanistan rappresenta una vera “ossessione” per l’autore, desideroso che gli errori del passato non si ripetano
Più in generale, oltre alla prudenza nelle scelte di politica estera, Kaplan apertamente elogia la saggezza che risiede nell’evitare la guerra e i suoi orrori. Come nelle parole pronunciate a mo' di cantilena da Marlon Brando alla fine di Apocalypse Now, l’orrore riecheggia nei racconti di guerra del reporter che ha vissuto decenni a contatto con i conflitti armati. Al contempo, però, non vi è traccia di pacifismo nella riflessione di Kaplan ma un chiaro collegamento ideale al paradigma realista. Più che al classico Sun Tzu, secondo il quale non esiste alcun beneficio da una lunga guerra, nel libro è esplicito il richiamo ad autori come Tucidide, Machiavelli e Morgenthau. In linea con il pensiero del realismo classico, Kaplan si focalizza infatti sull’imperfezione degli uomini e del mondo (da accettare per quello che è, senza speranze o smanie di trasformazioni radicali).
Il secondo pregio del volume attiene più allo stile che al contenuto. Il lettore, infatti, si trova di fronte costanti riferimenti alla tragedia: dai classici drammaturghi greci a Shakespeare, dagli scrittori russi fino a Il Gattopardo. Alcuni passaggi sono particolarmente evocativi e aiutano a spiegare con efficacia alcuni concetti-chiave per l’autore. Per esempio, tramite Dioniso e le Baccanti, Kaplan evidenzia la follia e il caos (nonché l’esigenza, anche da una prospettiva realista, di comprendere l’irrazionalità). Attraverso l’Antigone viene poi illustrato come la tragedia greca affronti (drammaticamente) il rapporto tra la lealtà alla famiglia e allo Stato. Infine, il personaggio shakespeariano di Iago è utilizzato dall’autore per parlare del male, la cui esistenza deve essere compresa e persino accettata. Ma la tragedia non è qui sinonimo di fatalismo, bensì consapevolezza della realtà. L’agire è infatti il massimo della grandezza, ma la tragedia è comprensione di una realtà “ostile”, dove il male persiste al di là di ogni illusione e speranza. La stessa inevitabile sofferenza dell’eroe rappresenta così l’essenza della tragedia.
Robert S. McNamara, uno dei politici più tragici della nostra epoca (stranamente e colpevolmente ignorato nel volume di Kaplan), cita nella sua biografia Eschilo, evidenziando come l’esperienza sia in fondo il premio del fallimento. Diversamente dall’ex segretariato della Difesa americana durante la guerra in Vietnam, l’intento dell’autore di The Coming Anarchy non è (purtroppo, sarebbe da aggiungere) quello di raccogliere le lezioni apprese dei fallimenti e degli sbagli. Sebbene il libro non indulga troppo nell’elaborazione di supposte responsabilità morali (ma semplicemente si limiti alla loro accettazione, come riflessioni personali a margine), il già citato orrore della guerra e il rifiuto della “idealizzazione della violenza” appare un utile antidoto in tempi segnati dal tifo da stadio che caratterizza ahimè la modalità con la quale molti esperti e accademici commentano i conflitti contemporanei.
Il libro, quindi, stimola a riflettere sulle caratteristiche della politica contemporanea con il merito di lodare la prudenza e la consapevolezza, traendo forza sia dalla letteratura sia dall’esperienza decennale di reporter di guerra. Ma l’originale promozione della sensibilità tragica avviene in un percorso narrativo segnato da almeno tre problemi che possono rappresentare degli ostacoli rilevanti rispetto all’intento del libro, nonché all’efficace diffusione del suo messaggio.
Il libro stimola a riflettere sulle caratteristiche della politica contemporanea con il merito di lodare la prudenza e la consapevolezza
Il primo problema attiene al determinismo con il quale Kaplan arriva facilmente a generalizzazioni a partire da esperienze personali. Questo aspetto aveva già attirato molte critiche in relazione ai suoi precedenti scritti, imperniati di analisi spesso legate ad aneddotica varia. Gli sbagli “delle élite della Est Coast” (a prescindere da contesto o dimensione partitica) nonché le riflessioni sui “difetti” del popolo americano, come fosse un’unità compatta e omogenea, sembrano ricalcare una certa geopolitica da operetta purtroppo molto di voga nel dibattito pubblico italiano. Ciò mal si concilia con la richiesta di maggiore consapevolezza con la quale affrontare una realtà complessa, al di là della “semplice” esistenza del male. Kaplan riflette anche sulle mancanze della Scienza Politica contemporanea. Ma i metodi e la pluralità delle prospettive teoriche della scienza politica e delle relazioni internazionali forse aiuterebbero ad affrontare con maggiore consapevolezza la complessità del reale, senza quel determinismo che ha accompagnato – sì tragicamente – le riflessioni di neoconservatori volte a sostenere l’invasione americana dell’Iraq.
Il libro poi sviluppa il proprio “messaggio” in opposizione a una supposta visione ottimistica della realtà internazionale. Sebbene questo approccio caratterizzi molti testi che mirano “a svegliare le coscienze” con una “buona dose di realismo”, il rischio è quello di elaborare una tesi sulla base di uno straw man argument (un argomento fantoccio): l’idea che vi sia una diffusa prospettiva rosea del contesto internazionale, basata sulla fiducia illimitata del mercato e della democrazia. Questa supposta visione “fiduciosa” (diremmo liberale dalla prospettiva realista) può certamente essere diffusa, ma ciò avviene soprattutto negli anni Novanta. Dopo i disastri della guerra al terrore e la crisi economico-finanziaria, le tracce di tale “ottimismo” sono assai labili se non del tutto inesistenti (si pensi al sostegno sempre più risicato alla globalizzazione liberale, anche nei dibattiti politici, più attenti ai costi che ai benefici di tale processo).
Kaplan parla addirittura di una società, che “evita di discutere della crudeltà della natura umana”, nella quale “preoccuparsi dei diritti umani aiuta a scalare la scala sociale”. Kaplan evidentemente dimentica gli ultimi lustri di dibattito su temi quali l’immigrazione, rispetto al quale una buona fetta delle opinioni pubbliche occidentali (si guardi il caso italiano) ha praticamente rimosso la dimensione umanitaria. E questo vale anche per le politiche, tra i respingimenti e i processi di esternalizzazione (gli accordi con attori vari per impedire ogni flusso), anche a costo di gravi violazioni dei diritti. Kaplan parla di “élite ottimistiche” che non hanno paura dell’anarchia, che non riescono a comprendere la vera natura del mondo nonché la rilevanza dell’ordine anche a causa “della mancanza di esperienza”. Viene quindi da porre una domanda a Kaplan: se solo l’esperienza diretta può portare alla comprensione, che valore può fornire la tragedia greca (e il libro stesso)?
La riflessione dell’autore però si comprende appieno solo soppesandone il lato “populista”, nel senso di ideologia che percepisce la società come divisa tra il popolo e una élite corrotta. Andando oltre l’idea (alla Walt) di una sorta di blob che guiderebbe con il pilota automatico liberale la politica estera americana, Kaplan accusa un insieme eterogeneo: élite della Est Coast, politici che non pagano il prezzo dei propri errori, “analisti con troppe lauree” e poca esperienza, intellettuali capaci di provare solo “una facile e appagante empatia per le vittime di guerra”. L’élite che guida gli Stati Uniti sarebbe composta da una “generazione sicura” che “non conosce guerra e anarchia”. Una mente tragica servirebbe quindi per superare una fase di perdurante ottimismo, cullato e promosso da leader abituati alla pace e al lusso, incapaci di capire l’orrore di guerra e anarchia e quindi di comprendere il male del mondo e i limiti dell’essere umano. Questa immagine romanzata è largamente diffusa nella comunicazione politica populista volta a contrastare la globalizzazione liberale e le sue (più che reali) conseguenze. Ma oltre a essere datata e consunta (il mondo non è più quello degli anni Novanta e della “fine della storia”), tale immagine caricaturale toglie molta forza alla necessità di sviluppare una mentalità tragica in un contesto segnato dalla crisi dell’ordine liberale. L’accusa di umanitarismo come chiave per accedere ai salotti di un potere che da anni – in lungo e in largo – ignora i dettami del diritto e del rispetto dell’umanitarismo e della solidarietà risulta quasi paradossale.
Un terzo elemento critico del testo, infine, non è un “difetto” ma un fattore che attiene alla visione politica che tutto il libro sottende. Una visione ampiamente legittima che finisce però per rimettere in discussione l’argomento di base dell’autore. La costante promozione e tutela dei valori dell’ordine contro il caos che emerge nell’analisi di Kaplan non è, alla fine dei conti, solo una difesa di uno status quo dal cambiamento? Se la trasformazione non è progresso ma primo passo inevitabile verso l’anarchia e “l’ordine deve essere rispettato anche se ingiusto”, che valore aggiunto può dare una sensibilità tragica se non la mera accettazione del “destino orribile” come qualcosa di naturale? Cosa vuol dire allora “ribellarsi con consapevolezza”? Da cosa è davvero composto l’ordine rispetto al quale “non sussiste alternativa”?
Sono domande che stimolano una riflessione cruciale in un’epoca instabile, nella quale aggrapparsi all’ordine appare effettivamente quasi logico e prudente alla luce del timore di sconvolgimenti e caos. Al tempo stesso occorre chiederci (cosa che il volume non fa) in che modo la (anch’essa naturale) lotta alle dilaganti disuguaglianza e ingiustizia può velocemente alterare l’ordine esistente promuovendone uno migliore. Il diffuso conservatorismo del testo, che rimpiange quella che Nanni Moretti chiamerebbe l’America conformista degli anni Cinquanta, sembra segnato, più che dallo spirito della tragedia greca, dalla volontà di preservare in ogni caso lo status quo di fronte al timore dell’anarchia.
Per Kaplan, secondo il quale “non si può correggere il mondo”, non pare esserci spazio per un reale cambiamento politico e sociale
Per Kaplan, secondo il quale “non si può correggere il mondo”, non pare esserci spazio per un reale cambiamento politico e sociale. Il punto di vista dell’autore sembra chiaro quando loda i vantaggi delle monarchie come regimi stabili, nelle quali le cose funzionano perché “la tradizione è tutto” e perché l’“autorità si nutre di un timore reverenziale”. Un timore che appare agli occhi di Kaplan non solo necessario ma in qualche modo apprezzabile. Pensiamo allora al rapporto tra regimi dittatoriali in Medio Oriente e agli effetti della cosiddetta “Primavera Araba”. Di fronte al rischio evidente di caos e instabilità (per quanto successiva al desiderio di libertà e democrazia) la soluzione prediletta è “il male minore” dell’autoritarismo? La politica di Bruxelles e Washington, nonché la riflessione di Kaplan, sembra fornire una risposta positiva a tale quesito. Una risposta che rivela un problema considerevole: tale preferenza ignora, o finge quantomeno di farlo, il rapporto diretto tra il permanere del giogo autoritario e la diffusione di violenza e terrorismo come fenomeni reattivi e speculari proprio all’esistenza stessa della costruzione autoritaria. La ricerca illustra efficacemente come i motivi che portano a far parte di gruppi terroristici nel continente africano non attengono in primis al fanatismo religioso o alla povertà ma proprio alla frustrazione, alla reazione contro la violenza e i soprusi perpetrati dalle forze di sicurezza di attori statuali autoritari percepiti come illegittimi.
Pertanto, la mera sopravvivenza di un siffatto ordine non è che il motore per lo sviluppo di fenomeni che destano, giustamente, la “nostra” preoccupazione. Restano come sottofondo, infine, due domande inevase che il libro stimola: la prudenza di fronte agli orrori della guerra e la consapevolezza del male nel mondo ci devono allora per forza spingere a combattere con una certa dose di malvagità? Ma soprattutto, il valore supremo dell’ordine quale forma di reale cambiamento consente?

Riproduzione riservata