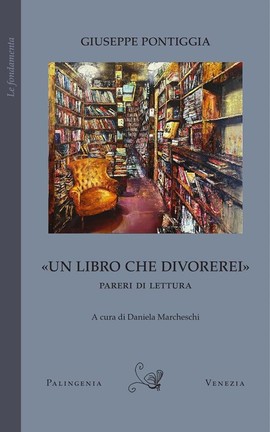Non trattenetemi, amici, lasciatemi salpare. / Non andrò lontano: solo fino all’altra sponda; / Voglio osservare da presso questa nuvola fosca / Che sorge sopra il Vesuvio ed ha forma di pino, / Scoprire d’onde viene questo chiarore strano. / Non vuoi seguirmi, nipote? Bene, rimani e studia; / Ricopiami le note che ti ho lasciate ieri. [P. Levi, Plinio, 23 maggio 1978]
Nella formazione di Valeria Parrella il patrimonio letterario classico – greco-romano – e, più ampiamente, le testimonianze superstiti del mondo antico hanno avuto una incidenza significativa. Parrella ha studiato lettere classiche all’Università Federico II di Napoli: fra i maestri che in quegli anni ne animavano le aule era Marcello Gigante, al quale si deve la rinnovata stagione della papirologia ercolanese e la sua salda organizzazione scientifica. La papirologia ercolanese riconduce a quel che resta della civiltà greco-romana fiorita alle pendici del Vesuvio e ricoperta di uno spesso strato di cenere e lapilli nell’eruzione del 79 d.C. È questo lo scenario del romanzo La Fortuna (Feltrinelli, 2022): in esso, l’institutio antichistica sostiene e alimenta la narrazione. Lucio ha diciassette anni e non vede da un occhio: potrebbe diventare senatore, ma desidera solo comandare una flotta, e a lui Plinio il Vecchio affida la sua ammiraglia quando ne scende per andare a morire osservando da presso l’eruzione del Vesuvio. Il racconto si snoda in una frizione feconda tra antico e presente. Questa frizione sembra già presente nella formazione di Parrella, che ad Annalena Benini ha raccontato (O la scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura, Rizzoli, 2018): «Io ho studiato lettere classiche e seguivo un seminario il pomeriggio di Letteratura contemporanea, che era una vergogna per noi che dovevamo diventare professori di greco, ma mi piaceva troppo». È una «vergogna» ben nota agli studenti, e talora finanche agli studiosi di lettere classiche, ma dà bene la misura di una urgenza, delle apparenti forzature, delle ibridazioni, degli attriti da cui possono nascere cose nuove.
Già nel primo libro di Parrella, Mosca più balena (minimum fax, 2003), la protagonista di uno dei racconti dice di voler fare l’archeologa, perché le sembra «una buona mediazione» rispetto ai desideri degli altri: ma in realtà vuole fare la commessa part-time alla Upim, perché «tutto quello che di interessante c’era da disseppellire, da scavare e da scoprire, le stava intorno». Il movimento tra separatezza e partecipazione, appartenenza, militanza, affiora a tratti nella produzione della scrittrice. Nel romanzo Lo spazio bianco (Einaudi, 2008) si legge: «Il tempo che mi lasciava Eschilo lo dedicavo alla riconquista delle strade, e mi pareva che ci fosse una metrica che comprendeva tutto, e che si scandiva con i passi».
La Fortuna affronta il motivo del desiderio e del limite che ad esso è connesso; della relazione fra desiderio, "che è quello che ognuno di noi muove e soddisfa", della costruzione del futuro
La Fortuna affronta il motivo del desiderio e del limite che ad esso è connesso; della relazione fra desiderio, «che è quello che ognuno di noi muove e soddisfa», e costruzione del futuro; dei confini, che in mare non esistono, per chi nuota e per chi naviga. Il limite può essere un confine netto, un discrimine urbano, fisico, e insieme interiore: nella descrizione di Lucio, sul finire del I secolo d.C. Roma «era fatta di una parte marmorea, illuminata, e di una parte infima e sporca, estesa molto più del triplo di quella splendente, dove le strade si perdevano direttamente nelle campagne, e dove si ammassava un’umanità lacera e inconsapevole, che aveva perduto la salute della terra senza acquistare l’agio della città». Ma i confini possono essere labili e forse in realtà inesistenti, come si legge in Almarina (Einaudi, 2019): «Bisogna nuotare fino al limite del mare territoriale per scoprire che una bracciata più in là è solo acqua e mare lo stesso, e che il confine non esiste». È una cosa che chi nuota molto, e nuota in mare, sa bene. La malattia stessa – come la malattia di Lucio – è un limite: in quanto ovviamente limita e riduce le possibilità, e in quanto è confine in realtà evanescente e continuamente varcato.
Come ha scritto Susan Sontag (Malattia come metafora, 1977, trad. it. nottetempo, 2020),
«La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più gravosa. Ogni nuovo nato detiene una duplice cittadinanza, nel regno dei sani e nel regno degli infermi. E per quanto preferiremmo tutti servirci soltanto del passaporto migliore, prima o poi ciascuno di noi è costretto, almeno per un certo tempo, a riconoscersi cittadino di quell’altro luogo».
Non a caso Lucio, percorrendo un sentiero in un giorno di nebbia, con la sua «debolezza di vista», vede e si prefigura la Pompei che sarà e che è oggi: non la città viva e brulicante che conosce, ma gli «interni: gli affreschi di cui erano dipinte le mura, i mosaici sotto i piedi di chi le abitava, gli orci di terracotta». Vede «i cavalli nelle stalle, e i cani stesi accanto ai padroni, vedeva gli abbracci»; vede il foro, le colonne, i forni e gli ottantuno pani nel forno. «Era – scrive Parrella – tutto vivo e immobile assieme, fermo, ciascuno, nel suo movimento». Che è una magnifica frase per descrivere quello che resta di Pompei.
L’antichità greco-romana, del resto, percorre carsicamente la produzione letteraria di Valeria Parrella. Si pensi al testo teatrale Antigone (Einaudi, 2012), che mutua titolo e forma letteraria dalla tragedia greca per riflettere sulla scelta, come si dice, del fine-vita. O in Almarina al dialogo, anch’esso vistosamente sofocleo, fra Elisabetta e Aurora, quando le due colleghe discutono della liceità della separazione fra due fratelli giunti insieme dalla Romania («No, non capisco, mi sembra disumano. Ma comunque. Mo perché non può vederlo? [...] È contro natura, questo diritto è contro natura. Quello è il fratello»); lo stesso dialogo in cui Elisabetta grida l’enorme responsabilità sociale di tutti «noi che buttiamo la carta della pizza fritta nel cestino» anziché per strada. E ancora si pensi alle pagine finali, sempre in Almarina, in cui Elisabetta si figura la donna che sarà Almarina, quando studierà farmacia, e il latino salda insieme il passato della lingua madre e il futuro che verrà
«I nomi della botanica li impara facilmente, perché pure il latino: stava già là nella voce di sua madre, solo che chi ci aveva pensato mai? E un giorno invece l’ha riconosciuto nel nome del muschio e del caprifoglio, l’ha ritrovato nelle profondità dei boschi che la videro in fuga. Nelle radici delle parole che dovette smettere di pronunciare da ragazzina c’erano gli erbari della biblioteca universitaria».
Ed è, ancora, l’indice dei passi dell’Enciclopedia delle donne, da cui emergono Catullo e Socrate, Diogene (di Sinope) e Alessandro Magno, Eros e Dioniso, Saffo e Platone, la tragedia greca e le Baccanti.
Nel romanzo La Fortuna non è incluso – e non avrebbe avuto forse senso sul piano editoriale – un indice delle fonti, letterarie ed archeologiche. Non è incluso ma avrebbe potuto esserlo: e per abitudine e prassi scientifica ho provato a costruirlo, almeno per le testimonianze scritte. Dall’Epistola VI 16, 11 di Plinio il Giovane – la lettera a Tacito – di cui è posto in esergo il passo celebre fortes fortuna iuvat (presto passato in proverbio e già attestato, pur in forma lievemente diversa, in Terenzio), all’Epigramma IV 44 di Marziale, qui citato nella traduzione di Giacomo Leopardi; dal prodigio noto alla tradizione – e attestato dalle Periochae liviane (I 39) – secondo cui il capo del neonato Servio Tullio prese fuoco quando era in culla, alle fonti intorno alla battaglia di Azio e intorno a Capo Miseno; dal resoconto dell’assedio di Gerusalemme narrato da Giuseppe Flavio al De rerum natura di Lucrezio, fino alle Selve di Stazio e al De spectaculis di Marziale, scrittore anch’egli di confine (sicché i suoi versi sono così belli «perché non è la sua lingua», scrive Parrella). E, su tutte le citazioni incastonate nel romanzo, troneggia la descrizione del vetro nella Storia naturale di Plinio il Vecchio (XXXVI 198): Plinio offre a Lucio una lente di vetro, e gli chiede di leggere su di un rotolo il passo della sua Storia in cui ha descritto il vetro, che Lucio leggerà finalmente con chiarezza. E lo scrittore aggiunge: «Ecco il caso di uno strumento che ti permette di leggere una pagina dedicata a se stesso».
A fronte di una progressiva riduzione di peso, gli studi umanistici possiedono una forza di fascinazione potente che ne spiega la fortuna editoriale e narrativa, ora più fiorente che mai
Quando Lucio vede Plinio per la prima volta, così lo descrive: «Io vedevo solo quest’uomo grosso, con i capelli grigi, scontornato dal mare e dalle sue navi, e quando si girò, e mi sorrise, dall’ampiezza del suo sguardo compresi senza incertezza che era un uomo felice. Plinio». Lucio gli chiede come ha fatto a diventare ammiraglio: forse aveva studiato, per comandare una nave? «No, io ho studiato per sapere le cose», risponde Plinio. E Lucio insiste: «E perché sei diventato ammiraglio?». «Perché sapevo le cose», risponde Plinio. Il sapere “inutile” diviene, in modo non esibito ma palese, una delle linee concettuali del romanzo: «se a un uomo così immerso nelle lettere avevano affidato un’intera flotta, a me che non avevo voglia di imparare neppure la centesima parte di quello che sapeva lui, almeno una triremi prima o poi me l’avrebbero passata». Attraverso la figura di Plinio, la separatezza degli studi diviene azione e capacità di incidere nel mondo, anche nel momento più grave. Sul finire del libro, il lettore antichista potrà interrogarsi, con Lucio, sul perché si studia: sul senso di un sapere e di un mestiere. E anche, forse, sulle ragioni per cui, a fronte di una progressiva riduzione di spazi, di peso, di prestigio culturale, gli studi classici, e umanistici in generale, possiedono una forza di fascinazione potente che ne spiega la fortuna editoriale e narrativa, ora più fiorente che mai.
Come spiega Porzio a Lucio, «Quando tutto sarà perduto, per la notte o per la tempesta o per la battaglia, devi sapere immaginare: questo fa un comandante: sa cosa succede». È qui, forse, la forza degli studi e segnatamente degli studi antichistici, che educano a ricostruire il passato a partire da frammenti: l’esercizio costante di questo sforzo immaginativo rivolto al passato può divenire, anche, capacità di immaginazione rispetto al futuro. E quando Lucio rischia l’ammutinamento dei suoi uomini dinanzi al vulcano in eruzione, riflette: «Pure saper parlare mi è servito». Anche l’addestramento alla scuola di retorica di Quintiliano, che torna alla memoria di Lucio, trova senso
«E ho capito a che serve la filosofia. A che servono le esercitazioni di retorica [...]. Sono al servizio degli altri: marinai che hanno il doppio dei miei anni sono venuti implorando perché spiegassi loro cosa stava accadendo. [...] A questo serviva quel magazzino di vite altrui che Quintiliano ci ha lasciato in dote: a orientarci quando non si vedono le stelle, come stasera».
Lucio capisce e spiega perché ha meno paura degli altri: perché ha letto Lucrezio, ha letto il VI libro del De rerum natura, ove è descritta l’eruzione dell’Etna. Cita il v. 685 del libro («E l’aria diviene vento quando l’agita e la muove una forza»), e spiega a se stesso dinanzi al Vesuvio in eruzione: «dice cose simili a ciò che abbiamo visto, e quindi forse si tratta di quello. [...] E soprattutto è già successo, già è stato cantato, e questo ci fa meno soli». È in questo homo sum il senso dell’umanesimo, che si capisce meglio e si completa nell’incastro con una riflessione parallela e opposta. In Almarina, quando pensa al confine, insieme invalicabile e inesistente come si scopre solo nuotando, Elisabetta pensa che bisogna «divellere quella spartenza iniziale a cui tanto abbiamo creduto: che si diventa professori, o condannati, o artisti, o giudici perché siamo diversi dentro. Mentre proprio lì dentro invece siamo uguali».

Riproduzione riservata