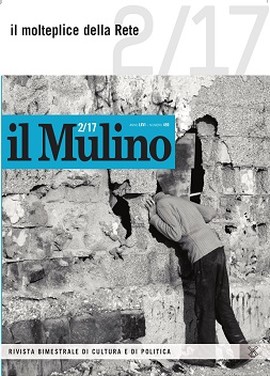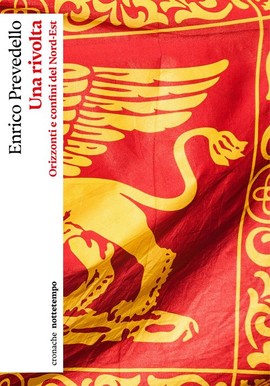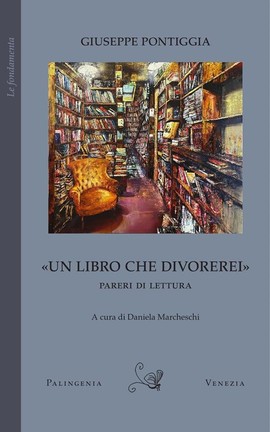Nel 2013 la Nokia commissionò uno studio sull’uso del telefono cellulare negli Stati Uniti. Dai dati raccolti emerse che in media un americano adulto controllava il proprio telefonino ogni sei minuti e mezzo. Sarà forse per questo che ora, dopo avere annunciato una riedizione del mitico 3310 – uno storico cellulare «basic», con pochi fronzoli, fatto per telefonare e al massimo inviare sms – la multinazionale finlandese sta investendo massicciamente per produrre una nuova generazione di smartphone da immettere sul mercato mondiale. Che quello degli smartphone sia un settore particolarmente ricco è evidente (nel 2015 si calcola che ne siano stati venduti circa 340 milioni di unità). Per rendersene conto non è necessario leggere i dati riportati nell’ultimo lavoro di Sherry Turkle – sociologa della scienza al Mit di Boston, già autrice di molti volumi dedicati all’impatto della tecnologia sulle nostre vite, alcuni tradotti in italiano. Basta guardarsi intorno: prendere un autobus o un treno, pranzare in un ristorante, partecipare a una riunione di lavoro o a un incontro tra genitori a scuola.
L’impatto è stato devastante da molti punti di vista, innanzitutto da quello dei rapporti tra persone, ai più diversi livelli, e sta portando a una sorta di mutazione antropologica. In particolare, in questo volume Turkle si occupa di ciò che sta accadendo alle nostre conversazioni e lo fa partendo da David Thoreau, lo scrittore statunitense esponente del trascendentalismo, l’«uomo dei boschi», di cui riporta subito in exergo questa citazione: «In casa avevo tre sedie; una per la solitudine, due per l’amicizia, tre per la compagnia». Turkle parte da qui per strutturare il suo lavoro. L’impatto dei nostri telefoni onnipresenti tocca infatti tanto la prima dimensione (quella della solitudine e dell’introspezione, del sapere restare con se stessi) quanto la seconda (la famiglia, l’amicizia, l’amore) e la terza (l’istruzione, il lavoro). Non c’è ambito, insomma, in cui la presenza di un telefono accanto a noi non modifichi profondamente il nostro comportamento sociale. E ciò accade fin dalla prima infanzia.
L’età a cui regaliamo ai nostri figli il primo cellulare si è progressivamente abbassata, e anche per i più piccoli si tratta ormai di uno strumento divenuto indispensabile in ogni momento della giornata. Le nuove applicazioni, pensate specificamente per loro, la facilità d’uso, il costo ormai abbordabile per la maggioranza delle famiglie hanno reso scontato che anche un bambino di pochi anni sia legittimato non solo a possedere ma anche a utilizzare nelle situazioni più disparate, esattamente come fanno i suoi genitori, il proprio smartphone. Le conseguenze sono forti e il tempo trascorso da quando i primi smartphone sono stati immessi sul mercato fa sì che siano disponibili molte ricerche, variamente richiamate nel libro, che tali conseguenze sottolineano.
Cominciando dalla prima «sedia» di Thoreau, sia la psicologia dello sviluppo sia le neuroscienze hanno da tempo messo in rilievo l’importanza della solitudine. Sin dalla prima infanzia, la capacità di vivere certi momenti della giornata da soli ci permette di cercare il contatto con gli altri, vedendoli però come separati da noi e indipendenti. La fase della vita in cui da bambini ci si «inventa» un gioco non è, come si potrebbe pensare, una cartolina romantica presa dagli anni Sessanta. È e resta un momento fondamentale nella costruzione dell’individuo. Inoltre, come ricorda Turkle, «la capacità di vivere la solitudine risulta essenziale allo sviluppo dell’empatia, ed è per questo che la solitudine segna l’inizio del ciclo virtuoso della conversazione» (p. 81). Una scarsa empatia avrà conseguenze rilevanti nei rapporti tra quei bambini a-lorché saranno adulti. Diventerà difficile, ad esempio, saper condividere il dolore provato da un amico per la perdita di una persona cara. È uno dei paradossi di questa nuova era caratterizzata, almeno in apparenza, da una continua condivisione con gli altri dei nostri stati d’animo. Turkle non la cita, ma viene in mente la trattazione che dell’empatia fece Edith Stein, la quale portava ad esempio il caso di un amico che ci racconta di avere perduto il fratello.
[L'articolo completo, pubblicato sul "Mulino" n. 2/17, pp. 251-253, è acquistabile qui]

Riproduzione riservata