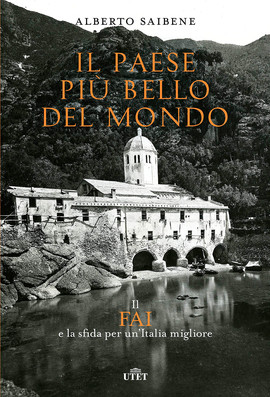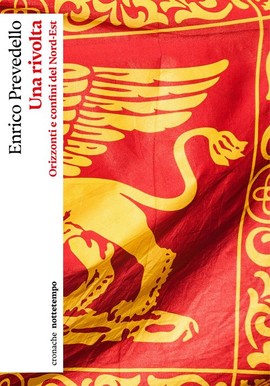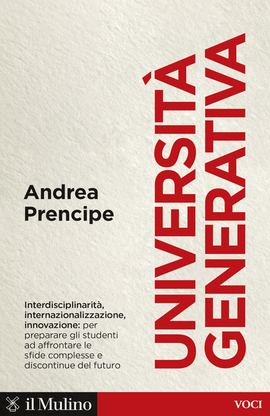Il Paese più bello del mondo è il titolo del volume di Alberto Saibene da poco uscito per Utet. Trattandosi di una storia del Fai (Fondo ambiente italiano) è un titolo che non stupisce. E che certo non può dirsi scenografico. Come sappiamo, infatti, l’Italia, insieme alla Cina, detiene il record del maggior numero di patrimoni dell'umanità dell'Unesco (a oggi sono 55 i beni nella lista). Eppure, e anche questo lo sappiamo bene anche se tendiamo a parlarne troppo poco, una tale abbondanza di bellezza ci ha spesso portati a trascurarla. O, peggio, ad abusarne.
Le distruzioni subite dal nostro Paese nel corso del secondo conflitto mondiale imposero una ricostruzione il più possibile rapida. Il grande numero di sfollati e di persone senza una casa misero in cima alle priorità della neonata democrazia uscita distrutta dalla guerra nuove abitazioni. Poco importava se a questa urgenza non si accompagnavano le necessarie pianificazioni e uno sguardo che ponesse la crescita oltre l’emergenza. Servivano case. Il grande cinema italiano di quel periodo ce le mostra bene, quelle caserme della conquistata modernità, nel loro avveniristico cemento armato sulle spianate della periferia ancora senza strade né opere idrauliche. Ben presto i danni provocati furono evidenti. La nascita del primo nucleo di donne e uomini (tra i quali due protagonisti della futura storia del Fai: Elena Croce, figlia di Benedetto, e Giorgio Bassani) che si pose la questione della tutela e della conservazione del nostro patrimonio – Italia Nostra – è del 1955.
Se, osservati oggi, quei primi anni post bellici possono trovare una giustificazione nell’emergenza, ben diverso è il giudizio che si può dare di quanto venne dopo. Il boom economico, a lungo mitizzato come un’epoca senza pari, portò con sé vere e proprie devastazioni del territorio, che non si interruppero certo neppure quando, verso la fine del decennio Sessanta, ci si accorse che il binomio sviluppo-progresso iniziava a vacillare. Proprio in quegli anni di crescente preoccupazione da parte di alcuni in merito alla conservazione di molti beni di straordinario valore storico e artistico – unitamente alla constatazione che l’assenza, in molti casi, di piani regolatori e alla forza del facile profitto stavano portando nuovi danni all’ambiente italiano, oltre a quelli della guerra – venne inaugurata una mostra, poi divenuta itinerante, alla quale si può far risalire l’origine stessa del Fai.
“Italia da salvare”, questo il titolo, esponeva una scelta delle migliaia di fotografie scattate da Renato Bazzoni per raccontare lo stato in cui versava il nostro patrimonio storico-artistico. Scriveva lo stesso Bazzoni nell’introduzione al catalogo: “I problemi della tutela, presupposto fondamentale della cultura di un Paese veramente moderno, discussi finora solo da studiosi e da tecnici, devono essere conosciuti da tutti gli italiani, perché contribuiscano a formare una coscienza storica e un costume civile di vita. Soltanto così potrà attuarsi una politica attiva e coordinata per la salvaguardia di un patrimonio culturale di valore”. Era il 1967 e sarebbero trascorsi ancora otto anni prima che il Fai venisse fondato, su stimolo di Elena Croce e iniziativa di Giulia Maria Crespi, guardando al britannico National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, creato dagli inglesi alla fine dell’Ottocento.
Il libro di Saibene riporta con molti dettagli di grande interesse – che peraltro incrociano via via le turbolenze politiche del Paese, con uno spaccato sul giornalismo italiano tutt’altro che scontato – i vari passaggi che portarono prima alla nascita del Fai, nel 1975; poi alle prime acquisizioni importanti (il Monastero di Torba, in terra longobarda; Castel Avio, in una spettacolare posizione sulla Vallagarina, ricevuto in donazione dalla nipote di Arturo Toscanini due anni dopo); via via sino al Fai delle Giornate di primavera e dei Luoghi del cuore. Ma il volume è molto di più di una storia del Fai.
Ripercorrere le vicende che hanno portato alla nascita e allo sviluppo di questa strana azienda-fondazione, infatti, è l’occasione per tracciare una breve storia dell’ambientalismo italiano che qui, al di là del suo valore documentario, mette in fila alcune questioni centrali ancora oggi, non ultima la percezione in base alla quale, in fondo, curarsi di ambiente e patrimonio culturale sia cosa per pochi: chi pena non può certo occuparsene; né da una castello o da una certosa ben conservata può ricavare alcunché (“con la cultura non si mangia”, 2010, non nacque sul nulla). La lunga battaglia per l’ambiente è in Italia una linea che si snoda su un percorso particolarmente accidentato, che sembra trovare pochissimo sostegno nell’evoluzione di stampo culturale che ci si aspetterebbe, a distanza di dieci anni dalla demolizione dell’Hotel Fuenti, l’ecomostro in Costiera amalfitana che fu costruito nel 1971 sulla base (ci ricorda Saibene) di una parere favorevole della Sovrintendenza della Regione Campania.
L’Italia di oggi è così diversa, da questo punto di vista, rispetto a quella le cui nefandezze sono state via via denunciate da persone come Antonio Cederna? Nonostante gli indubbi progressi, anche di ordine legislativo, c’è da dubitarne. Così come c’è da dubitare che il giornalismo italiano sia così diverso da quello che proprio Cederna denunciava nel 1976 in una lettera a Gaspare Barbiellini Amidei, alla vicedirezione del “Corriere della Sera”, nel lamentarsi di un suo articolo fermo in bozza da troppi giorni: “È un vecchio discorso che non coinvolge solo me ma la stessa materia di cui mi occupo, che è quasi scomparsa dal giornale, tranne per le deplorazioni in periodo di alluvioni [siamo a dieci anni esatti dalle grandi piogge del ‘66 che a Firenze portarono l’Arno fuori dagli argini, mentre ne passeranno ventidue prima delle alluvioni e della marea di fango che a Sarno uccideranno 160 persone, N.d.R.]. Sempre a rimorchio della «notizia» stramaledetta, cioè della calamità: un culto dell’«attualità» che arriva sempre a fatti compiuti e a disastri avvenuti. Un giornalismo squillo”.
Anche rispetto alla tutela del territorio e del paesaggio siamo un Paese che sembra non progredire mai, attorcigliandosi in una spirale che si dipana sempre lungo gli stessi due estremi: da un lato variamo leggi e leggine proclamandone l’impatto decisivo nel contrastare il crimine paesaggistico e ambientale, dall’altro lasciamo che la devastazione prosegua. E questo sia condonando e sanando, sia facendo finta di non accorgerci dei danni che, tra i tanti, il presunto sviluppo sta generando ad esempio ai centri storici, con un turismo di bassa qualità ma dal forte impatto nel ridefinire il volto, sempre meno ridente, delle nostre città. Resta bassa la programmazione, con un ruolo marginale per gli urbanisti e la pianificazione territoriale, senza un risvolto davvero decisivo nelle politiche urbane.
Cosicché per trovare conforto tocca riandare alle operazioni riuscite, su varia scala, da chi ha saputo per tempo prevedere i disastri della modernità, cercando di porvi rimedio. Non è un caso se, e mi sia consentito un richiamo al caso di Bologna, Saibene cita il lavoro svolto da Pier Luigi Cervellati nel 1972 per recuperare il nostro centro storico (dieci anni prima era stata la sezione bolognese di Italia Nostra a salvare dalla demolizione la chiesa di San Giorgio in Poggiale, gravemente danneggiata dai bombardamenti del '43). E ricorda come, sempre nel '72, il Club di Roma pubblicasse il suo Rapporto sui limiti dello sviluppo, denunciando l’insostenibiiltà di una crescita illimitata. Ecco, forse qui sta un altro punto importante: sapevamo tutto da tempo, sappiamo tutto da molto tempo. Eppure non siamo stati e non siamo capaci di tradurre in politiche pubbliche adeguate e in azioni concrete per ridare dignità agli anni a venire un’idea forte di paesaggio, in linea con le straordinarie innovazioni che hanno accompagnato questi lunghi decenni di ignavia.
Così, più di sessant’anni dopo la mostra che espose la fotografia-denuncia di Bazzoni, le parole che possiamo leggere di tanti che hanno denunciato tutto – come Pier Paolo Pasolini e Andrea Zanzotto, solo per citarne un paio non proprio minori – restano più che mai vere. Mentre l’Italia resta più che mai “da salvare”.

Riproduzione riservata