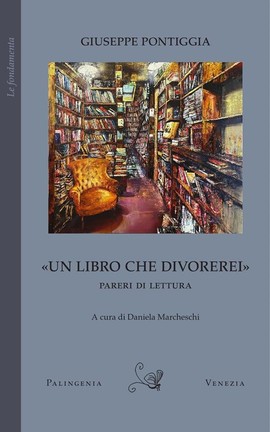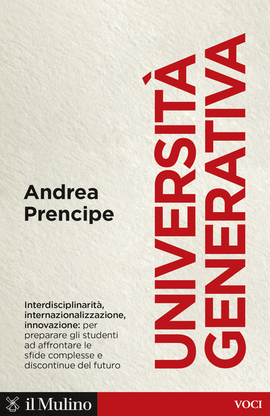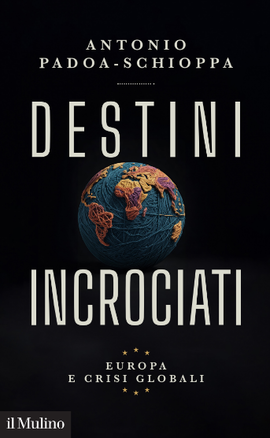L’elaborazione del passato è un processo complesso, spesso doloroso. Al nostro Paese, in particolare, elaborare il fascismo è venuto sempre difficile. Innanzitutto, per le modalità concrete con cui si venne determinando la Liberazione: a partire dalla crisi del regime che stava perdendo la guerra, con la quale una parte considerevole del vecchio Stato – monarchia in testa – tentò di accreditarsi come non insozzata da vent’anni di dittatura, dalle guerre e dalle leggi razziali. Che questo determinasse, per le scelte della Corona e di Badoglio, anche una lunghissima guerra civile, che non ebbe confronti con il resto d’Europa, è un altro elemento che rende quegli anni particolarmente torbidi e complicatissima la transizione verso la democrazia.
Di particolare interesse è la vicenda dei giuristi, un ceto che riuscì a passare, quasi scivolando, dal fascismo alle nuove istituzioni repubblicane, lavorando attivamente per neutralizzare le richieste di cambiamento che il movimento partigiano portava con sé.
Ecco perché è di grandissimo rilievo il lavoro di Massimiliano Boni, «In questi tempi di fervore e di gloria». Vita di Gaetano Azzariti, magistrato senza toga, capo del Tribunale della razza, presidente della Corte costituzionale (Bollati Boringhieri, 2022), la biografia di Gaetano Azzariti, che fu con il fascismo a capo dell’ufficio legislativo del ministero della Giustizia – quindi codificatore delle norme fasciste – e addirittura presidente del Tribunale della razza. Per poi diventare giudice della Corte costituzionale ed estensore della prima sentenza, con la quale la Corte affermò la propria competenza a giudicare anche norme anteriori alla Costituzione e, relativizzando la pericolosa distinzione tra norme precettive e programmatiche, dichiarò «l’illegittimità costituzionale della norma varata dal governo Mussolini venticinque anni prima». Ai primi del 1957 sarà eletto addirittura presidente della Corte.
La parabola di Azzariti è sintetizzata efficacemente da Boni: «Se il ramo materno [della famiglia] aveva servito i Borboni, lui ha prima servito i Savoia e poi Mussolini. E adesso che tutto è cambiato, per Azzariti in fondo non cambia molto».
Proprio per questo chi legge il libro alla fine non sa se ammirare o detestare la capacità di Azzariti di muoversi con impareggiabile destrezza tra gli ambienti ministeriali, quelli politici e la transizione dal fascismo alla Repubblica. Intendiamoci: non è moralismo. Siamo consapevoli che con un regime bisogna fare i conti e che le storie individuali vanno soppesate e comprese, non semplicemente giudicate: come la destra italiana tentò di fare decenni fa con Norberto Bobbio per ribadire che con Mussolini, in fondo, non si stava tanto male.
Azzariti fa carriera prima, durante e dopo il fascismo: Boni, con un grande lavoro di archivio, ci offre una biografia molto nitida e rilevanti sono le ricostruzioni del suo operato nel Tribunale della razza: l’autore smentisce con argomenti convincenti un suo utilizzo in chiave filoebraica («Al Tribunale non si rivolgono coloro che vogliono difendere la propria identità di ebrei, ma chi da tempo l’ha abbandonata»), smontando una mitologia diffusissima e pericolosamente autoassolutoria.
Proprio la biografia è un genere che si rivela molto delicato: una cosa è parlare dei «giuristi», altro è riferirsi concretamente a uno di essi. Per quanto sia impossibile comprendere le scelte di Azzariti se non dentro una discussione complessiva sul Paese, sul regime e sui giuristi in quanto ceto («L’autoassoluzione della magistratura è collettiva»), Boni rimette finalmente al centro dell’analisi storica la responsabilità individuale. E ne mostra limiti, astuzie, calcoli e anche meschinità.
Proprio la biografia è un genere che si rivela molto delicato: una cosa è parlare dei “giuristi”, altro è riferirsi concretamente a uno di essi
In effetti, il «metodo» Azzariti, come lo chiama Boni, riflette questa grande natura dei giuristi: «sopire, smussare, attenuare i toni» e fin qui si potrebbe anche parteggiare per Azzariti, tant’è che non mi convince – una delle poche volte in cui sono in disaccordo – la domanda se agisca più da magistrato o da politico. Perché presuppone una impossibile separazione dei due ambiti: è un tema che meriterebbe di essere approfondito. Ma Boni aggiunge sul «metodo»: «Lasciare scolorire la memoria, perché si possano dimenticare, non solo le colpe, ma anche i colpevoli, o almeno i complici». Ecco la vera accusa, ineccepibile e decisiva: il libro ci permette di osservare la parabola di un uomo impegnato ad attraversare il regime fascista «senza» porsi il problema della profonda alterazione che sta imprimendo allo Stato liberale.
È qui che si coglie con chiarezza la pericolosità della tesi del fascismo come parentesi, alla quale Benedetto Croce ha conferito dignità (si pensi alla nota polemica con Ferruccio Parri sullo Stato liberale). Ed è sempre questa impostazione che ha permesso anche il superamento del fascismo senza eccessivi traumi. Come, ad esempio, l’uso dell’amnistia e la tolleranza di tanti magistrati con i responsabili dei crimini fascisti.
Leggere il libro di Boni significa ripercorrere momenti importantissimi per il nostro Paese, ad esempio, la fondazione della Corte costituzionale e le dimissioni del suo primo presidente, De Nicola, fatti di solito confinati nella letteratura specialistica e che vengono raccontati quasi come un giallo. Ad esempio, lo scontro istituzionale di fine anni Cinquanta sul rapporto della Corte con gli altri organi dello Stato, che non è possibile considerare una semplice questione protocollare o di etichetta: «Da quando la Corte è nata i rapporti con il governo hanno sempre stentato a essere buoni». O anche le critiche, in particolare delle sinistre, che vedevano nell’offensiva contro la Corte anche un freno più generale all’attuazione della Costituzione (ad esempio le norme per le regioni e quelle sul referendum) e che, dunque, difendono la presidenza Azzariti nel contrasto contro il governo in quel momento democristiano. Con uno spettacolare e apparentemente ingenuo chissà, Boni si chiede se in questa guerra delle poltrone, come fu chiamata, un ruolo non lo giochi anche il passato (fascista) di Azzariti.
Per tutte queste ragioni mi auguro che questo libro possa costituire l’inizio di un successo per il genere, anche visto che quasi contemporaneamente Dieter Grimm ha mandato in stampa un libro dal titolo programmatico: Gli storici e la Costituzione. Si tratta di evidenziare come l’emergere della Corte costituzionale e la sua giurisprudenza abbiano contribuito a cambiare la storia del Paese, rendendolo, nel bene e nel male, quello che è. Ad esempio, nel caso italiano, con la preferenza, tutt’ora presente, della Corte per presidenze brevi, anche per evitare un certo presenzialismo che aveva caratterizzato quella di Azzariti.
C’è, tuttavia, nel libro un certo ottimismo finale che non condivido. Boni è convinto che la Storia abbia provveduto a fare giustizia, contribuendo a incrinare prima e seppellire poi il «mito» di Azzariti. Certo, negli ultimi anni, molto è stato fatto. La ricerca di Boni, però, s’inserisce nel dibattito sull’elaborazione del passato: la posta in gioco, per così dire, va oltre il giudizio su Azzariti.
Non si può negare che la casuale coincidenza della nomina del governo Meloni con i cento anni dalla marcia su Roma abbia destato qualche preoccupazione sullo stato di salute della memoria e della democrazia italiana. Si fa spesso un paragone con la Germania ma è a mio avviso improprio. Innanzitutto, perché si dimentica che diversissime sono state le storie dei due Paesi: l’Italia non fu occupata, la Germania sì. Il contributo della Resistenza è qualcosa che la ricerca ha da tempo evidenziato: diversamente anche noi avremmo avuto «solo» una Legge fondamentale, come i tedeschi, o una Costituzione ottriata, come nel caso giapponese. E del resto la stessa parabola di Azzariti si spiega ed è resa possibile solo dentro questa particolare transizione italiana.
Non si può negare che la casuale coincidenza della nomina del governo Meloni con i cento anni dalla marcia su Roma abbia destato qualche preoccupazione sullo stato di salute della memoria e della democrazia italiana
In secondo luogo, perché anche i tedeschi (occidentali) si adeguarono alle formule di giuristi rimasti confinati in una impostazione anacronistica, ad esempio con la tesi della continuità tra il Reich e la nuova Repubblica. Una discussione che animò per decenni la discussione tedesca – oggi se ne sente una eco quando si parla di un supposto colpo di Stato da parte di cosiddetti Reichsbürger – e che invece fu del tutto assente in quella italiana, dove si registra il solo intervento di Vezio Crisafulli, limitato a una ricostruzione puramente dogmatica della questione.
Queste differenze hanno poi contribuito a costruire due modelli di democrazia simili ma anche molto diversi. Non si può negare, ad esempio, che la scelta di una wehrhafte Demokratie è qualcosa di lontano dalla nostra tradizione: sarebbe stato pensabile, al di là di questioni di dogmatica del diritto, un divieto del Partito comunista da parte della Corte costituzionale?
C’è, infine, una questione che riguarda gli ultimi decenni. Quello che nel nostro Paese è avvenuto non è tanto la normalizzazione del personale vicino al Movimento sociale – ne aveva parlato Renzo De Felice in un’intervista al "Corriere della Sera" nel dicembre 1987 –, quanto l’incapacità della cosiddetta Seconda Repubblica di definire una memoria condivisa sulla quale costruire un nuovo patto nazionale proprio nel momento in cui finiva, per esaurimento dei suoi componenti, l’arco costituzionale.
Da quel momento, la memoria, più che oggetto di rielaborazione critica, è diventata strumento di identificazione identitaria per soggetti politici che una identità non avevano più. Ed è proprio l’assenza di una memoria condivisa che preoccupa per il futuro del nostro Paese, dove è quasi impossibile parlare di «patriottismo costituzionale». Ma se la memoria della Resistenza è stata più volte oggetto di discussione e analisi tra gli esperti, la sfera pubblica sembra ancora usarla più in senso identitario e politico che come base per una codificazione della storia nazionale del Paese.
Ecco perché, oltre ai risultati, anche lo stile, sempre elegante e mai rancoroso o peggio moralista, della ricerca di Boni possono costituire un contributo in questa direzione. O almeno c’è da augurarselo.

Riproduzione riservata