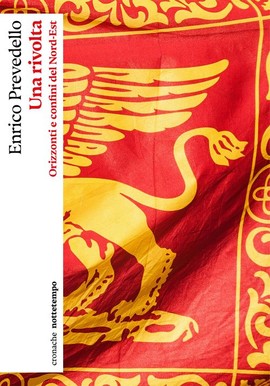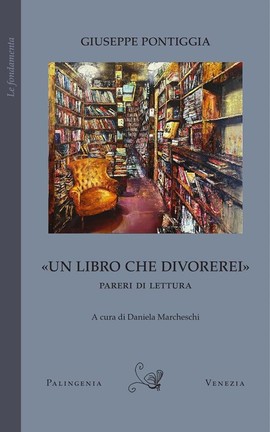Il 14 marzo del 2022, meno di tre settimane dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la rivista «Time» dedicò la copertina al «ritorno della storia» (The Return of History), illustrandola con la foto di un BMP-3, un veicolo da combattimento cingolato russo che percorreva una strada in territorio nemico. Il titolo del libro di Marco Mondini, che si apre con la citazione di quella copertina, ci parla invece di «ritorno della guerra», implicando un’equazione tra evoluzione storica e conflitti che fa dolorosamente riflettere non soltanto sul nostro presente, ma più in generale sul carattere delle «sciagure umane» che il sole illumina ormai da millenni (M. Mondini, Il ritorno della guerra: combattere, uccidere e morire in Italia 1861-2023, Il Mulino, 2024).
Mondini intraprende un coraggioso itinerario di ricerca, ricco di implicazioni non tutte lusinghiere per la vicenda storico-culturale dell’Italia postunitaria
Mondini intraprende un coraggioso itinerario di ricerca, ricco di implicazioni non tutte lusinghiere per la vicenda storico-culturale dell’Italia post-unitaria, analizzando nell’arco temporale di oltre un secolo il rapporto tra i combattenti e la morte. Il punto di partenza sono le «leggi dell’onore» ottocentesche, che costringono gli ufficiali (e in misura minore i loro uomini) ad affrontare il pericolo in maniera spesso sconsiderata dal punto di vista tattico; ma il punto di partenza è anche, per quello che riguarda la memoria collettiva del paese, la problematica rimozione delle gravi sconfitte della Terza guerra d’indipendenza – Custoza e Lissa – che si trasformò presto nel seme di un senso di colpa diffuso, e quindi nel rancore per un’umiliazione che andava riscattata a tutti i costi per dare all’Italia il posto che le spettava in Europa e nel mondo. Anche Giuseppe Cesare Abba – «uno dei cantori di maggior successo dell’epica guerriera risorgimentale […] avrebbe pudicamente rimosso Lissa e (quasi) Custoza dal regesto degli edificanti episodi di valore da raccontare ai giovani italiani» (p. 43): non si negava certo il valore degli sconfitti, ma (come Abba fa dire a un giovane reduce del 1866) «questa gloria di saper morire bastava cinquant’anni or sono, quando pochi italiani sorgevano e cadevano per mostrare appunto che si sapeva morire», non più nel momento storico in cui l’Italia deve saper vincere e gestire i frutti della vittoria (G.C. Abba, Uomini e soldati. Letture per l’esercito e pel popolo, Zanichelli, 1892 [1890], p. 247).
Abba invitava a non indulgere in una sterile «estetica della disfatta». Ma «saper morire» restava comunque una delle qualità necessarie per costruire le «magnifiche sorti» del giovane Paese: che intanto continuava a inciampare, più che a marciare sicuro, sulla strada del proprio autoproclamato destino di potenza coloniale, peraltro arrivata in ritardo all’appuntamento con lo scramble for Africa, la «spartizione dell’Africa» tra i maggiori stati europei di cui si discusse al congresso di Berlino del 1884-85. L’Italia voleva colmare il distacco e dimostrare la legittimità delle proprie aspirazioni politico-militari, ma il «fardello dell’uomo bianco» si rivelò capace di spezzare le spalle dei suoi soldati, poco esperti nel condurre le «piccole guerre» dell’età degli imperi: il 26 gennaio 1887 a Dogali, in Eritrea, i 548 uomini della colonna comandata dal colonnello Tommaso De Cristoforis vennero intercettati, circondati e massacrati da almeno 7.000 abissini al comando di ras Alula Engida, il miglior capo militare del Negus Giovanni IV d’Etiopia. Emblematica la ricostruzione dell’evento di Alfredo Oriani, che costruì in buona parte la propria fortuna sulla trasfigurazione eroica (e nazionalista, oltre che razzista) della disfatta:
«la storia italiana doveva trovarli là, allineati sulla soglia dell’Africa, nell’eroismo di un atteggiamento che il nemico stesso non aveva osato scomporre fuggendo dopo la strage […]. Quei cinquecento soldati erano l’Italia nuova. […] Non bastava morire, perché la morte era inevitabile, ma bisognava morire colla impassibilità di un orgoglio nel quale morire non è più una sconfitta, con un valore che provasse quanti africani valeva un soldato d’Italia» (A. Oriani, Dogali, in Id., Fino a Dogali , Galli, 1899, pp. 419-423).
Fantasie: come scrive Mondini, «l’unità di soccorso che era giunta sul campo di battaglia poche ore dopo lo scontro aveva rinvenuto centinaia di corpi scomposti, denudati, abbandonati a mucchi dagli abissini» (p. 64). A Oriani ovviamente la realtà interessava poco: la morte – anzi il modo «impassibile» di morire – continuava ad essere la sola prova della pretesa esistenza di un’«Italia nuova», grande anche di fronte al fallimento, in attesa di tempi migliori.
Tempi per cui sarebbe stato necessario attendere più di una generazione, visto che le avventure coloniali continuavano a regalare all’Italia solo delusioni militari, prima fra tutte la disfatta di Adua (1° marzo 1896); persino la campagna di Libia del 1911-12 non fu certo priva di ombre, e la sua conclusione poco più di un precario compromesso mascherato da vittoria. L’apoteosi del dulce et decorum est pro patria mori, da additare ai giovani come esempio, furono le offensive della Grande guerra, propagandata come compimento dell’unità della nazione: cosa a ben vedere quasi paradossale, visto che nel mare di sangue delle titaniche Materialschlachten del 1915-18 annegava la possibilità stessa del «bel morire».
Il viaggio di Mondini diventa ancora più interessante, e doloroso, quando nuove disfatte mettono gli italiani che combattono di fronte alla necessità di dare un senso al loro sacrificio
Il viaggio di Mondini continua attraverso la prevedibile retorica del Ventennio; diventa ancora più interessante, e doloroso, quando nuove disfatte mettono gli italiani che combattono di fronte alla necessità di dare un senso al loro sacrificio. La disponibilità ad accettare il rischio della morte rimane la sola via d’uscita per chi è costretto ad assistere allo sfacelo della patria: «Io ho combattuto da buon soldato», scrive ad esempio il maggiore di artiglieria Oderisio Piscicelli Taeggi, prigioniero dei britannici dopo la resa delle forze dell’asse in Tunisia (maggio 1943): «sapevo di combattere con una speranza di salvezza contro mille, ma sapevo che dovevo mettere tutto me stesso in quell’una. Poi, quando speranza non c’è stata più, ho lottato ancora per salvare almeno l’onore» (O. Piscicelli Taeggi, Diario di un combattente nell’Africa settentrionale, Longanesi, 1972 [1946], pp. 3-4).
Qui credo si possa trovare una chiave di lettura importante del saggio di Mondini. La morte è sempre uguale a se stessa, quale che sia il motivo per il quale la si affronta; farlo in maniera onorevole è la sola via per conquistare una sorta di riscatto morale, individuale e collettivo, anche nella sconfitta. Questo valore della morte come strumento di redenzione non è patrimonio esclusivo di una particolare ideologia o epoca storica: era stato attribuito ai poveri fanti di Dogali, la cui (pretesa) compostezza mentre cadevano sotto i colpi del nemico era stata intesa come segno del nuovo spirito della nazione (e della superiorità dell’uomo bianco civilizzato sui selvaggi africani); divenne tale per tutti quelli che, dopo l’8 settembre, scelsero di combattere per «una nuova Italia». Il disonore di aver partecipato alla guerra accanto al Terzo Reich hitleriano poteva essere superato, se non dimenticato, soltanto attraversando l’orizzonte terribile della morte. Quando il 23 giugno 1945 Ferruccio Parri pronunciò alla radio il primo discorso da capo del governo di unità nazionale, queste furono le parole che scelse come più adatte alla realtà nata dalla Resistenza:
«sotto la camicia fascista una nuova Italia è apparsa, un povera Italia, una Italia disperata ma ansiosa della sua libertà, ferita nel suo senso dell’onore, una Italia che ha sentito il dovere e il diritto di versare anche il suo sangue per il riscatto. Ci siamo purificati, cittadini, col sangue dei figli migliori. E il sigillo di sangue abbiamo posto sul fascismo perché ogni ponte fosse rotto ed impossibile ogni ritorno verso il passato» (cit. in Mondini, Il ritorno della guerra, p. 264).
«Feriti nell’onore», gli italiani avevano sentito il dovere di affrontare la morte per il riscatto della patria. Il «sigillo del sangue» rimane il solo capace di cancellare colpe, capovolgere il senso di inadeguatezza di una generazione, purificare la sconfitta delle sue scorie più amare, e persino «rompere i ponti» con il passato. Impossibile, per chi aveva lottato contro il nazifascismo, trovare un’altra chiave per interpretare la Resistenza. Una chiave che forse non esiste.
Questa visione rimase sostanzialmente valida per una quindicina d’anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Mondini ricorda come nell’ottobre del 1961 ben 60.000 ex partigiani sfilarono per le strade di Torino per celebrare il centenario dell’unità d’Italia, «veterani della lotta per la Liberazione che commemoravano le battaglie del Risorgimento in un’ideale continuità» di gloria, sacrificio, valore (p. 309). Ma il mondo stava cambiando in fretta. Il 24 settembre dello stesso 1961, promossa da Aldo Capitini, si era svolta la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi, a cui avevano partecipato almeno 20.000 persone, che aveva segnato la nascita del «Movimento Nonviolento»; e con una cera lungimiranza, il 5 luglio precedente, un giovane deputato del Partito comunista – Giorgio Napolitano – aveva dichiarato durante una «Tribuna politica» televisiva che «i ventenni chiedevano pace, lavoro e benessere, e non giuramenti, cannoni, caserme e inni» (p. 313).
La guerra stava uscendo dall’orizzonte del vecchio continente, e soprattutto diventava estranea, e odiosa, alla sensibilità delle sue nuove generazioni, figli e nipoti di chi l’aveva fatta e subita nella prima metà del Novecento. Nel 1977 in Italia l’obiezione di coscienza divenne «un diritto e una vera possibilità», e il 4 novembre – il nostro giorno della vittoria – venne soppresso come giorno festivo; nel 2004 «un Parlamento semideserto dichiarava finita la storia della leva» (p. 316), un tempo considerata strumento fondamentale dell’identità nazionale e della difesa della patria. L’Italia del benessere si illudeva – assieme a tante altre nazioni europee – di essere destinata a vivere in un’epoca priva di conflitti, almeno per gli happy few del vecchio continente protetto dall’ombrello nucleare americano.
Un’illusione con cui oggi siamo costretti a fare i conti: un esame di coscienza che il saggio di Mondini può rendere sicuramente più ricco e utile. Non mi resta che registrare la sola mancanza de Il ritorno della guerra : appena cinque pagine dopo aver citato gli eventi del 1961, infatti, l’opera si chiude bruscamente ricordando che nel 2022 «a pochi chilometri dalla frontiera italiana, austriaca, tedesca si moriva di nuovo a migliaia» (p. 318). Ma nei decenni che separano le due date sono successe molte cose interessanti per il tema del volume: il ritorno della brigata «Folgore» dal Libano a Livorno, il 26 febbraio 1984, accolta dal presidente-partigiano Pertini; la «battaglia del pastificio» a Mogadiscio, il 2 luglio 1993, con tre caduti italiani in combattimento; i diciannove morti dell’attentato suicida contro la base «Maestrale» del nostro contingente di pace a Nassiriya, il 12 novembre 2003; i 53 morti e 723 feriti della lunga missione di peacekeeping in Afghanistan. Tutti eventi che hanno progressivamente cambiato la percezione del ruolo delle nostre Forze Armate in un mondo dove i conflitti, qualsiasi carattere e nome avessero assunto, non erano certo scomparsi dalla storia. Anche di questa fase recente credo bisognerebbe dar conto quando si parla di «combattere, uccidere e morire in Italia»: più che una critica, un invito all’autore a completare la sua riflessione includendo anni ed eventi che credo siano decisivi per comprendere il ruolo del nostro paese, e delle nostre forze armate, nel complesso orizzonte del «nuovo disordine globale».

Riproduzione riservata