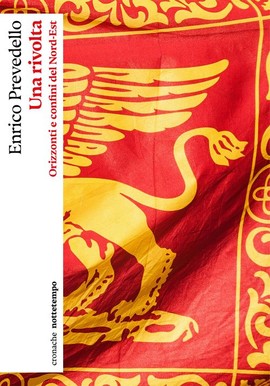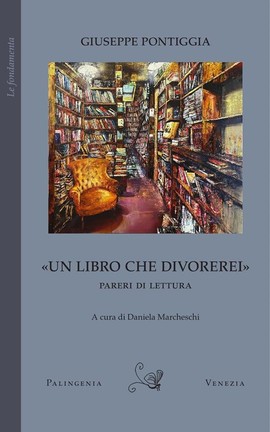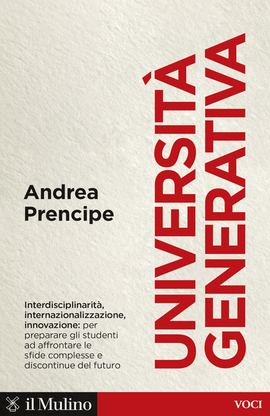Fin dall’inizio degli anni Ottanta Chiara Saraceno è stata protagonista della riflessione sulla povertà in Italia e all’estero, con saggi scientifici e interventi a convegni. Nel suo ultimo volume, Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi (Feltrinelli, 2015), la sua scrittura, tuttavia, si lascia percorrere agevolmente anche dal lettore non specialista, per la sua limpida linearità. Un risultato conseguito senza rinunciare alla più rigorosa elaborazione concettuale e alla faticosa lettura dei dati.
La complessità del tema si rivela in uno scenario immediatamente comprensibile. Essa deriva, come appare chiaro fin dalle prime pagine del libro, non dalla natura multidimensionale della povertà, con la quale pure occorre misurarsi per le sfide che pone sul piano della rilevazione empirica della povertà, ma dal carattere socialmente e storicamente determinato del fenomeno e dal fatto che esso non può essere affrontato senza tenere in debito conto le questioni relative alla libertà di scelta, alla giustizia sociale e alla natura dei sistemi democratici. Lo afferma chiaramente l’autrice quando scrive che poiché «la povertà consiste nella difficoltà, o impossibilità, di soddisfare in modo adeguato i propri bisogni nella società in cui si vive e di condurre la vita secondo le proprie aspirazioni e capacità» essa rappresenta, secondo la lezione di Amartya Sen «una forte limitazione non solo delle possibilità di consumo, ma della libertà», del «potere di decidere su di sé» e della capacità di «partecipare alla vita sociale e politica». Per questo insieme di motivi «la povertà costituisce non solo un problema morale, e neppure solo di equità e di giustizia sociale, ma anche un problema di democrazia» (pp. 31 e ss.). Di ciò del resto erano ben consapevoli i primi studiosi della povertà al punto da includere nel “minimo vitale”, come fece Rowntree ad inizio Novecento, anche il consumo di tabacco e di birra, non essenziali alla dieta giornaliera ma parte delle attività di socializzazione che consentono di mantenere attivi la stima di sé e l’interesse per la vita. Per questo motivo il ritardo con cui, rispetto agli altri paesi europei, l’Italia si accinge, sempre che voglia farlo, ad introdurre una misura di sostegno al reddito non riservata a particolari categorie di poveri, non temporanea e non limitata a particolari aree geografiche, getta un ombra sulla natura del nostro sistema democratico e sulle promesse mancate dell’articolo 38 della Costituzione che garantiva un adeguato tenore di vita a tutti coloro “sprovvisti dei mezzi necessari per vivere”. O forse è proprio in quell’articolo, e nella diversità del trattamento previsto per i “cittadini inabili al lavoro” e i “lavoratori”, che vanno ricercate le ragioni della difficoltà di fare entrare nel dibattito italiano l’idea di un reddito minimo su base universale, che non condiziona l’intervento al sussistere di qualche caratteristica familiare o individuale salvo l’insufficienza di risorse economiche, difficoltà acuite oggi dai tagli lineari alla spesa pubblica e dai sentimenti di rivalsa nei confronti dei più poveri generati dalla crisi.
Una volta acquisito questo dato generale di sfondo e avvicinando lo sguardo, si scoprono i molteplici livelli in cui il testo si articola. Sarà possibile qui soltanto citarne alcuni. Un primo livello è quello della percezione del problema, sia da parte della popolazione nel suo complesso, sia dei poveri stessi, e di come essa possa variare qualora le situazioni di povertà interessino molteplici tipi familiari (la povertà che Serge Paugam definisce “integrata”), siano limitate a pochi soggetti marginali (la povertà “marginale” appunto) o riguardino soggetti identificati come poveri in virtù del loro rapporto con l’assistenza e quindi oggetto di un processo di perdita della originaria identità di classe (la povertà “squalificata”). Un altro livello è quello della povertà minorile, tema che sta particolarmente a cuore all’autrice, la quale presenta una incidenza maggiore rispetto ad altre categorie in molti paesi europei tra cui l’Italia (dove è anche territorialmente concentrata nel Mezzogiorno e maggiormente determinata da processi di trasmissione intergenerazionale della povertà), facendo in tal modo piazza pulita di tutte le teorie colpevolizzanti dei poveri, poiché non si può accusare dei bambini di “non essere all’altezza delle sfide”, di “essersela andata a cercare”, di essere degli “scrocconi del welfare”. E qui veniamo ad un altro livello di discorso, quello appunto che dà il titolo al libro: l’occupazione, che non è sufficiente ad evitare la povertà, se si tratta di un lavoro mal pagato, saltuario, che non può essere accettato perché incompatibile con carichi di cura familiare che non possono essere condivisi o delegati ad altri, o in ragione del particolare periodo di difficoltà che si sta vivendo (l’uscita da una depressione, da un matrimonio difficile, dalla tossicodipendenza), o che semplicemente assicura un reddito di per sé dignitoso ma insufficiente rispetto al numero di persone che da esso dipendono. «Pensare che l’aumento dell’occupazione generi automaticamente una riduzione della povertà – scrive senza mezzi termini Chiara Saraceno – può essere un’illusione, se non si considera attentamente di che tipo di occupazione si tratta e chi è più probabile che benefici dell’aumento della domanda di lavoro» (p. 55). De resto, ricorda l’autrice, nell’Unione Europea il rischio di diventare povero è tre volte maggiore tra i disoccupati rispetto agli occupati, ma essere occupati non mette del tutto al riparo da tale rischio: nel 2012 poco meno del dieci per cento degli occupati viveva al di sotto della soglia di povertà relativa. E più in avanti, nel capitolo dedicato ai minori, aggiunge che «se l’assenza di occupazione degli adulti con cui vivono, o la sottoccupazione grave, è una causa diretta di povertà ed esclusione sociale per i minori, la maggior parte dei minori poveri vive tuttora in famiglie in cui almeno un genitore lavora» (p. 74).
Dunque il lavoro non basta: queste quattro parole, scelte provocatoriamente come titolo del libro, misurano in modo efficace la distanza che intercorre tra le conclusioni a cui giunge il dibattito europeo sulla povertà e la convinzione, ribadita di recente da Matteo Renzi, che la lotta alla povertà «non va condotta con aiuti e sussidi, ma creando posti di lavoro». Ci sarebbe da rimpiangere Bettino Craxi che, a metà degli anni Ottanta, con minore ottimismo e maggiore consapevolezza della specificità del problema, istituì una apposita Commissione di indagine sulla povertà affidandone il coordinamento a Ermanno Gorrieri – in seguito sarà presieduta dalla stessa Chiara Saraceno –, se non fosse per il fatto che lo stesso Craxi ne accolse con scetticismo i risultati poiché “i ristoranti erano sempre affollati”. Peccato che questo indicatore, al quale ripetutamente si ispirano i nostri presidenti del consiglio, da ultimo Silvio Berlusconi qualche anno addietro, non rientri tra quelli utilizzati dagli organismi di rilevazione statistica più accreditati.

Riproduzione riservata