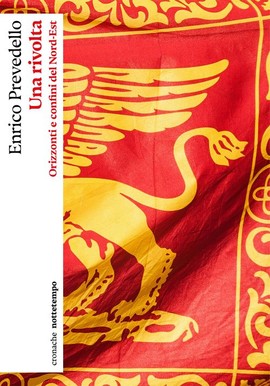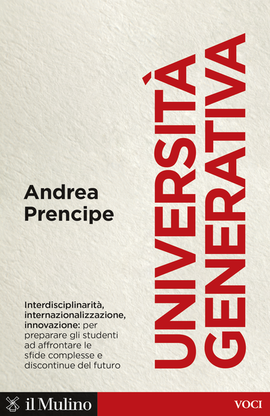Quando Raphael Lemkin, promotore della Convenzione sul genocidio del 1948, ricercava un nuovo lemma per nominare gli eccidi dell’apparato nazista, trasse ispirazione dalle riflessioni di George Eastman, pioniere della fotografia, per il marchio Kodak: «primo è breve, secondo non si presta a errori di pronuncia, terzo non assomiglia a nulla e non può essere associato che alla Kodak». Così riporta Samantha Power nel suo volume-inchiesta vincitore del premio Pulitzer: Voci dall’Inferno. L’America e l’era del genocidio (Baldini e Castoldi, 2004, p. 75). Vi si ricorda altresì che il termine fu introdotto nell’Encyclopédie Larousse nel 1953, dopo l’approvazione dell’Accademia francese; e che l’Oxford English Dictionary lo elencò per la prima volta nella sezione Corrigenda dell’aggiornamento del 1955, alla terza edizione (ibidem, cap. 3, nota 44).
Coniato originariamente in inglese, il neologismo fu il frutto della passione per la linguistica del suo inventore, un poliglotta polacco di origine ebrea. Risultò infatti dalla combinazione di due radici antiche: γένος, dal greco, che rimanda all’idea di stirpe, genere; ed ex-cìdium, dal latino, che rinvia all’idea di strage, di grande – rafforzativo ex – uccisione.
Tuttavia, prima di entrare nel linguaggio comune il termine «genocidio» fu adoperato per la prima volta da Lemkin nel contesto di un imponente approfondimento (Axis Rule in Occupied Europe) pubblicato verso la fine del 1944 e dedicato alle leggi di occupazione naziste. Il «New York Times Book Review» del 21 gennaio 1945, tra gli altri, lo recensì dedicandogli la copertina, perché «al di là del suo asciutto legalismo vi emergono i contorni del mostro che cavalca il mondo» (Marcello Flores, Il genocidio, Il Mulino 2021, p. 25). Ma questo non bastò a sdoganarlo in tempo per Norimberga. Nonostante Lemkin fosse stato assunto come collaboratore del procuratore Robert Jackson, accusatore Usa al celebre processo, riuscì solo a invocare il termine nel capo di imputazione relativo ai «crimini di guerra». Il lemma non fu adoperato per le sentenze di condanna, che si concentrarono, oltre che su questi ultimi, sui «crimini contro la pace», sull’«aggressione», e su quella che si profilò come la vera novità dell’esperienza giudiziaria: «i crimini contro l’umanità».
Per una più matura definizione del tema bisognò attendere gli anni a ridosso della fine della Seconda guerra mondiale, quando, in seguito alla costituzione delle Nazioni unite, si moltiplicarono le iniziative volte «a salvare le future generazioni dal flagello della guerra», come recita il Preambolo della Carta istituiva. In tale contesto, il 9 dicembre 1948, giorno antecedente alla proclamazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, fu approvata la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Entrata in vigore tre anni più tardi, detta Convenzione instaura un complesso sistema di prevenzione, dal quale può derivare tanto la responsabilità dello Stato quanto quella dell’individuo.
Senza indugiare in tecnicismi, è sufficiente chiarire che per sostenere un’accusa di «genocidio» occorrono tre elementi. i) Il compimento di un actus reus, ovvero di una condotta materiale rinvenibile in una serie di atti, quali, ad esempio, le «uccisioni» o le «lesioni gravi all’integrità fisica o mentale». ii) L’esistenza di un «gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso». iii) La previsione di un dolus specialis, ovvero di una volontà (mens rea) che nel caso del genocidio va al di là del semplice perseguimento dell’evento considerato – ad esempio: uccidere qualcuno – ma consiste nell’intenzione di compiere quella determinata azione al fine ulteriore di «distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale» (corsivo aggiunto).
Appare evidente che la categoria del genocidio registra due notevoli restrizioni: l’eliminazione di ogni riferimento al "genocidio culturale" e l’esclusione del "gruppo politico" tra i gruppi protetti
Già da questa sommaria descrizione appare evidente che la categoria del genocidio si concentra sommamente sul gruppo protetto, quasi spersonalizzando la vittima che qui assume rilevanza non in quanto individuo ma in quanto appartenente a una specifica collettività. Proprio quest’attenzione al gruppo avrebbe suggerito un maggiore apertura della norma, e invece nel compromesso finale si dovettero registrare due notevoli restrizioni: l’eliminazione di ogni riferimento al «genocidio culturale» e l’esclusione del «gruppo politico» tra i gruppi protetti.
Entrambe queste limitazioni sono affrontate, nel testo di Marcello Flores, con la profondità di sguardo di uno dei massimi storici di questi temi. L’esclusione del «gruppo politico» si rivelò necessaria per non incorrere nell’opposizione del blocco sovietico – il quale, dietro la critica volta alla presunta «instabilità» di tale gruppo (sic!), temeva di doverne rispondere a sua volta. Diversamente, l’eliminazione del «genocidio culturale» fu causata dall’opposizione degli Stati europei. La resistenza di questi ultimi fu motivata dalla colonizzazione. Né fu sufficiente, per vincere tali resistenze, avanzare nelle ultime fasi negoziali una proposta diretta a limitarne l’applicazione ai soli «atti violenti» in grado di cancellare l’identità di un popolo.
Precisata la genesi e la portata della Convenzione, il volume di Flores prosegue interrogandosi sulle ragioni che ne hanno determinato la tardiva applicazione (la prima condanna per genocidio è giunta solo nel 1998, nel caso Akayesu dinanzi al Tribunale ad hoc per il Ruanda). In questa parte centrale della disamina sono presenti diversi passaggi interessanti: ad esempio, sulle esperienze dei tribunali di opinione degli anni Sessanta e Settanta, spesso tralasciate negli studi specialistici, o sulla critica dei negazionisti, sul quale l’A. ha offerto un eccezionale contributo nel corso degli anni. Tuttavia il discorso ci è apparso preparatorio al vero tema intorno al quale è costruito il saggio: quello dello scarto tra la «storia del genocidio e il genocidio nella storia» (cit., p. 93). Ovvero tra la sua definizione strettamente giuridica, subordinata a una pronuncia accertamento giudiziale, e il riferimento a questa definizione in contesti diversi da quello giuridico. La questione non cessa di essere attuale. Appena il 24 aprile 2021 il nuovo presidente Usa ha rilasciato uno statement con il quale si rende onorano «all those Armenians who perished in the genocide that began 106 years ago today» (corsivo aggiunto); ed è del 22 aprile 2021 una proposta non vincolante approvata dalla House of Commons britannica senza l’avallo dell’esecutivo, con la quale si riconosce come genocidio la repressione cinese degli uiguri nello Xinjiang.
Al netto della dimensione giuridica, la domanda di Flores è la seguente: di quali genocidi parliamo, o siamo legittimati a parlare, in senso storico? Secondo l’A. la scelta di riferirsi al termine per stragi avvenute in millenni di storia sembra «coerente con le posizioni espresse a suo tempo da Raphael Lemkin e con il breve inciso che si ritrova nello stesso preambolo della Convenzione (“riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità”)» (cit., p. 135). Ma «siamo sicuri», aggiunge l’A., «che quando pensiamo ai presunti genocidi del passato abbiamo in mente la definizione che del genocidio ha dato la Convenzione del 1948?» (cit., p. 136).
La tesi sostenuta è quella di non trovare «convincente la definizione di genocidio data da molti storici a numerosi massacri e distruzioni del passato, in cui la violenza aveva sempre delle componenti (potere, ricchezza, sfruttamento, occupazione del territorio, vendetta) che venivano prima dell’identità di gruppo in quanto tale» (cit., p. 149). Come anticipato, secondo l’A. non è escluso ricorrere al termine per caratterizzare eventi anche antecedenti la previsione della medesima Convenzione, purché si tratti di atti compiuti con la precisa intenzione di distruggere, in tutto o in parte, gruppi protetti in quanto tali. Chiaramente questo pone un problema di compatibilità con la ricostruzione della figura giuridica indissolubilmente legata al rispetto del principio di irretroattività. Della questione l’A. appare consapevole, allorquando ricorda come i giuristi siano spesso restii a usare la definizione «per le epoche precedenti» (cit., p. 176). Si potrebbe obiettare che il dibattito è presente anche nell’angusto mondo di questi ultimi, come testimoniano alcuni lavori dedicati al rischio di appiattimento normativo (vedi, ad es., P. Akhavan, Reducing Genocide to Law, Cambridge University Press, 2012); o altri, dedicati a specifici problemi «storici» (sempre ex multis, vedi E. Pistoia, Una questione di identità. La lite turco-armena sul nome «genocidio» per i massacri del 1915-1916, in F. Lattanzi (a cura di), Genocidio. Conoscere e ricordare per prevenire, Roma tre Press, 2020, p. 107 ss., liberamente scaricabile qui).
Flores ritiene che la distinzione vada ricercata "nella comprensione delle tappe e della cultura che hanno reso possibile, in un contesto di guerra, la decisione di individuare un gruppo da eliminare completamente"
Tornando alle tesi del volume di Flores, posta l’esigenza di superare tanto la stretta definizione giuridica, quanto il ricorso incondizionato al termine, l’A. ritiene che la distinzione vada ricercata «nella comprensione delle tappe e della cultura che hanno reso possibile, in un contesto particolare che è quasi sempre quello della guerra, la decisione di individuare un gruppo da eliminare completamente e l’intenzione di portare a compimento nelle forme possibili quel progetto» (cit., p. 170). D’altronde è solo in questa prospettiva che è possibile comprendere, e dunque rispettare, la genesi di una definizione prodotta in un contesto, ci auguriamo, irripetibile. Ci riferiamo ovviamente alla Shoah, la cui unicità è stata determinata dall’eccezionale intreccio tra «tecnologia, ideologia razzista e burocrazia», come ben messo in luce da Z. Bauman in Modernità e Olocausto (fondatamente evocato in cit., p. 165).
Alla luce di queste considerazioni lo studio si conclude con una lista di dieci situazioni che l’A. ritiene propriamente denominabili «genocidi», a partire dall’inizio del Novecento. Si tratta di: i) herero e nama nell’Africa sudoccidentale (1905-1905); ii) Metz Yeghérn degli armeni (1915-1916); iii) Holodomor degli ucraini (1932-1933); iv) Shoah (1941-1945); v) Minoranza vietnamita, cinese e musulmana chan in Cambogia (1975-1979); vi) Popolazione maya e ixil in Guatemala (1981-1983); vii) Anfal dei curdi dell’Iraq (1988); viii) Tutsi in Ruanda (1994); ix) Musulmani bosniaci a Srberenica (1995); x) Yazidi in Iraq (2014-2019).
Come si evince da questo elenco, il «crimine senza nome», – come lo definì il premier britannico in un incontro del 24 agosto 1941 con il presidente Usa (cit., p. 19) – alla fine ha trovato una denominazione, peraltro così significativa da meritargli il titolo di «crimine dei crimini» (come indicato, non senza ambiguità, dal Tribunale ad hoc per il Ruanda in una sentenza del 4 settembre 1998 nel caso Kambanda).
Tuttavia, il dialogo con i giuristi resta aperto, e un primo confronto è atteso in occasione della presentazione del saggio, organizzata dall’Istituto di studi internazionali e dall’Alta Scuola Federico Stella sulla giustizia penale dell’Università Cattolica, il 3 maggio 2021 (per maggiori informazioni sulla possibilità di parteciparvi in modalità remota, vedi il seguente link).

Riproduzione riservata