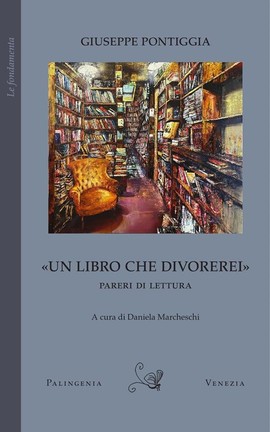Dopo un’eclissi durata almeno un quarantennio, il tema della diseguaglianza nella distribuzione del reddito è ridivenuto centrale nel dibattito di politica economica grazie alla crisi. In questo contesto, il nuovo volume di Thomas Piketty (di cui è in uscita una traduzione inglese per Oxford University Press) rappresenta certamente un contributo centrale, che orienterà la discussione dei prossimi anni.
Si tratta in effetti di un lavoro di amplissimo respiro, una sorta di trattato di economia politica nel solco dei grandi classici come Ricardo, Marx o Marshall. Una boccata d’ossigeno per la professione degli economisti, per cui la norma è oramai la corsa alla pubblicazione di articoli su riviste prestigiose, spesso con contributi di importanza marginale rispetto alla letteratura esistente. Dopo i pionieristici contributi di Simon Kuznets, negli anni Cinquanta, la distribuzione del reddito ha gradualmente perduto importanza, fino a diventare, a partire dagli anni Settanta, un tema di nicchia. Questo processo di marginalizzazione non è casuale, ma coincide con l’affermarsi della nuova macroeconomia classica. Quest’ultima, una versione moderna della teoria neoclassica prekeynesiana, riafferma la dicotomia tra efficienza ed equità su cui riposa l’economia del benessere paretiana.
In un mondo in cui ogni fattore di produzione è remunerato in base al contributo marginale alla produzione, la distribuzione del reddito è determinata dai «fondamentali» dell’economia (in particolare dalla tecnologia), e quindi esce dal campo di analisi dell’economista. Questi deve solo occuparsi di ridurre le imperfezioni di mercato che ostacolano il raggiungimento di un’allocazione efficiente delle risorse. L’equità può ovviamente essere una preoccupazione per la sfera politica; ma anche in quel caso, l’economista deve solo vegliare che la redistribuzione delle risorse si faccia senza distorcere gli incentivi degli agenti economici e dunque l’efficienza globale del sistema. Paradossalmente, mentre la distribuzione del reddito spariva dal radar degli economisti accademici, si assisteva a uno spettacolare aumento della diseguaglianza, che all’alba della crisi era tornata ai livelli degli anni Venti del secolo scorso. Un numero crescente di economisti, come ad esempio James Galbraith, Joseph Stiglitz, o anche chi scrive (J.P. Fitoussi e F. Saraceno, Inequality, the Crisis and After, «Rivista di politica economica », gennaio 2011), hanno rimesso in questione la dicotomia tradizionale, e collegato la crisi iniziata nel 2007 all’accumularsi di rendite (in particolare nel settore finanziario) e squilibri globali, tutti riconducibili all’aumento della diseguaglianza.
Il volume di Piketty, il frutto di quindici anni di ricerche, arriva quindi al momento giusto, mentre la professione si domanda se e come la distribuzione del reddito debba rientrare tra i temi di studio degli economisti. Thomas Piketty rappresenta un’eccezione rispetto alla tendenza delineata sopra, in quanto si è occupato, con un ristretto numero di coautori (Atkinson e Saez, per esempio), di distribuzione del reddito nei Paesi occidentali fin dagli anni Novanta. Le Capital au XXIe siècle rappresenta prima di tutto una poderosa raccolta di dati, che traccia l’evoluzione della distribuzione del reddito tra capitale e lavoro, principalmente in tre Paesi (Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, con estensioni ad altre nazioni) su quasi tre secoli. Rompendo con le pratiche più recenti, che utilizzavano le inchieste sulle famiglie per analizzare la distribuzione del reddito, Piketty riviene alla tradizione kuznetiana di utilizzare i dati delle amministrazioni fiscali; questi sono più adatti a catturare l’evoluzione dei redditi più alti (il famoso 1%), quelli che hanno visto l’aumento più spettacolare negli scorsi decenni. Fin dalle prime pagine Piketty ha cura di mettere in guardia il lettore su tutti i limiti che un tale esercizio comporta, soprattutto se si ha l’ambizione di costruire serie che vadano indietro nel tempo. Ciononostante, la ricchezza dei dati raccolti e il rigore con cui sono assemblati e resi comparabili rappresentano il primo pregio di un’opera che solo per questo si candida ad essere uno dei testi di riferimento per chi nei prossimi anni vorrà cimentarsi con il tema della distribuzione del reddito. A rendere il lavoro di Piketty ancora più prezioso è un sito web di accompagnamento, un’appendice tecnica dove il lettore può avere accesso a tutti i dati e ai grafici del libro, potendoli manipolare a piacimento per verificare le tesi dell’autore, o svilupparne di proprie. Piketty aveva già reso pubblico il Top Incomes Database raccolto insieme ad Emmanuel Saez e altri, e che ritroviamo tra le fonti del Capital au XXIe siècle. Così facendo ci indica quello che dovrebbe fare ogni serio ricercatore applicato, per consentire il controllo e la riproducibilità dei propri risultati.
Nella versione francese il testo ha quasi mille pagine, e si sviluppa in quattro parti. La prima, di natura più pedagogica, introduce i concetti ricorrenti nel resto del libro, come il reddito nazionale e il capitale, e traccia le evoluzioni demografiche e della produzione dalla rivoluzione industriale ad oggi. Le parti due e tre costituiscono il cuore dell’opera. La seconda parte si concentra sull’evoluzione di lungo periodo del rapporto tra capitale e reddito nazionale, partendo dai Paesi per cui esistono dati di migliore qualità (principalmente Francia e Inghilterra). Piketty estende poi progressivamente, e compatibilmente con i dati disponibili, l’analisi al resto dell’economia mondiale. Nella terza parte si analizza l’evoluzione storica della distribuzione tra capitale e lavoro, ma anche all’interno dei redditi da lavoro. Particolarmente interessante, ai fini dell’argomentazione successiva, è il capitolo sul ruolo della trasmissione ereditaria nel perpetuare e amplificare la diseguaglianza. L’ultima parte, il cui obiettivo è quello di trarre le lezioni politiche e normative dall’analisi precedente, è coerente con la convinzione di Piketty che la storia della distribuzione del reddito non obbedisca a tendenze spontanee dell’economia, ma che sia piuttosto il riflesso «di una storia profondamente politica ». In questa parte si analizzano possibili soluzioni di politica economica alla crescente diseguaglianza del reddito. Piketty ritorna su possibili modi di ripensare la progressività della tassazione sul reddito, e propone «l’utile utopia» di un’imposizione mondiale sul patrimonio che serva da riferimento per l’elaborazione di proposte più realiste soprattutto su scala europea.
Questa parte, e il volume, si concludono con un’analisi del debito pubblico, e dell’accumulazione ottimale del capitale pubblico. Piketty parte da una osservazione aggregata: il rapporto tra capitale e prodotto nazionale (il Pil, per intendersi) è stato elevato fino alla Prima guerra mondiale, per poi calare drasticamente (si è circa dimezzato, passando per esempio in Francia da un valore di 7 a meno di 3) per i successivi cinquant’anni. A partire dagli anni Settanta, il rapporto ha ricominciato ad aumentare per raggiungere, alla vigilia della crisi del 2007, praticamente gli stessi livelli degli anni Venti del secolo scorso. Questa traiettoria ad U del rapporto tra capitale e prodotto vale per la Francia, per gli Stati Uniti e per il Regno Unito, così come per le altre economie analizzate da Piketty, nonostante traiettorie storiche e politiche estremamente diverse. È in altre parole una dinamica che sembra prescindere dalle specificità nazionali.
Utilizzando un quadro analitico estremamente intuitivo, Piketty mostra che la parte dei profitti sul reddito nazionale interagisce con il rapporto tra capitale e prodotto. L’argomento di Piketty si regge su una diseguaglianza fondamentale, per cui il tasso di rendimento sul capitale è superiore al tasso di crescita dell’economia (r > g); questo vuol dire che in ogni periodo al capitale andrà una quota crescente del reddito nazionale; questo surplus a sua volta sarà investito e andrà ad aumentare la quota di capitale sul prodotto, in un processo che si autoalimenta potenzialmente all’infinito. I patrimoni ereditati si ricapitalizzano quindi più in fretta di quelli di nuova costituzione, legati al lavoro e alla produzione: «il passato divora il futuro», per utilizzare l’efficace espressione dell’autore, che fa riferimento al «dilemma di Rastignac» del Père Goriot di Balzac: a che pro lavorare duro, se si può migliorare la propria posizione di molto sposando una ricca ereditiera? Infine, essendo il reddito da capitale più concentrato di quello da lavoro (la quota di capitale detenuta dal 50% più povero della popolazione è praticamente nulla), la tendenza di lungo periodo all’aumento della quota del capitale sul reddito nazionale comporta anche un marcato aumento della diseguaglianza nella distribuzione personale del reddito.
Prima di passare all’analisi del punto centrale di Piketty sulle tendenze di lungo periodo delle economie sviluppate, vale la pena di menzionare un punto che rimane marginale nel discorso dell’economista francese, ma che è rilevante per l’Italia. Il quadro analitico di riferimento implica che un Paese con risparmi elevati e crescita lenta accumuli, nel lungo periodo, un enorme stock di capitale e tenda, quindi, ad avere una diseguaglianza crescente. La tendenza verso una sempre maggiore concentrazione dei patrimoni, evidenziata a più riprese dalla Banca d’Italia, sarebbe quindi un fenomeno strutturale e legato alla bassa crescita del nostro Paese. Ma veniamo al punto centrale di Piketty, che si riassume in un solo grafico (il 10.10, p. 565). Piketty mostra che il rendimento del capitale è storicamente stato nell’ordine del 4-5%, mentre il tasso di crescita si situava tra l’1,5% e il 2%. La diseguaglianza fondamentale r > g ha quindi delle solide basi empiriche. Lo stesso grafico ci mostra poi che il cinquantennio 1920-1970 rappresenta effettivamente un’eccezione, con tassi di crescita più elevati e superiori al rendimento del capitale. La spiegazione per questo periodo «anomalo» risiede secondo Piketty nell’operare congiunto di due guerre, che hanno provocato distruzione di capitale fisico, e di una crisi economica senza precedenti, quella del 1929, che ha fatto volare in fumo patrimoni spesso vecchi di secoli. Questo ha spezzato l’interazione tra accumulazione del capitale e rendimento descritta sopra, «azzerando i contatori» e consentendo una riduzione significativa della diseguaglianza accompagnata da forte crescita e da convergenza economica tra i differenti paesi; in altre parole, un’età d’oro dell’economia mondiale. Ma a partire dal 1970 le due curve si incrociano di nuovo, e i tassi di rendimento del capitale ridiventano più elevati del tasso di crescita; siamo rientrati in una fase storica in cui la trasmissione ereditaria è più efficace del lavoro per produrre ricchezza. La conclusione di Piketty è quindi tetra, una sorta di catastrofismo della ragione: il recente aumento delle diseguaglianze, che tra le altre cose ha portato alla crisi del 2007, non è un’anomalia, ma un ritorno alla norma. L’eccezione è il cinquantennio d’oro 1920-1970. Se si legge il volume di Piketty alla luce del recente dibattito sulla «stagnazione secolare», lanciato da Larry Summers nell’ottobre 2013, il pessimismo sembra più che giustificato. La tendenza dei tassi di crescita di lungo periodo a ridursi sostanzialmente (per motivi demografici, di ritmo del progresso tecnico, e altro) contribuirebbe ad alimentare l’aumento della diseguaglianza, che a sua volta sarebbe causa di riduzione del tasso di crescita di lungo periodo (mi permetto di segnalare le mie riflessioni: Reduce Inequality to Fight Secular Stagnation, pubblicate sul mio blog il 22.12.2013).
Il lettore arriva quindi alla terza parte di questo trattato di economia politica in preda a foschi pensieri. Ma per fortuna l’autore indica una serie di possibili misure di politica economica, coerenti con la sua convinzione che l’aumento della diseguaglianza abbia poco a che fare con tendenze «naturali» dell’economia, e molto con processi politici e appropriazione di rendite importanti da parte delle élite. In primo luogo, Piketty reclama un ritorno a sistemi di imposizione più progressivi, invertendo la tendenza alla riduzione della progressività in atto dagli anni Settanta. Più specificamente, Piketty reclama delle politiche economiche in grado di ridurre il rendimento del capitale fino a farlo coincidere con il tasso di crescita dell’economia. Un’imposta globale sui patrimoni sarebbe la soluzione ideale, per evitare concorrenza tra i paesi e, soprattutto, avvicinarci ad una specie di stato utopico di «capitalismo senza i capitalisti », in cui una tassazione di tipo confiscatorio interviene ogni volta che l’attività imprenditoriale si trasforma, a causa della concentrazione della ricchezza, in accumulazione di rendite. Al lettore che si chiede se un fisco confiscatorio sia compatibile con il capitalismo e la libertà di impresa, Piketty ricorda che precisamente nell’età d’oro degli anni Quaranta e Cinquanta, caratterizzata da crescita e innovazione tecnica, gli Stati Uniti avevano tassi marginali di imposizione vicini al 90%, il cui effetto non era tanto quello di rimpinguare le casse dello Stato, ma di disincentivare rendite eccessive e remunerazioni spropositate rispetto all’effettivo contributo alla produzione dell’impresa. Il lettore italiano, alla luce dei dibattiti sulle faraoniche remunerazioni di manager pubblici e privati, dovrebbe essere particolarmente sensibile a questo argomento.
In conclusione, Piketty ci offre un saggio di grande spessore culturale, nel quale il pessimismo analitico è compensato dall’ottimismo quanto alla capacità della politica di alterare i processi in corso. Anche se l’età d’oro del XX secolo emerge come un’eccezione, l’economista e il cittadino Piketty non rinunciano a porsi l’obiettivo di ritrovarne le dinamiche economiche e sociali. E la sfida di creare un capitalismo senza rendite sembra affascinante in un periodo in cui la rendita (particolarmente per noi italiani) sembra essere tornata ad essere il motore principale del benessere e dell’arricchimento. Certo, un’opera così ambiziosa non può essere esente da difetti. Per esempio, è stato da molti rimarcato come il persistere di rendimenti del capitale elevati sia in contrasto con una tendenza del capitale a divenire sempre più abbondante, e quindi in teoria sempre meno produttivo. L’argomento di Piketty, quindi, ha una debolezza analitica importante e riposa essenzialmente su una regolarità empirica. Ma credo che riguardo a questo punto venga in soccorso dell’autore proprio la sua definizione di capitale, che, sinonimo di patrimonio, comprende capitale produttivo e improduttivo. Se è vero che un’accumulazione importante di beni capitali in senso stretto (l’investimento produttivo, per intendersi) tenderebbe a farne calare i rendimenti nel lungo periodo, se l’accumulazione si concentra su capitali di rendita (la terra in passato, i capitali finanziari e immobiliari oggi), e se in aggiunta il processo politico consente alle élite di estendere le loro rendite (come è avvenuto in tutta la prima fase dello sviluppo industriale, e come sembra avvenire di nuovo oggi per il famoso 1%), allora la quota crescente del capitale può essere compatibile con rendimenti non decrescenti e superiori al tasso di crescita dell’economia. L’investimento in attività «improduttive» tra l’altro contribuisce a sottrarre risorse utili all’economia e a deprimere il tasso di crescita.
Altri mi sembrano essere i difetti del Capital au XXIe siècle: Ad esempio, il parallelismo tra oggi e i primi anni del XX secolo regge fin tanto che non si considera il capitale sociale. L’età d’oro ci ha lasciato in eredità dei sistemi di istruzione, di salute pubblica, di protezione sociale, che non esistevano in precedenza, e che costituiscono un capitale sociale di cui Piketty parla pochissimo. Inoltre, la proprietà del capitale, pur restando concentrata nei decili superiori, è oggi molto più diffusa di quanto non fosse in passato. E la mobilità tra decili (se non tra centili) è maggiore che all’inizio del XX secolo. Certo, il recente aumento delle diseguaglianze si è fatto anche attraverso un ridimensionamento del capitale sociale. Ma sarei curioso di conoscere la prospettiva dell’autore sul ruolo della diffusione della ricchezza, e del capitale sociale, sia rispetto ai processi in corso, sia rispetto alle soluzioni di politica economica che vengono prospettate.
Riguardo alle soluzioni, nonostante il fascino dell’«utile utopia», sarebbe stato desiderabile che Piketty non si limitasse alle politiche fiscali, ma esplorasse altre possibili politiche. Per esempio, sarei stato curioso di conoscere la sua opinione sulla cosiddetta economia della partecipazione, vale a dire sulla partecipazione del lavoro agli utili da capitale. Ma più che di difetti, si tratta di interrogativi, che il lavoro di Piketty ha il merito di stimolare. E che, ne sono sicuro, saranno discussi in futuri lavori altrettanto rigorosi e importanti.
Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013, 970 pp.

Riproduzione riservata