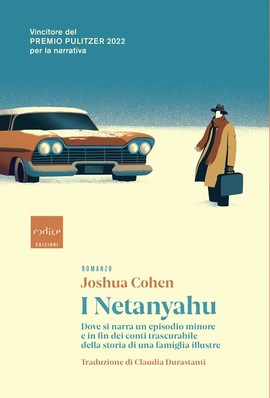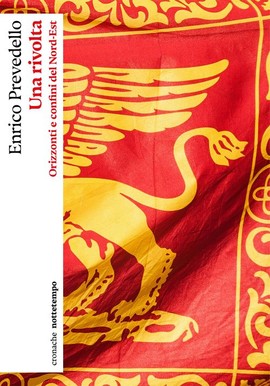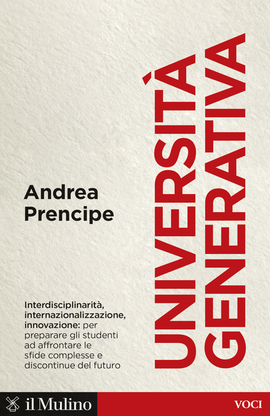Nell’estate del 2018, un venerdì di giugno, Joshua Cohen andò a trovare Harold Bloom nella sua casa di New Haven. Erano passate poche settimane dalla morte di Philip Roth, dettaglio che qui ha un suo peso, e l’invito era arrivato direttamente, con un’e-mail, dal mostro sacro della critica letteraria, che, a 88 anni, sentiva di avere qualcosa da dire a quel giovane, o quasi giovane, scrittore ebreo americano. Di quell’incontro Cohen avrebbe scritto un resoconto, a stretto giro, sulla "Los Angeles Review of Books": “Veniamo da un retaggio simile, Joshua, ma ricorda: le nostre vite sono separate da mezzo secolo,” gli disse Bloom. “Tutti gli scrittori della mia generazione ormai se ne sono andati.” Dove per “scrittori” Bloom intendeva “scrittori ebrei americani” e per “generazione” intendeva quella, appunto, di Philip Roth e Joseph Heller, coetanei di Bloom, ma anche di Saul Bellow e Bernard Malamud, di un decennio più anziani, insomma una generazione con cui è difficile confrontarsi (non ci metto Chaim Potok perché Bloom, che pure ne curò edizioni critiche, lo considerava un autore minore). Ma, soprattutto, una generazione che è entrata a fare parte della cultura americana partendo da una posizione di outsider, quando gli ebrei erano ancora un gruppo socialmente distinto, e respinto, con codici culturali e linguistici altri, un piede a New York e l’altro ancorato in uno shtetl dell’Europa orientale. “La mia prima lingua era lo yiddish, l’inglese non era ancora arrivato nella nostra casa, e neppure nella nostra zona del Bronx,” racconta Bloom.
Ora, premiamo il tasto fast forward fino al 2021. Quando si scopre che, in quella chiacchierata a New Haven, Harold Bloom ha raccontato anche qualcos’altro, di cui non c’era traccia nel resoconto sulla “L.A. Review”. Pare che, quando era un giovane professore a Yale, a Bloom fu affibbiato il compito di “coordinare una visita nel campus di uno sconosciuto storico israeliano di nome Ben-Zion Netanyahu,” ovvero il padre del futuro primo ministro Benjamin Netanyahu. E lo scopriamo perché Cohen ci ha scritto un romanzo, delizioso e perturbante, che poi ha vinto il premio Pulitzer: I Netanyahu. Dove si narra un episodio minore e in fin dei conti trascurabile della storia di una famiglia illustre. In Italia arriverà il 7 settembre, tradotto da Claudia Durastanti e pubblicato da Codice.
Se il titolo è I Netanyahu, al plurale, un motivo c’è. Il romanzo, densissimo e relativamente breve (poco più di 250 pagine), ruota attorno all’intero clan dei Netanyahu, e allo sconvolgimento che portarono, in appena pochi giorni, in una tranquilla cittadina universitaria americana. C’è Ben-Zion, descritto come uno storico che si sente in missione per conto di Dio, o meglio del popolo ebraico, dalle credenziali accademiche controverse, tanto basate più sull’ideologia che sui fatti sono le sue ricerche, almeno nella ricostruzione che ne fa Cohen. C’è sua moglie Tzila, personificazione della yiddish mame invadente, e ci sono i tre figli: Yonathan, il futuro eroe martire, che sarebbe morto guidando la missione per liberare gli ostaggi a Entebbe nel 1976, e qui rappresentato come un adolescente dongiovanni; Benjamin, il figlio di mezzo, il futuro primo ministro che tutti conosciamo, il più famoso della famiglia, ma che nel romanzo funge per lo più da spalla di Yonathan; e infine Ido, il minore, destinato a diventare medico e poi autore teatrale senza infamia e senza lode, qui in veste di ciclone col pannolino.
Al clan dei Netanyahu, tutti personaggi storici, sono affiancati altri personaggi che strettamente storici non sono, anche se non è difficile capire a chi siano ispirati. A partire dal protagonista, un tale professore Ruben Blum, alter ego di Harold Bloom, che però è un economista, non un critico letterario, e non insegna a Yale, ma in un immaginario college di medio prestigio. La dicotomia tra Netanyahu, nel senso di Ben-Zion, e Blum (o Bloom?) è il perno su cui ruota la vicenda. Da un lato l’aggressività e l’ossessione persecutoria di Netanyahu, figlio del Sionismo revisionista, di destra, che fu di Ze'ev Jabotinsky, in quegli anni relegato ai margini della vita politica e intellettuale israeliana ma destinato a diventare maggioritario nel tempo. Dall’altro lo spaesamento di Blum, accademico di successo, certo, ma di successo recente; professore rispettato, ma ancora guardato dall’alto in basso dai suoi colleghi, che appartengono all’élite anglosassone protestante, e infatti si sentono d’imporgli di fare da anfitrione a uno storico israeliano, perché, questo il sottotesto, tra voi ebrei vi capite. Netanyahu è pervaso da un senso di precarietà esistenziale, Blum da una precarietà sociale, entrambi sentimenti molto ebraici, il timore dell’annientamento, da un lato, e dall’altro la paura di essere ricacciati nei ghetti da cui si era appena usciti: è lo scontro tra l’israeliano e l’ebreo della diaspora.
Ma c’è un’altra tensione, più sottotraccia, che si fa sentire: la contrapposizione, più o meno implicita, tra cosa significa essere ebrei in America oggi e cosa significava esserlo ieri, l’antitesi tra l’identità di chi scrive e l’identità di chi è descritto.
Blum incarna un momento liminale dell’esperienza ebraica in America, quando gli ebrei cominciavano a non essere più, o prevalentemente non più, relegati ai margini della società ma non erano ancora pienamente accettati a fianco dei protestanti anglosassoni, tanto che il lettore noterà tracce del mondo di Pastorale Americana, o quello di Ombre sullo Hudson. Era l’epoca in cui sono cresciuti Philip Roth e Harold Bloom. Non è, evidentemente, il mondo di Joshua Cohen, che, classe 1980, è cresciuta in un’America dove gli ebrei, o, meglio, un certo tipo di ebrei laici, colti e benestanti, erano già perfettamente integrati nel tessuto socio-economico e dove, in alcuni campi, come appunto la letteratura, alcuni codici dell’identità ebraica erano addirittura permeati al di là della loro giurisdizione (basti pensare all’utilizzo che David Foster Wallace, già una generazione prima di Cohen, faceva della parola yiddish “nudnik”).
Cohen fa parte della stessa leva di scrittori ebrei americani che ha prodotto Shalom Auslander (1970); Jonathan Safran Foer (1977), Gary Shteyngart (1972), Rivka Galchen (1976) e Ben Lerner (1979) e che potremmo definire la prima generazione di scrittori cresciuti in un’America, in una certa America, dove l’identità ebraica era interamente normalizzata. In alcuni di questi autori c’è una marcata spinta a giocare con i modelli che li hanno preceduti, non una ma due generazioni prima, a confrontarcisi, a rivisitare l’identità ebraica con la sua alterità, che oggi è sempre meno un’alterità, o che, forse, lo è in modo più sottile. E’ precisamente quello che fa Cohen, ne I Netanyahu, quando mette in scena lo scontro-incontro tra Ben-Zion Netanyahu, il padre del premier che avrebbe plasmato l’Israele di oggi, e l’alter ego di Harold Bloom, il raffinato intellettuale nato in un East Bronx dove ancora si parlava yiddish. L’unica pecca, che non è gran cosa, sta nell'avere messo un po’ troppa carne al fuoco, nell’ansia di dire molto, e forse spiegare un po’ troppo, in poco spazio.
Dell’opera di certi poeti Bloom diceva che si faceva sentire l’angoscia dell'influenza, un rapporto irrisolto con l’eredità lasciata dai loro precursori. Lo stesso si potrebbe dire di certi scrittori contemporanei e, tra questi, Cohen è senza dubbio uno dei più brillanti.

Riproduzione riservata