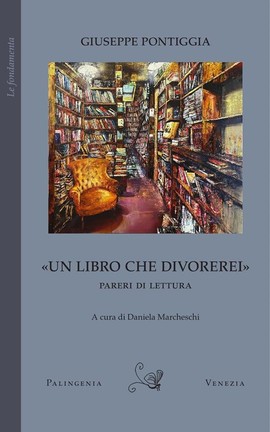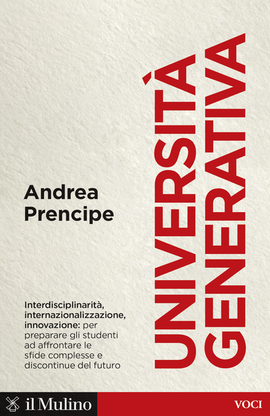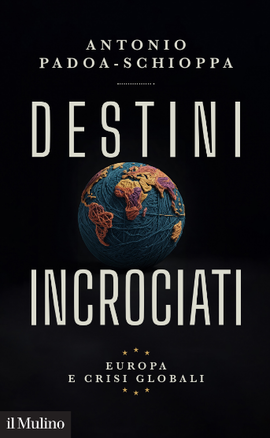Lo sguardo della differenza femminile sul carcere che Susanna Ronconi e Grazia Zuffa mettono all’opera in Recluse (Ediesse, 2014) è duplice: da una parte è il punto di vista sulla propria condizione delle donne detenute che vi sono intervistate, dall’altra è la chiave di lettura delle autrici sull’istituzione penitenziaria e le sue prospettive.
Il libro nasce come una ricerca sull’autolesionismo in carcere, si sviluppa come un’analisi del vissuto femminiledietro le sbarre e, infine, restituisce una immagine nitida e veritiera della realtà detentiva. I nessi sono evidenti ed esplicitati dalle autrici. Il fenomeno del suicidio e dell’autolesionismo in carcere da cui parte il lavoro (rielaborazione di una ricerca condotta da La Società della Ragione per conto dell’Azienda Usl 10 di Firenze) sono osservati da una prospettiva ecologica. In questa chiave, il carcere si presenta come un ambiente a rischio in cui si sommano le precarietà esistenziali pregresse delle persone detenute e una pluralità di fattori di stress legati alla stessa privazione della libertà. In un’ottica di prevenzione, il fuoco della ricerca si sposta quindi sul contesto penitenziario, sulle condizioni di vita di chi vi è costretta e sulle relazioni che ne determinano la quotidianità. Così la ricerca diventa uno scavo nella realtà del carcere. La prospettiva della differenza di genere consente di mettere in luce le ambivalenze del modello correzionalista-trattamentale cui ancora si ispira la concezione progressista della pena detentiva.
L’universo penitenziario femminile continua a essere quantitativamente marginale (2354 su 54122 all’ultimo rilevamento, poco più del 4%), così come – almeno in Italia – quello minorile, con circa 400 ragazze e ragazzi detenuti. Eppure ad essi, al carcere femminile e a quello minorile, dobbiamo la radice del modello correzionalista, l’idea – cioè – che la pena possa essere utile a “correggere” e a “recuperare” il deviante. Nelle testimonianze delle donne intervistate è però evidente la scissione tra l’esecuzione della pena detentiva e le prospettive del reinserimento sociale di ciascuna di loro. Il carcere appare un deserto da attraversare piuttosto che uno strumento di empowerment per il futuro. Esso è un accumulatore di fattori di stress, da quelli apertamente negativi (l’impatto con l’istituzione totale e la spersonalizzazione, il tempo vuoto, la perdita o la distanza degli affetti, la difficile cura di sé e del proprio corpo) a quelli ambivalenti, legati alle complesse relazioni con le altre detenute e con il personale penitenziario. Le misure alternative, un lavoro all’esterno, appaiono come eventualità improbabili, cui certo orientare atteggiamenti saggiamente opportunistici, ma su cui non fare troppo affidamento.
L’immagine che ne viene è quella di un sistema inefficace, in cui gli effetti collaterali del farmaco somministrato sono di gran lunga preponderanti rispetto a quelli promessi dalle sue indicazioni terapeutiche. La rieducazione è un miraggio oscurato dalla difficoltà di mantenere un equilibrio e una padronanza di sé senza la quale sarà impossibile qualsiasi duratura forma di reinserimento sociale.
Pur essendo il prodotto di una ricerca svolta negli anni più difficili del sovraffollamento penitenziario, esso è solo sullo sfondo, quasi non toccato da quel duplice sguardo, delle detenute e delle autrici. Sì, certo, la penuria relativa di risorse umane e strumentali che il sovraffollamento porta con sé hanno aggravato le condizioni di vita in carcere, riducendo l’offerta trattamentale e le possibilità di un tempo di detenzione significativo nel potenziamento del sé. Ma lo sguardo critico della differenza femminile non si ferma alle conseguenze del populismo penale in termini di incarcerazione di massa e investe direttamente il modello penitenziario rieducativo. Quest’ultimo aggiunge alla spersonalizzazione della istituzione totale la infantilizzazione della persona detenuta, destinataria di un trattamento paternalistico che ne sminuisce le capacità, invece di investire su di esse. Si affaccia, quindi, una critica radicale della privazione della libertà e il pensiero va a possibili alternative a quella tradizionale modalità di esecuzione della pena.
Ma, intanto, nella parte conclusiva il libro è ricco di indicazioni operative per un diverso trattamento delle persone detenute. Indicazioni rivolte sia agli operatori che alle istituzioni, sia al legislatore che alle amministrazioni competenti, dal superamento di anacronistici vincoli ai colloqui e alle relazioni familiari alla valorizzazione del personale e delle stesse detenute nel sostegno reciproco e nella promozione di attività per il reinserimento sociale. Fedeli alle loro competenze nel campo delle dipendenze, le autrici ci accompagnano quindi sulla strada della riduzione del danno del carcere. Finché non riusciremo a farne a meno, il modo migliore per conviverci.

Riproduzione riservata