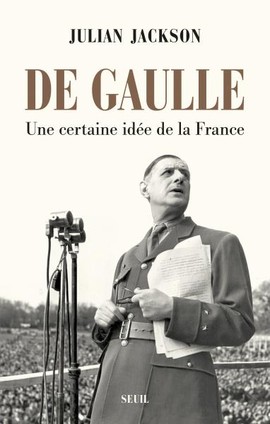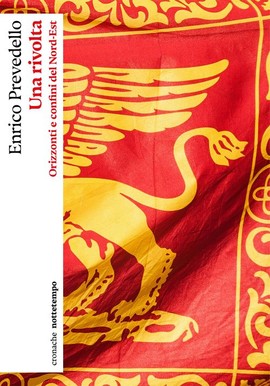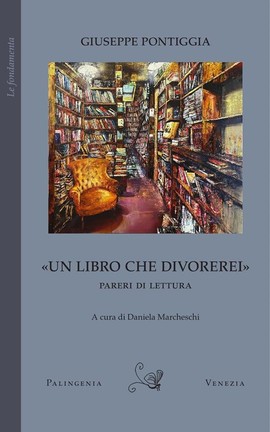Con un Emmanuel Macron a livelli di popolarità bassi come sono stati soltanto quelli in epoca di “febbre esagonale” da gilets jaunes (autunno 2018-primavera 2019) e con voci autorevoli che criticano le istituzioni della V Repubblica (di recente Jean Garrigues e Pascal Ory su “Le Monde” oppure Jacques Julliard e Édouard Balladur su “Le Figaro”), immergersi nelle oltre ottocento pagine del monumentale De Gaulle di Julian Jackson (De Gaulle, une certaine idée de la France, Seuil, 2019; prima edizione Penguin Books, 2018) ha un significato ancora più rilevante. Inutile soffermarsi a dire che il libro è documentatissimo e si mantiene in equilibrio sapiente tra indagine d’archivio e confronto con la storiografia francese, europea e mondiale sulla figura del generale de Gaulle. E quasi superfluo è aggiungere che, nonostante la mole, come spesso accade per le biografie di autori anglosassoni, il libro si fa leggere con la scorrevolezza di una spy story.
Occorre invece aggiungere che Jackson riesce a offrire spunti originali, nonostante dal 1984 ad oggi (data dell’uscita del primo volume dell’altrettanto monumentale biografia di de Gaulle scritta da Jean Lacouture) almeno altri quattro notevoli lavori sono stati pubblicati: i tre tomi di Lacouture, l’ottima opera di Eric Roussel, quella di Michel Winock e naturalmente De Gaulle e il gollismo di Gaetano Quagliariello (con una menzione per il più agile Brizzi-Marchi, pubblicato per il Mulino a cinquant’anni dalla nascita della V Repubblica).
La prima interessante originalità del volume di Jackson si concretizza nelle pagine conclusive, quelle dedicate alla riflessione sul mito del generale, sulla continuità del suo ricordo, che spinge “Le Monde” nel novembre 2010, dunque quarant'anni dopo la sua morte, a definire i francesi “ancora e sempre orfani di de Gaulle”. Centratissime sono due citazioni che lo storico britannico riporta, entrambe relative alle giornate del lutto del novembre 1970, quando la Francia si scopre sola, senza il “suo generale”. Scrive Claude Lanzmann, colonna portante di “Les Temps modernes”, intellettuale vicinissimo a Sartre e Simone de Beauvoir (dunque difficilmente ascrivibile al campo gollista): “Che lo si considerasse un amico o un nemico, de Gaulle era parte di noi, senza di lui le nostre vite personali erano raggiunte da un’assenza storica ed esistenziale che quelli della mia generazione percepirono subito”. Gli fa eco Michel Winock, che il 12 settembre 1970 annota nel suo diario di giovane storico: “In fondo a me – e nonostante tutto quello che abbia provato per il regime che aveva instaurato (ho mai votato sì a un suo referendum?) – trovo l’emozione, l’ammirazione profonda che avevo provato, quando sentii l’Appel appena adolescente. Quest’uomo ci ha tutti fatti crescere” (cit. p. 833).
Dunque, ci sono l’uomo e con lui un trentennio di storia del Paese, da quel gesto del 18 giugno 1940, un misto di follia e lucida progettualità politica, chiaro soltanto nell’eccezionale volontarismo di un personaggio politico fuori dalla norma. Ma allo stesso modo c’è l’assoluta normalità di un sistema politico istituzionale che permette alla Francia di entrare nella società del benessere, di vivere la sua età dell’oro e di affrontare poi la discesa verso l’attuale età dell’incertezza e del caos globale con qualche appiglio in più rispetto a numerosi altri sistemi politico-istituzionali (si pensi al nostro Paese, ma anche alla crisi che sta attraversando la patria del presidenzialismo statunitense o quella del parlamentarismo razionalizzato britannico). Il primo punto è dunque tutto in questo apparente ossimoro: un uomo eccezionale per il suo operato, nel 1940 così come nel 1958, fornisce al Paese delle istituzioni e una pratica costituzionale perfetta tanto per i tempi della crisi quanto per quelli della normalità. L’idealtipo non definibile produce un sistema flessibile a tal punto che non soltanto è perfetto per il suo più fiero oppositore (cioè Mitterrand, eletto nel 1981), ma addirittura per personalità politiche, diciamo, di caratura meno rilevante quali Sarkozy e Hollande e in contesti post-bipolari che appaiono lontani anni luce dallo scenario gollista della terza via tra socialismo e capitalismo, o dell’Europa dall’Atlantico agli Urali come amava definirla de Gaulle.
Altro grande merito del volume di Jackson – che anche in questo caso riesce a essere originale nonostante le tonnellate di pagine scritte sul generale – è relativo al secondo salvataggio del Paese, quello appunto del 1958-1962. De Gaulle è quasi brutale nel suo realismo quando contribuisce, senza mai farlo direttamente, a soffiare sul fuoco dell’orgoglio coloniale in quella terra speciale che è l’Algeria, ma contemporaneamente riesce a tenere diritta la barra della sua convinzione profonda, ossia quella di liberarsi di ogni minimo retaggio del colonialismo che la fine della Seconda guerra mondiale ha chiuso nell’armadio della storia. Ma se su questo punto Odile Rudelle, René Rémond e più di recente con documenti inediti Benjamin Stora e Maurice Vaïsse ci hanno detto praticamente tutto sul generale, profondamente convinto di tagliare il nodo gordiano tra la madrepatria e l’Algeria, Jackson illumina e fornisce pagine di grande interesse sull’altro doppio azzardo di de Gaulle, quello del 1962 e cioè l’introduzione dell’elezione diretta del presidente della Repubblica (in base al testo del 1958 era eletto da un collegio ristretto di circa 80 mila grandi elettori) e la scelta dello “sconosciuto” (per la politica francese) Georges Pompidou come primo ministro, al posto del fedelissimo Michel Debré.
Jackson illumina e fornisce pagine di grande interesse sull’altro doppio azzardo di de Gaulle: l’introduzione dell’elezione diretta del presidente della Repubblica e la scelta dello “sconosciuto” Georges Pompidou come primo ministro
Rispetto al primo punto Jackson è magistrale nel ricostruire le opposizioni, politiche ma anche cultural-costituzionali, che, tra fine settembre e inizio ottobre 1962, de Gaulle si trova a dover affrontare non tanto per la decisione di introdurre l’elezione diretta, quanto per lo strumento di revisione costituzionale che ha scelto: cioè il referendum. Tra le molte voci una racchiude tutte le indignate reazioni di fronte alla scelta dell’articolo 11 per modificare il testo del 1958. È quella del presidente del Senato Gaston Monnerville. Prima davanti alla platea del suo partito radicale e poi dai banchi dell’emiciclo che presiede, egli non esita a parlare di “Costituzione violata” e di “popolo abusato”, per poi definire quella di de Gaulle una vera e propria “forfaiture”, abuso che il codice penale descrive come “crimine commesso da un funzionario dello Stato nell’esercizio delle sue funzioni”. Il referendum e le successive elezioni legislative, frutto dello scioglimento voluto da de Gaulle come risposta alla mozione di censura contro il governo Pompidou che ha raccolto la maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale, certificano il successo su tutta la linea della coppia de Gaulle-Pompidou. E per i sei anni successivi è questa la grande novità: una diarchia nella quale è costituzionalmente e politicamente chiaro da dove promani il potere, cioè dall’Eliseo dominato dal generale. Ma lo è altrettanto da dove promani la gestione politica dello stesso, cioè a Matignon.
Rispetto al secondo punto, cioè la relazione tra Eliseo e Matignon, Jackson lavora come nessun altro biografo sul doppio binario del rapporto personale ma allo stesso tempo istituzionale tra presidente e primo ministro. Quest’ultimo non mette mai in dubbio la sua fidelité personale, almeno quanto il dettato costituzionale la cui ambiguità costitutiva fortemente voluta da Michel Debré (sostenitore del parlamentarismo razionalizzato all’inglese) tende a eclissarsi di fronte alla legittimazione diretta derivante dall’elezione a suffragio universale del presidente. Allo stesso tempo però Pompidou, convinto del carattere eccezionale del generale, ha una visione di medio-lungo periodo e opera per la normalizzazione del sistema. Già nel periodo 1962-1965 il rapporto con il generale è dialettico, ma il passaggio della rielezione del 1965 è senza dubbio un punto di non ritorno. E questo non tanto perché il generale finisca per sciogliere all’ultimo la riserva sulla sua rielezione e non lasci la scena la suo primo ministro, profilo ideale in caso di mancata ricandidatura. Ma soprattutto perché il ballottaggio al quale è costretto il generale e l’avvio di una bipolarizzazione del sistema sono segnali che vanno nella direzione di quell’uscita dall’eccezionalità che lo stesso Pompidou si prepara a gestire. In questo senso le elezioni legislative del 1967, con un coinvolgimento in prima persona di quel Pompidou mai eletto prima in alcun consesso rappresentativo e il lavoro dello stesso primo ministro per fare ciò che il generale non aveva mai voluto, tramutare il movimento gollista in un partito della maggioranza presidenziale, sono segnali inequivocabili.
Occorre però fare attenzione a non accreditare una versione finalistica e deterministica dell’evoluzione storica. Il maggio ’68 piomba come un fulmine a ciel sereno nella sua intensità, in un contesto universitario e giovanile che al contrario aveva fornito segnali di insoddisfazione e aveva soprattutto imposto riflessioni che tardavano ad arrivare, nel contesto francese ed europeo in generale, rispetto al ruolo della cosiddetta generazione dei baby-boomers. Ancora una volta Jackson lavora in maniera attenta sul “finale di partita” del generale. De Gaulle che, a inizio aprile, confida a uno dei suoi più stretti collaboratori: “La situazione non mi diverte più, non vi è nulla di eroico e di difficile da fare”, prima di tutto esprime un’evidenza fondamentale: l’eccezionalità della sua leadership fatica a sostenersi di fronte a tempi normali. L’esplosione della Sorbona e del Quartiere Latino sembrano per un attimo riportare al centro l’importanza del leader eccezionale e il coup de théâtre della fuga a far visita al generale Massu e poi della manifestazione successiva sui Champs-Elysées si inseriscono in questo filone. Ma si tratta da un lato solo di una minima percentuale di una gestione, quella del generale de Gaulle di fronte alla crisi studentesca (poi anche sociale e politica), per il resto inadeguata e soprattutto non in grado di comprenderne la portata prima di tutto generazionale. Al contrario, maggio ’68 è il mese di Georges Pompidou, del suo operato istituzionale (la diarchia non deve essere trascurata) quanto politico (nel movimento gollista quanto nel Paese).
La scelta di cercare una rilegittimazione popolare su tematiche che lo stesso generale non esita a definire poco appassionanti illustra l’oramai chiara incapacità di interpretare la normalità da parte del leader eccezionale
E passata l’ondata del maggio francese, chiusa elettoralmente dalla marea gollista della nuova Assemblea nazionale frutto dello scioglimento anticipato e delle elezioni del giugno 1968, sarà proprio lo strano e quasi inutile referendum del 1969 a chiudere definitivamente questo tema della leadership eccezionale e della sua inutilità in tempi normali. La scelta di cercare una rilegittimazione popolare su tematiche che lo stesso generale non esita a definire poco appassionanti e scarsamente mobilitanti illustra l’oramai chiara incapacità di interpretare la normalità da parte del leader eccezionale. Dall’altro lato l’esito finale non poco deve alla certezza che il sistema avrà a disposizione un “normalizzatore”, in caso di vittoria del “no”. Il richiamo, più volte utilizzato tra il 1958 e il 1962, cioè “o me, o il caos”, ha perso di gran parte della sua efficacia.
Un ultimo passaggio di rilievo nell’ampia ricostruzione storica di Jackson deve essere sottolineato. In tutto il volume si ricordano i critici, anche molto illustri (si pensi a Raymond Aron o allo storico direttore di “Le Monde” Beuve-Méry) del sistema istituzionale creato dal generale tra il 1958 e il 1962. Anche coloro che si limitano a fornire un approccio maggiormente scientifico non nascondono lo scetticismo per un regime che definiscono ibrido, né completamente presidenziale, né tantomeno compiutamente parlamentare. Il giudizio finale è sospeso all’uscita di scena del suo “eccezionale ideatore”. Ci si trova di fronte a un uomo che ha sostituito lo Stato, il redde rationem arriverà nel momento in cui tale uomo uscirà di scena. Come sottolineato da Jackson, scettici e critici che hanno questo approccio, non devono attendere molto. La cosiddetta “prova del 1969” arriverà nello spazio di meno di tre mesi. L’elezione di Georges Pompidou, solida e senza alcuna polemica, e soprattutto il ballottaggio Pompidou-Poher, cioè il duello tra il custode della République gaullienne e il senatore centrista teorico del ritorno a un repubblicanesimo parlamentarista, scioglie il dilemma tanto dibattuto da giuristi e politologi quali Georges Vedel e Maurice Duverger a inizio anni Sessanta. L’elezione di Pompidou è la ratifica da parte dell’opinione pubblica che il primato dell’esecutivo incarnato nel presidente della Repubblica deve restare la chiave di volta di un sistema pronto a gestire la normalità e progressivamente preparato (ci vorrà quasi un ventennio) anche a favorire l’alternanza.
Leggere, o rileggere, il de Gaulle di Jackson oggi potrebbe essere di una qualche utilità per interpretare le difficoltà ma anche prendere atto degli strumenti istituzionali nelle mani di Emmanuel Macron. E potrebbe anche non essere inutile per riempire di contenuti il troppo spesso vacuo dibattito italiano, punteggiato da proposte di modelli solo teoricamente funzionali alla chiusura della nostra ultratrentennale transizione politico-istituzionale.

Riproduzione riservata