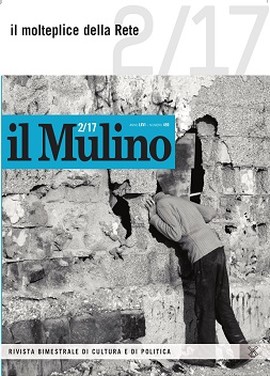In Blade runner, il film del 1982 tratto da un romanzo del visionario scrittore americano Philip K. Dick, gli umani vivono in una costante minaccia, quella che proviene loro dai «replicanti», macchine il cui aspetto è così simile a quello degli uomini da renderli non più distinguibili. Molte e complesse sono le suggestioni che provengono dalla trama e dai temi del film; qui mi limiterò a rievocarne soltanto una. La scena in cui un replicante entra furtivamente in una casa e ruba alcune fotografie relative all’infanzia di chi vi abita. Che senso ha quel furto? Forse, quel replicante desidera costruirsi, seppure tramite un’appropriazione indebita, una storia affettiva posticcia. I replicanti – macchine senza storia – sentono il bisogno «umano» di dotarsi di un percorso affettivo in cui riconoscersi e poter narrare la propria storia. Sentono il bisogno di darsi, sia pure in modo fittizio e a posteriori, una rete affettiva capace di accogliere la propria esistenza macchinale.
E noi umani? Come stiamo agendo riguardo al nostro mondo affettivo? Non stiamo, forse, via via anestetizzando la possibilità di essere toccati dalla complessità degli affetti? Quali sono, quindi, i destini cui l’assetto affettivo sarà esposto nel tempo a venire? Si tratta, probabilmente, di domande troppo assolute e pretenziose per poter ricevere un qualche tentativo di risposta; occorre svilupparle in altro modo e interrogarsi, ad esempio, su come si presenta e si va sviluppando l’assetto affettivo nella generazione degli adolescenti di oggi, i cosiddetti «nativi digitali». Non per fare facili profezie, né per lanciare ammonimenti cassandrici. Ma per puntare lo sguardo su una dimensione dell’identità che – come ci ricordano i replicanti di Blade runner quando si appropriano, rubandole, di alcune foto d’infanzia – è gravoso sottoporre a operazioni di smentita o di svilimento.
[L'articolo completo, pubblicato sul "Mulino" n. 2/17, pp. 218-225, è acquistabile qui]

Riproduzione riservata