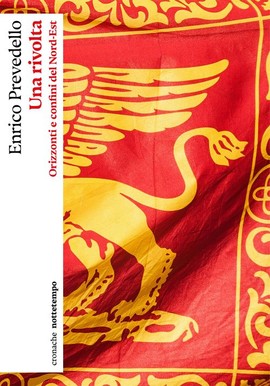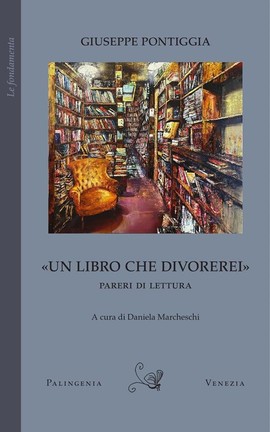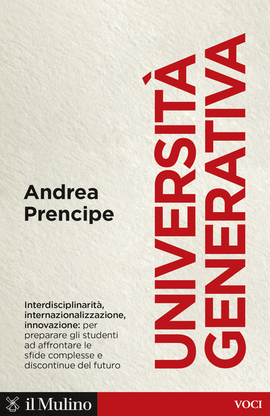Conosco poco Tommaso Giartosio, ma ricordo un particolare curioso: nelle rare occasioni in cui abbiamo scambiato qualche battuta, mi è capitato d’incorrere più volte in un lapsus. Non è per fare dell’aneddotica che inizio da questo fatto personale. Autobiogrammatica, il suo bel libro uscito ora da minimum fax del quale do conto, parla infatti sia delle deformazioni volontarie del linguaggio (calembour, pun, insomma giochi di parole, o più largamente i Witze) sia di quelle involontarie. Inoltre, è la storia di un letterato-uomo d’ordine: e io so che nei lapsus, di solito, inciampo appunto davanti a questo tipo umano. Nato negli anni Sessanta, cresciuto nella Roma borghese e in quell’enclave che è l’ambiente dell’esercito, Giartosio ha avuto un padre ufficiale di marina. Qui rappresenta la propria vicenda famigliare col filtro di un “atlante del linguaggio di un singolo individuo: cioè del suo modo di sentire e vivere la lingua”: analisi iper-identificata, e insieme resoconto da everyman, o rito totemico dove soggetto e specie si confondono.
Il “Lessico famigliare” giartosiano è il contrario di quello ginzburghiano, data la sua natura enciclopedica, il richiamo costante a un “meta”, e una mappatura meticolosa da militare o da collezionista metafisico, che si macera di voluttà di fronte a qualunque segno alfabetico e oggetto di cancelleria. Autobiogrammatica non è un romanzo: è un’orazione narrativa che apre e chiude di continuo delle porte su un romanzo possibile, e ne fa una fuga di stanze in stiacciato. Estrae la memoria dei fatti dai “frantumi verbali” casalinghi, magari insignificanti ma favolosi, perché orecchiati per la prima volta dall’altezza rasoterra dell’infanzia. Tracciare le linee che descrivono il loro fluttuare, o il loro rimescolarsi nella formazione dell’Io arringante, è un buon modo per schivare la convenzionalità dello storytelling da saga.
Tommaso non pretende di salvare il lessico di cui è impregnato, né accetta di liquidarlo con insofferenza: vuole capirlo, giocarselo, ben sapendo che come un seme si scioglierà comunque, alimentandolo, nel gran mare dell’essere. Si pone le domande cruciali sul proprio destino saggiando quasi tattilmente la stoffa delle parole. Indugia nella freddura – questa etimologia fantastica – o s’interroga sul rapporto tra l’ambiguità dell’umorismo e la correttezza della retorica civile, e nel frattempo forgia notevoli aforismi (“Il pregiudizio è molto più spesso passivo che attivo, blando che atroce”, “Nessuno è paternalista quanto un figlio”).
Nel clan Giartosio, lo humour si dispone su una scala che va da Wilde a Campanile. In questa famiglia agiata, che a un capo sfiora Pound e all’altro la P2, s’intrecciano l’anglofilia, un conservatorismo non senza rapporti col fascismo e la vecchia sobrietà piemontese
Nel clan Giartosio, lo humour si dispone su una scala che va da Wilde a Campanile. In questa famiglia agiata, che a un capo sfiora Pound e all’altro la P2, s’intrecciano l’anglofilia, un conservatorismo non senza rapporti col fascismo e la vecchia sobrietà piemontese. In sintesi: dignità sabauda, difesa non meno reale che ironica dei valori tradizionali, ma anche un po’ di avventura alla Soldati. Il linguaggio del padre kiplinghiano si deposita in formule consolidate, oppure è assorbito dal silenzio degli omissis da cui affiora soltanto un primordiale, ludico “Ólà”: esclamativo che agisce, direbbe Montale, embrione performativo o fatico, nuvola da fumetto. Tra i due registri estremi, manca all’ammiraglio l’espressione mediata del sentimento. Il suo rigore trova l’unica valvola di sfogo nei “versi”, nel senso sia di Carducci sia delle bestie, imitate nel “felice analfabetismo di ritorno” in cui si rifugia anche il figlio, che impara subito a memoria i puri nomi della fauna (il suo totem è il topo: topos, topica, arte o gaffe) e che proprio durante una regressione all’animalità sconta la diversa animalità dei bulli (“quello che guarda”, “quello che mena”). La madre invece, avendo respirato lingue e culture diverse, e sperimentato diverse situazioni sociali, senza passare attraverso un’irreggimentazione scolastica, si è fatta da sé un lessico arlecchinesco, dispersivo e temerario, pronto a sfumare in grammelot – un lessico in cui una stessa cosa si dice in molti modi come la neve proverbiale degli eschimesi (e qui viene in mente Fortini, il quale all’esaltazione donmilaniana di un vocabolario ricco ribatteva che possiede il potere chi sa ridurre tutti i cosiddetti sinonimi a un solo termine algebrico: da questo punto di vista la madre è ribelle, antimilitaresca).
Quanto al narratore-oratore, mentre scheda e assapora dialetti, lingue europee e gerghi odorosi di casa, sembra un Calvino che riordini gli scaffali di villa Gadda. Facendolo, è naturale, scopre quanto è molecolarmente composto dei genitori (poi dei compagni di scuola), e come ha imparato ad abitare quei mondi-linguaggi. Ad esempio, anche lui rimuove le parole dell’aggressività per trasferirla con astuzia su piani più indiretti: il rovescio del suo understatement, della sua educazione impeccabile, è la hybris di chi vorrebbe riportare tutti e tutto alla misura del proprio archivio. Ad esempio, a partire dalla routine famigliare, il ragazzo ha fatto del suo strano bilinguismo o “diplopia” italo-inglese un’altra enclave, scarto e origine di sé: da una parte la lingua classica zeppa di vocali, dall’altra quella romantica che, come diceva Savinio, si prolunga nel suono oltre sé stessa. Ancora: a poco a poco, il post-ideologico Tommaso si rende conto di quanto anche gli aspetti ambigui e reazionari di un Novecento che credeva lontano gli siano rimasti attaccati addosso: fino alla scena finale del convegno su Pound, sorta di piccolo ricevimento Guermantes che svela una mostruosa verità retrospettiva.
Ma il tema centrale è l’oscillazione tra resa alla bellezza screziata del mondo-linguaggio e alibi o corazza della goliardia, che tende a prevalere. Il protagonista è un eterno bravo studente, i cui esperimenti di parole in libertà vengono subito organizzati in un esperanto speculare alle materie di studio. Come molte persone cresciute nel tardo ventesimo secolo, pensa che l’ipercoscienza sia un’assoluzione, che salvi e riscatti tutto.
“Credono che io non sappia che è stupida, credono che mi faccia ridere, ma non hanno capito, la battuta non mi fa ridere, so che è stupida, quello che mi fa ridere è immaginare quanto sarebbe stupido qualcuno che ridesse di questa battuta: non io, ovviamente”,
scrive Tommaso a proposito della sua passione per le freddure demenziali. Il suo istinto è di rendere civico, di piallare in bello stile il subconscio. Così, come al padre, gli resta lo sfogo o vacanza del calembour e al limite dell’ecolalia, del ritornello insensato che scatta da solo; ma subito si sente in dovere di spiegarli spaccando il capello in quattro. Un compromesso lo trova nel gioco come costruzione fabbrile (si veda il falegname compagno dell’infanzia; ma fabbro è anche Pound, che esaltava il figlio di fabbro Mussolini). Anzi, per essere esatti, il compromesso corrisponde al luogo in cui sembra di toccare con mano la scrittura come artigianato insieme raffinatissimo e socialmente inattaccabile: il regno della grafica. Anche l’impaginazione del libro suggerisce che per Giartosio scrittura e disegno sono reversibili l’una nell’altro. Ma la domanda che continua ad aleggiare su questa tendenza è: dove sta il confine tra il gusto grafico come mestiere autarchico e il gusto grafico come moda, cioè disciplina che è tutta dalla parte dell’uniforme (nome e aggettivo)? Dov’è, insomma, il confine tra la precisione minuziosa e il conformismo, o anche un certo bovarismo? Giartosio coglie bene il problema, e si mostra scisso. Pur così misurato, il suo protagonista si compiace un po’ troppo nello scandire i motti di spirito; e ogni tanto rasenta una tipica forma attuale del nostro dannunzianesimo narrativo, che consiste nel contrabbandare l’estetismo sotto la parola in apparenza inevitabilmente tecnica: “Ora l’auto muove sicura, tropistica”, “Lenta morbida rotazione archimedea del portone”, “Isobare di autocoscienza lo percorrono”…
Il fatto è che questo narratore-oratore, tagliato a metà e diviso in un doppio senso, ha mantenuto il rispetto edificante del padre per la Cultura codificata. Solo passando per la Scuola si crede legittimato alla tracotanza fisiologica della Poesia
Il fatto è che questo narratore-oratore, tagliato a metà e diviso in un doppio senso, ha mantenuto il rispetto edificante del padre per la Cultura codificata. Solo passando per la Scuola si crede legittimato alla tracotanza fisiologica della Poesia. Ed ecco allora che, quando si sente soffocare, reagisce alla compulsione tassonomica con il nonsense. Come dire che anche lui diffida dell’incerta mediazione dei simboli concreti, che sospetta di immoralità le metafore impure. I suoi quaderni, letteralmente, ce li squaderna davanti: ha l’ansia di esibire il rovescio di ogni affermazione, di indicare l’etichetta, perché non ha abbastanza fiducia nella letteratura ancora senza nome. Perciò forse sono così belle e struggenti le pagine in cui rimpiange di aver perduto il momento giusto per parlare con un amico adolescente della propria omosessualità – il momento, cioè, nel quale l’omosessualità avrebbe potuto essere evocata con parole nuove, inaudite, irriducibili alle classificazioni standard dell’età adulta. “La poesia è la teologia presa alla lettera”, dice Giartosio a un certo punto: ma è vero il contrario. È la teologia – o la teoria, o la geometria marziale del linguaggio – che pretende di prendere alla lettera il senso e il nonsenso, i livelli naturalmente mescolati della poesia. Così la bio-grafia di questo uomo d’ordine abitato dalla tentazione di un disordine che non può dialogare coi suoi freni inibitori, la summa teologica di questo goliardo severo e tenero, sembra a volte una sorta di calembour serio tenuto per 400 pagine. Qua e là, uno Scialoja con le note: topo, topo, dopo te vengono i topoi. Il suo testo, insomma, è davvero un ircocervo. Ed è comunque pieno di sorprese: ad esempio la giocosa poesia giovanile riportata a pagina 393 è una delle cose più perfette di Autobiogrammatica – e supera molte liriche del Giartosio versificatore “educato” e “maturo”.
A libro chiuso (ma è chiuso, archiviato fin dall’inizio: gli autoesami si fanno sempre immaginandosi morti), mi sono ricordato di un famoso racconto del giovane Tommaso Landolfi, il Dialogo dei massimi sistemi. Un letterato, convinto che l'arte migliore nasca componendo in una lingua straniera, ha preso lezioni di persiano da un capitano inglese, e in persiano ha scritto i primi versi. Ma il giorno in cui, partito l'insegnante, si è procurato una grammatica, ha scoperto di avere appreso una lingua che non è affatto la persiana, né alcun’altra conosciuta. Per somma beffa, intanto, il capitano ha dimenticato la sua stessa invenzione. Il poeta si trova quindi tra le mani un’opera ingiudicabile se non da lui medesimo. Siamo davanti a una situazione che diverrà caratteristica in Landolfi: al tentativo impossibile d'inventarsi un linguaggio o un gioco ex novo. Ne esce una satira del crocianesimo allora imperante; il quale, ridotto all’assurdo, porterebbe ad affermare che ogni poesia, essendo intraducibile, è sempre “unica misura a se stessa”. L’autore dell’Autobiogrammatica, per fortuna, bagna invece l’espressione linguistica nella biologia e nella storia. Eppure, eppure… quel capitano di marina inglese non somiglia un po’ all’ammiraglio Giartosio?

Riproduzione riservata