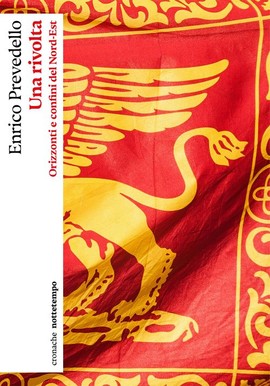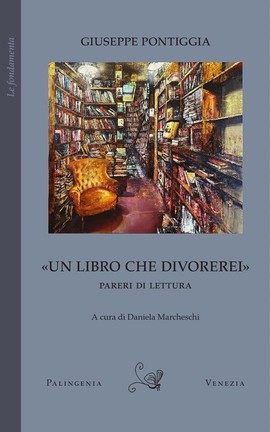Richard David Precht è un filosofo, o meglio, un divulgatore di filosofia; ha portato l’austera disciplina perfino in tv, sul secondo canale tedesco, Zdf, dove conduce una trasmissione che si intitola semplicemente Precht. Ricorda in parte il fenomeno del nostro Vittorio Sgarbi, e infatti, quando lo vedi in foto o in video, è quello che si dice "un personaggio". Può stare subito antipatico, perché trasuda narcisismo maschile da ogni poro, ha un look stravagante (camicie aperte sul petto, stivali a punta ai piedi) e si fa ritrarre in pose studiatissime. Lo si può odiare a prima vista. Oppure, siccome l’immagine e il personaggio sono così evidentemente costruiti, si può pensare che sia uno molto intelligente, perché molto autoironico. Comunque, un personaggio. E quindi mi sono messa a leggere questo suo libro sulla scuola (tedesca), il cui titolo Anna, die Schule und der liebe Gott, ossia "Anna, la scuola e il buon Dio", non si capisce se non alla luce di un aneddoto (dovuto al comico Ken Robinson) riportato nella prima pagina: la piccola Anna sta disegnando in classe, il maestro la osserva e le chiede: "Anna, cosa stai disegnando?"; "Il buon Dio", risponde la bambina; e il maestro: "Ma il buon Dio non si può assolutamente disegnare. Nessuno sa come sia fatto". "Tempo cinque minuti, e lo sapremo!".
Cosa ha da dire Precht sulla scuola? Il suo libro è corposo (quasi 350 pagine), ma vuole essere divulgativo, e i concetti chiave si ripresentano più volte nel corso dell’esposizione, discorsiva, senza note a piè di pagina. Al netto di tutti i riferimenti al sistema scolastico tedesco, Precht inquadra la crisi della scuola all’interno della crisi del capitalismo: la scuola così com’è oggi è, infatti, conforme a questa ideologia, e negli ultimi tempi è diventata ancor di più un luogo in cui gli alunni devono fornire essenzialmente prestazioni, ben misurabili, dimostrando di aver assimilato nozioni e sottoponendosi così ad una selezione. Queste quattro parole in corsivo sono le chiavi d’accesso al problema scuola nei paesi del cosiddetto Occidente. Dunque anche in Italia. I genitori con figli in età scolare troveranno finalmente in queste pagine la spiegazione del malessere, psicologico e fisico, dei propri figli, e anche delle prestazioni scolastiche del tutto insufficienti di bambini e ragazzi di normale e perfino acuta intelligenza. E’ infatti ai genitori che Precht in primo luogo si rivolge, segnalando la follia di un sistema che tende pericolosamente a individuare e coltivare solo le cosiddette eccellenze, come in un mercato in cui si debbano scartare i prodotti di seconda fascia perché non dotati di tutti gli optional. La verifica continua della quantità di nozioni memorizzate (le nozioni sono le uniche misurabili quantitativamente e pertanto frequentemente) è lo strumento crudele per il raggiungimento di questo scopo: un’ossessione valutativa serpeggia tra gli insegnanti, le famiglie vengono tartassate di voti e comunicazioni da parte della scuola perché risulti evidente il livello e dunque il posto occupato da ogni alunno nella prima gerarchia competitiva della sua vita. Per non parlare dell’idiozia (il termine Dummheit è di Precht) delle valutazioni Pisa e simili (in Italia si occupa di questo il famigerato Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione) predisposte da e per i Paesi aderenti all’Ocse, che non è un’associazione intergovernativa ideologicamente neutra, ma al contrario marcata in senso capitalista. La scuola ha dunque assoggettato se stessa alle regole di una società nella quale la velocità nella crescita e nel raggiungimento degli obiettivi predefiniti è un valore, e l’obiettivo è vincere: gli Stati sgomitano per arrivare primi nella classifica Ocse così come i bambini e i ragazzi vengono allenati per ottenere voti alti, mentre non viene loro insegnato a fallire, a sbagliare, a correggersi, in un’epoca in cui il fallimento familiare e/o lavorativo rientra nel percorso esistenziale di moltissimi individui.
In generale, l’educazione emotiva sembra essere uscita dall’orizzonte scolastico, così come l’obiettivo di uno sviluppo armonico della persona. Il fattore tempo è invece determinante: chi, come alunno, non fornisce la prestazione richiesta nell’arco di una data unità temporale (il quadrimestre o lo svolgimento di una determinata unità didattica) viene valutato come inadeguato all’apprendimento, quando invece si tratta solo di individui non assoggettabili ad un sistema così concepito. Inquietanti sono anche gli aspetti quantitativi dell’organizzazione spicciola del sistema scuola, che riecheggiano il modello produttivo taylorista: l’orario delle lezioni, la ripartizione del sapere in materie, perfino l’articolazione in gruppi classe con un certo numero di alunni. L’obiettivo di ogni insegnante è svolgere il programma ministeriale, presentandone in classe i contenuti e affidando agli alunni il compito (spesso arduo) di assimilarli da soli, a casa: l’importante è che sulla carta il programma sia stato “fatto”, l’importante è che le verifiche consegnino agli alunni e alle loro famiglie gli indicatori di livello. Precht, sfruttando abilmente una retorica paradossale, provoca il lettore, invitandolo a chiedersi se questo sistema debba ritenersi ineluttabile, immodificabile, vista anche la sua solo parziale efficacia: al suo interno possono venir istruiti (istruiti, non educati!) adeguatamente solo alunni con un certo background familiare, che, oltre a predisporli favorevolmente al sistema, alimenta e sostiene la loro competitività, eventualmente pagando lezioni private per il recupero delle prestazioni insufficienti. Precht ha molto a cuore il tema dell’integrazione degli immigrati di seconda generazione, che restano ai margini dei percorsi formativi non per le loro capacità personali, ma per le loro condizioni di vita: per loro la scuola e l’Università non rappresentano ancora il luogo in cui esplicare le proprie potenzialità, ma sono il più delle volte solo uno strumento selettivo. Dunque la scuola non ha alcun portato rivoluzionario, non si volge al futuro, che è anche quello di società interculturali: al contrario, è un potente strumento di conservazione per una società classista.
Che fare, dunque? Una rivoluzione. Perché, dice Precht, una riforma della scuola sarebbe troppo poco: non si può correggere solo un’ala dell’edificio. E dunque, nello spirito dei grandi riformatori della scuola come Wihelm von Humboldt, Maria Montessori, Washburne (l’ideatore del Mastery Learning), i tedeschi Kerschensteiner e Picht, e con molta simpatia per esperimenti recenti come la Kahn-Akademie, Precht dà il via a una serie di proposte: via innanzitutto l’enciclopedismo nozionistico, via i voti, via i quadrimestri, l’orario settimanale, le materie così come oggi concepite. Spazio al tempo lento della comprensione, della riflessione, della rielaborazione. Spazio alla voce degli alunni, di ogni età, alle loro piccole e grandi esperienze e curiosità. Spazio alla ricerca, e non alla memorizzazione passiva. Spazio all’emozione dell’apprendimento: giacché, come le neuroscienze hanno ampiamente dimostrato, il sapere si fissa nella memoria quando è accompagnato dal piacere, dalla gioia, non già quando avviene sotto la minaccia della punizione o con la promessa di un premio. I soliti grandi discorsi, le solite grandi visioni, si dirà. Ma per cominciare, si provi almeno a non costringere gli alunni di ogni età a stare seduti in un banco per ore: in questa postura l’attenzione dura al massimo venti minuti. E quindi cosa fa un alunno per i restanti 30/40 dell’unità oraria? Oppure: prolungare la permanenza degli alunni a scuola, per consentire lo studio, anche individuale, con l’assistenza degli insegnanti (in Italia nella scuola primaria il tempo pieno esiste già: in Germania si tratta di una realtà minimamente presente; ma Precht ha in mente anche gli adolescenti). E ancora: sfruttare sapientemente (quindi non esclusivamente, ma come variante rispetto ad altri strumenti e metodi) le tecnologie informatiche, giacché queste consentono l’autoverifica o la costruzione di percorsi personali di ricerca e di apprendimento, ed è stato dimostrato che anche i videogiochi insegnano, e molto. Comunque promuovere il lavoro di gruppo, perché l’intelligenza emotiva e le competenze sociali sviluppate dagli alunni verranno messe per prime alla prova nella vita fuori dalla scuola, sul piano personale e professionale.
In questa prospettiva anche la selezione e la formazione degli insegnanti devono avvenire sulla base di sicure attitudini personali alla leadership e alla comunicazione: Precht sogna delle accademie per l’insegnamento come ve ne sono per il teatro e le altre arti, giacché una buona lezione è a tutti gli effetti un’opera d’arte. Gli alunni devono poter stimare i propri insegnanti e da questi essere sempre motivati, devono sentire che quello che viene loro proposto nell’attività scolastica è degno di essere preso in considerazione, perché fornirà un appagamento intellettuale immediato e, a lungo termine, una capacità di affrontare la realtà. La questione dell’insegnamento della matematica ben riassume il modo di pensare di Precht. Le famigerate valutazioni quantitative nazionali mettono in luce (in Germania come in Italia) una situazione disastrosa in questa materia, che nello stesso tempo sta diventando, per la società, l’indispensabile sapere del terzo millennio (naturalmente un’idea sbagliata, questa, ma molto, molto diffusa: come se nel mondo ci fosse bisogno solo di ingegneri). Un problema sono innanzitutto gli insegnanti di matematica, spesso privi di grandi capacità comunicative e indifferenti (talvolta perfino per principio, quasi conformandosi alla natura astratta della disciplina in sé) al rapporto con i propri alunni e dunque agli effetti della propria attività pedagogica. La matematica, poi, si presta molto bene alla selezione degli alunni, soprattutto quando questi, alle soglie della pubertà, devono fare quel salto di qualità richiesto dai programmi didattici, ossia sviluppare il pensiero astratto attraverso un duro esercizio mnemonico. Precht fa notare che gli individui veramente dotati per questo tipo di sforzo intellettuale sono molto pochi: dunque nella scuola la matematica è la ‘bestia nera’ in quasi tutte le classi, moltissimi ragazzi vanno incontro all’insuccesso, nei casi peggiori vengono considerati degli idioti, ma comunque si disamorano per sempre.
Con la consueta retorica paradossale, Precht arriva a dire che non sta scritto in nessuna Bibbia che l’intera umanità debba sapere tutto dell’analisi matematica o dell’algebra (è un po’ come il greco antico, no?). Se dunque l’obiettivo è educare al pensiero astratto, lo si può raggiungere attraverso la filosofia, o perfino il gioco degli scacchi… Ciò che veramente conta è imparare ad imparare. Sarebbe ideale poter permettere a ciascun alunno di individuare la propria strada per il sapere.
Precht stila, in chiusura, un vero e proprio decalogo della rivoluzione necessaria: 1) curare la motivazione intrinseca nel bambino; 2) lasciare che il bambino apprenda secondo il proprio individuale carattere; 3) far capire il senso e la natura delle cose e le loro relazioni, superando la suddivisione del sapere in ‘materie’; 4) curare le relazioni interpersonali; 5) introdurre nella scuola una cultura delle relazioni e delle responsabilità reciproche; 6) promuovere valori e insegnare a distinguerli; 7) rendere gradevole l’architettura delle strutture scolastiche; 8) allenare le capacità di concentrazione; 9) esprimere la valutazione degli alunni attraverso giudizi articolati, e non voti; 10) estendere la scuola a tempo pieno. Se queste proposte appaiono astratte, lontane dalla quotidianità scolastica, allora davvero è l’ora di fermarsi a pensare: vuol dire che si è persa la capacità di visione della propria epoca e delle relazioni umane che all’interno della scuola si intrecciano, coinvolgendo la parte più delicata della società, ossia le nuove generazioni. In Germania il dibattito pubblico sulla scuola è stato nell’ultimo anno molto intenso: quotidiani come “Die Zeit” e “Die Welt” hanno concesso ampie interviste a Precht, ma anche a John Hattie, il pedagogo australiano del Visible Learning, per citare i nomi più significativi; il settimanale “Der Spiegel” ha dedicato, nello scorso mese di marzo, un ampio dossier al tema Schule macht krank (“La scuola fa ammalare”), perché, dal punto di vista dei genitori e degli alunni, i problemi psicologici e perfino fisici generati dalla scuola sono diventati molto seri.
In Italia sarebbe l’ora che la discussione, per ora circoscritta agli addetti ai lavori (insegnanti, dirigenti e sindacalisti) si allargasse all’intera società. Gli esperimenti didattici innovativi non sono coordinati dall’alto e una certa passività intellettuale contraddistingue la maggior parte degli insegnanti, che si dipingono spesso come vittime di un sistema economico iniquo e di alunni diventati ormai ingestibili. Le famiglie, da parte loro, esercitano verso la scuola una critica talvolta feroce, ma sterile e circoscritta a problemi e disagi personali. La politica è riuscita solo a ridimensionare le spinte innovative (dov’è finito don Milani?), arrivando, nell’ultimo decennio, a smantellare perfino quello che di buono poteva esserci in un sistema comunque vecchio. “Non abbiamo bisogno di un’altra riforma, abbiamo bisogno di una rivoluzione”: cos’altro dire?
[Questo contributo è stato pubblicato sul numero 6/2013 della rivista “il Mulino”]

Riproduzione riservata