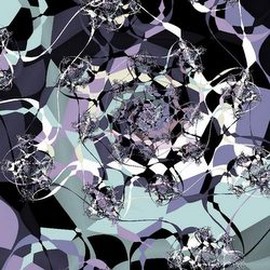Nelle sale in queste settimane, ora anche col viatico delle dieci nomination agli Oscar, American Hustle di David O. Russell è molto di più che una variante malinconica con tocchi virulenti alla Scorsese di La stangata, la commedia che quarant’anni fa mise insieme Paul Newman e Robert Redford conquistando le platee di mezzo mondo. Infatti American Hustle è lì a ricordarci che “l’apparenza inganna”, come recita la seconda parte del titolo nella versione italiana, didascalica ed efficace. Ambientato alla fine degli anni Settanta nella Atlantic City dei casinò in disarmo cara a Bob Rafelson e a Louis Malle, il film si conclude con una sorta di elogio della realtà. È l’approdo chissà se volontario o inconscio della pirotecnica trama in giallo tra politici corrotti, boss del crimine, ciarlatani allo sbaraglio e due bellissime donne – Amy Adams e Jennifer Lawrence – tanto deluse dalla vita quanto determinate nel duellare. L’esito è politicamente schietto: il protagonista Irving Rosenfeld (Christian Bale imbolsito all’inverosimile rispetto alla prestanza del “suo” Batman) dichiara nelle ultime battute di voler “restare con i piedi ben piantati per terra”. Così, nella filigrana di una pellicola di successo, dagli Stati Uniti giunge un invito neanche troppo dissimulato a rileggere il passaggio decisivo fra i Settanta e gli Ottanta in cui la realtà prese a confondersi con la finzione, ovvero le due dimensioni a sovrapporsi nel nome dell’utilitarismo e dell’edonismo proverbialmente “reaganiano” o berlusconiano nelle declinazioni nostrane. Più soldi e più piacere per tutti! Sappiamo com’è andata a finire, al di là e al di qua dell’Atlantico.
Quell’hustle dai molteplici possibili significati letterali o in slang (andirivieni, fretta, truffa, meretricio, scaltro calcolo; il nostro gergale “casino”), inorgoglito e rinvigorito nel 1989 dal crollo del muro di Berlino e poco oltre dal disgregarsi dell’impero sovietico, avrebbe impresso un’accelerazione mercantile, suscitato una vertigine finanziaria e, oltretutto, suggerito metafore sulla fine della Storia, parimenti smentite nei fatti. Da bipolare che era, il mondo non diventa affatto unipolare e solo americano, bensì molteplice, sfuggente e più minaccioso di prima. Ed è singolare che siano pochi gli analisti a richiamare il legame fra lo shock delle Twin Towers in principio di un secolo le cui magnifiche sorti pareva potessero essere inficiate al massimo dai difetti telematici o dalla pirateria sul web (ricordate il millennium bug?) e la crisi economica, politica e culturale esplosa nel 2007 e tutt’oggi non doma nel mondo occidentale.
Dal canto suo, l’America negli ultimi lustri – tranne che nell’incipit della presidenza Obama e in occasione del lutto globale per Steve Jobs – è andata dissipando il suo fascino come non era accaduto neppure durante la guerra del Vietnam, allorché, fra il 1960 e il 1975, i ragazzi statunitensi e quelli europei riempirono sì le piazze contro l’intervento bellico di Washington, tuttavia in nome di valori libertari e sbandierando costumi, comportamenti e merci a stelle e strisce. Si ebbe allora il paradosso, annotato da Umberto Eco, della terza generazione italiana innamorata dell’America sebbene politicamente anti-yankee, dopo gli intellettuali come Mario Soldati ed Emilio Cecchi durante il fascismo, e Cesare Pavese ed Elio Vittorini nel dopoguerra. Il Sessantotto rinverdì l’anelito occidentale, consumistico, “americano”, al netto e a dispetto delle sue rigidità orientali di cui è rimasto ben poco (il mito di Stalin, il culto di Mao o la surreale infatuazione per l’Albania).
È presto per dire se oggi la generazione dei social networke del selfie (dai dodici ai cinquant’anni tutti ad autoritrarsi!) sia interessata o disponibile a un nuovo incanto americano, a un orizzonte appena più vasto delle funzioni di un iPhone 5s, insomma a non rinserrarsi nell’ideologia tecnologica che permea e imbambola l’immaginario. “Per il narcisista il mondo è uno specchio”: aveva visto lungo il sociologo Christopher Lasch, scomparso giusto vent’anni fa, nel suo The Culture of Narcissism del 1979.
Eppure alcuni segnali depongono per un cambio di stagione. All’America corposa, sanguigna, tenace, autentica, ruvida si ricomincia ad attribuire – suo malgrado – un’attrattiva che sembrava persa per sempre. Ricordate Pavese? L’America a mo’ di palcoscenico dove, prima che altrove, “si recita il dramma di tutti”. Certo, lo sguardo è retrospettivo come in American Hustle o nella rassegna biennale dedicata alla New Hollywood anni Sessanta-Settanta, a cura di Emanuela Martini, che anche nel 2014 il Torino Film Festival dedicherà alle opere dei giovani ribelli del tempo. Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Sam Peckinpah, Robert Altman… Registi e film alieni dalle lusinghe degli effetti speciali rispetto al primato del cinema di indagine, dell’elegia realistica e della denuncia dei rapporti di classe o di genere. Vintage? Modernariato? Nostalgia canaglia? Può darsi, ma è roba forte che se riprende a circolare non lascerà indifferenti.
Vedi il caso di Autunno americano, come s’intitola l’importante serie di esposizioni e iniziative in corso a Milano fino al prossimo febbraio. Un successo in primis nel pubblico dei più giovani. Prendendo le mosse dalla Scuola di New York di “Pollock e gli irascibili” a Palazzo Reale e passando per Bob Dylan, Andy Warhol o Marilyn Monroe, di scena vi sono le voci, le visioni e le icone pop che fin dai primi anni Cinquanta palesano/denudano anzitempo l’addio al Novecento delle Grandi Narrazioni, dei movimenti di massa e delle utopie di riscatto. Lì, in America, si produce lo strappo o la ferita della modernità la cui sicumera comincia a sfarinarsi nei frammenti, nei racconti occasionali, nei minima immoralia, nei pensieri brevi o post ben prima che su Facebook.
Ecco, potremmo metterla così: si torna sui propri passi per capire dove abbiamo sbagliato, lungo strade geograficamente lontane eppure familiari. Tra l’altro è sugli schermi italiani anche Nebraska di Alexander Payne (sei nomination all’Oscar), pensoso e delicato road movie in bianco e nero, con stile Seventies e paesaggi desolati che possono ricordare le sonorità dell’omonimo album di Bruce Springsteen. Mentre è stato appena tradotto finalmente in edizione integrale da Sergio Claudio Perroni per Bompiani Furore di John Steinbeck (1939), l’opera di viaggio per eccellenza da cui John Ford trasse un film altrettanto memorabile: è l’odissea verso Ovest di Tom Joad e della sua famiglia contadina in fuga dalla Grande depressione. Come già accaduto nei recenti Lincoln di Steven Spielberg e Django Unchained di Quentin Tarantino, Hollywood rivolge lo sguardo all’indietro e cerca tracce di futuro nelle ombre e nei buchi neri della storia: una sorta di analisi terapeutica per mitigare l’onnipotenza perduta.
La ricerca ci riguarda. A quale bivio ci siamo persi sognando l’America amara? Era il bellissimo titolo di Emilio Cecchi, il più consapevole dei viaggiatori oltreoceano anni Trenta nel gruppo dei Cipolla e Fraccaroli, mutuato dallo storico Lucio Villari per un’agile ricognizione di “storie e miti a stelle e strisce” fresca di stampa per Salerno Editrice. Nei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti, conclude Villari, “l’America è l’Oggetto di una nostra eterna infanzia, di un nostro futuro misterioso”. In cerca di speranze, dove altro mai rivolgersi?

Riproduzione riservata