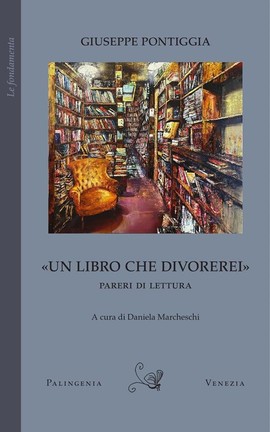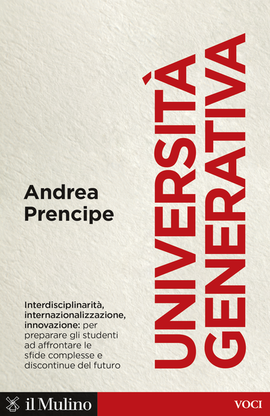“Avrei potuto leggere il «Financial Times» e l’«Economist» per un secolo senza ottenere un singolo punto in più”. Questa la lamentela di uno studente di economia costretto a seguire corsi e sostenere esami che paiono avere poco a che fare con le sue esperienze e letture di tutti i giorni e molto con la ripetizione meccanica di astratti (e astrusi) modelli matematici. La provocazione dello studente, intervistato da Joe Earle, Cahal Moran and Zach Ward-Perkins, autori di The Econocracy: The perils of leaving economics to the experts (Manchester University Press, 2017), sintetizza bene quello che per i tre è uno dei problemi centrali della disciplina economica oggi, ossia il suo scollamento rispetto a quanto succede nel mondo reale.
Questo scollamento a sua volta genera uno strano paradosso: da un lato l’economia – o meglio il paradigma neoclassico che domina la disciplina da diversi decenni – appare sempre meno rilevante dal punto di vista sociale, incapace com’è di rispondere ad alcuni dei maggiori problemi contemporanei, dal degrado ambientale, alle disuguaglianze, allo scoppio delle crisi finanziarie. Dall’altro lato, però, l’influenza politica dell’economia come professione non è mai stata maggiore come ai giorni nostri, spinta da un sistema di conoscenza specializzato, inaccessibile ai più e presuntamente oggettivo che permette a una ristretta casta di tecnocrati di prendere decisioni di politica pubblica in pressoché totale (e talvolta legale, come nel caso delle banche centrali) isolamento rispetto al controllo degli elettori. Un’econocrazia, per l’appunto.
Questo libro è sia uno studio accademico sia un manifesto di cambiamento sociale. Vuole esaminare le caratteristiche e le radici del sistema econocratico che pervade i sistemi politici occidentali e allo stesso tempo proporre soluzioni concrete ai suoi molti difetti. Earle, Moran e Ward-Perkins sono tra gli animatori della Post-Crash Economics Society, un collettivo di studenti dell’Università di Manchester a sua volta legato ad altri gruppi simili in altre parti del mondo tramite la rete interuniversitaria Rethinking Economics. The Econocracy contiene le riflessioni, i principi e le ricette di queste organizzazioni.
Nello spazio di sei brevi capitoli il volume esplora molte questioni: dalla filosofia dell’econocrazia – fondata sull’auto-percezione scientistica degli economisti – al racconto della sua ascesa dopo la seconda guerra mondiale, avvenuta di pari passo all’affermarsi del concetto stesso di “economia” come una sfera sociale a sé stante e popolata da attori iper-razionali e calcolatori. E ancora, dalla descrizione dei meccanismi di riproduzione dell’econocrazia nelle università, per mezzo dell’accettazione acritica del paradigma neoclassico, al resoconto storico di come altre prospettive teoriche (il marxismo, il femminismo, ma anche il keynesismo e la scuola austriaca, per dirne alcuni) siano state via via marginalizzate nell’accademia per mezzo, tra gli altri, di meccanismi di finanziamento pubblico e peer review non esattamente imparziali.
Se l’econocrazia è un problema sociale, politico e accademico, la sua soluzione deve necessariamente articolarsi in tutte queste sfere. Per gli autori, è necessario che i corsi di economia creino nuovi spazi per le prospettive eterodosse. L’università tutta deve tornare a un modello di istruzione “liberale” in cui gli studenti non siano indottrinati entro i confini artificiali di un campo ristretto come l’economia neoclassica, bensì siano formati come esperti (e prim’ancora cittadini) a tutto tondo, capaci di leggere i meccanismi economici all’interno del loro contesto sociale e politico, e critici rispetto all’esistenza di punti di vista e soluzioni univoche ai problemi sociali.
Ciò, infine, si deve accompagnare a una riapertura dei processi decisionali pubblici nei confronti dei cittadini, e a una trasformazione degli esperti da decisori con delega in bianco a facilitatori di un dialogo costruttivo e informato tra la cittadinanza e le istituzioni, che permetta alla prima di valutare problemi e soluzioni con vera cognizione di causa. Per fare tutto ciò, gli autori presentano una serie di ricette che toccano non solo l’istruzione universitaria e i suoi metodi (per esempio suggerendo modalità di studio e apprendimento “tra pari” e l’estensione all’economia del problem-based learning tradizionalmente utilizzato in medicina), ma anche l’arena della politica, per esempio con la proposta di creare dei comitati di cittadini incaricati di consigliare i decisori politici.
L’originalità di questo volume non è tanto nei suoi singoli contenuti – molto di quello che ci viene detto dagli autori non è particolarmente nuovo – quanto nel modo in cui essi sono confezionati assieme. The Econocracy è un libro che spazia dalla sociologia della conoscenza all’epistemologia, dalle politiche pubbliche alla pedagogia. Ma è proprio questo eclettismo a determinare alcune delle debolezze del volume. Il problema è in primo luogo fisico: gli autori semplicemente non hanno lo spazio a disposizione per analizzare a fondo alcuno dei vari aspetti della loro tesi. Ad esempio, la loro riflessione sull’influenza delle idee economiche dominanti sulle politiche pubbliche non regge il confronto con altri lavori dedicati allo stesso argomento, come Austerity, di Mark Blyth, o il più recente The Power of Economists within the State, di Johan Christensen. In questo senso non aiuta neppure il fatto che il volume sia eccessivamente anglo-centrico nella sua analisi.
I legami tra le varie problematiche esaminate del libro sono, inoltre, a tratti poco chiari. La tecnocrazia, l’omologazione teorica e l’osticità dei modelli neoclassici sono colpevoli in egual modo nella narrativa degli autori. Ma sono, questi, tre problemi ben distinti e in larga parte indipendenti l’uno dall’altro. Earle, Moran e Ward-Perkins saltano troppo spesso da una patologia all’altra senza soffermarsi a sufficienza sui loro rapporti. Solo per fare un esempio, non è affatto evidente che la divulgazione economica al di fuori delle mura dell’accademia sarebbe più semplice in un contesto di maggior pluralismo teorico.
Più spazio, infine, si sarebbe potuto dedicare all’elaborazione delle proposte politiche più ambiziose del volume, in primis quelle volte a rendere l’economia più democratica e “responsabile” – idee attraenti ma non scevre di problemi. C’è una linea sottile che divide, da un lato, l’obiettivo nobile di rendere la cittadinanza più informata per migliorare la qualità della democrazia, e dall’altro la svalutazione delle conoscenze, o della figura stessa dell’esperto, propugnata dal peggior populismo (e spesso facilitata dai social media). Per quanto gli autori affermino il contrario, non è sempre chiaro da quale parte della linea si collochino alcuni dei loro concetti centrali, a partire da quello del “cittadino economista”.
Al di là dei suoi limiti, The Econocracy rimane un’aggiunta di valore alla letteratura critica in economia e nelle scienze sociali più in generale, nonché un utile richiamo al fatto che, per dirla brutalmente, l’economia non è come la fisica. Le analisi empiriche dei tre autori – il loro sondaggio sull’alfabetizzaione economica e la loro disamina dei curricula accademici – sono, in particolare, un contributo interessante, utile e originale a un dibattito che è, esso stesso, condotto troppo spesso in termini oltremodo astratti.
:: per ricevere tutti gli aggiornamenti settimanali della rivista il Mulino è sufficiente iscriversi alla newsletter :: QUI

Riproduzione riservata