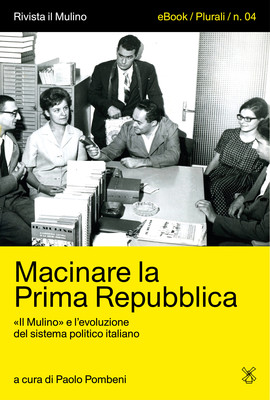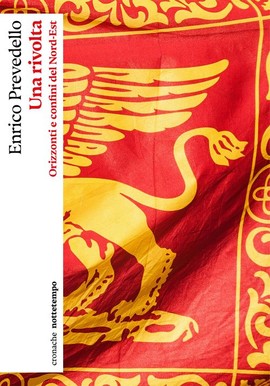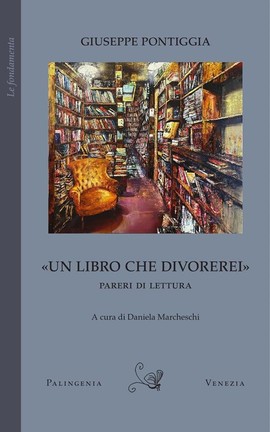Nella prima metà del Novecento, lo psichiatra francese Joseph Capgras descrisse per la prima volta una malattia – da allora sindrome di Capgras – che ha attirato l’attenzione di scienziati cognitivi e filosofi. Chi ne è affetto inizia a credere che le persone a lui più care siano state rimpiazzate da un sosia: pur avendo le stesse fattezze di prima, sarebbero in realtà degli impostori. Alla fine del 2022, il programma radiofonico La Zanzara ha reso popolare l’ascoltatore “Marco da Milano”, intervenuto più volte in trasmissione per lanciare il suo j’accuse: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe stata sostituita da un sosia – peraltro, a suo dire, non molto somigliante – dal Nuovo ordine mondiale. Solo così si spiegherebbe il suo repentino cambio di rotta una volta ottenuta la guida del governo: letteralmente, non è più lei! Meloni premier non è che un docile burattino dell’oscura associazione, mentre l’originale sarebbe stata imprigionata in un carcere segreto nei sotterranei dell’aeroporto di Denver.
A dispetto delle somiglianze tra i due casi, quella di Marco non è la storia di una malattia psichiatrica, ma solo un comico esempio di un fenomeno ben più diffuso: il complottismo. Sebbene abbia accompagnato l’intera storia umana, gli esiti grotteschi e l’attenzione mediatica degli ultimi anni hanno spinto un numero crescente di studiosi a occuparsene da varie prospettive. I filosofi Steven Nadler e Lawrence Shapiro (Quando persone intelligenti hanno idee stupide. Come la filosofia ci salva da noi stessi, trad. it. Cortina, 2022) hanno recentemente dedicato un volume al «bad thinking», il pensare male, evidenziando gli errori logici alla base del complottismo e mostrando come una formazione filosofica allo spirito critico può aiutarci a combatterli. Lo psicologo Rob Brotherton (Menti sospettose. Perché siamo tutti complottisti, trad. it. Bollati Boringhieri, 2017) si è invece focalizzato sui bias e i meccanismi psicologici che ci predispongono a credere alle teorie della cospirazione, argomentando che, entro certi limiti, siamo tutti inclini a caderne vittima almeno qualche volta nella vita.
Nel loro libro per Rosenberg & Sellier (Complottisti vulnerabili. Le ragioni profonde del cospirazionismo, 2023), Emiliano Loria, Stefano Iacone e Cristina Meini hanno adottato un approccio a metà tra i precedenti. Unendo l’expertise di due filosofi e di uno psicologo e psicoterapeuta hanno tentato di addentrarsi nella mente dei complottisti sondandone gli aspetti cognitivi (come pensa un complottista?), emotivi (che cosa prova solitamente un complottista?) e soprattutto motivazionali (che cosa spinge al cospirazionismo?).
Una delle cause fondamentali del complottismo è una condizione di fragilità, unita al desiderio di definire la propria identità attraverso il riconoscimento di una comunità di pari
La loro tesi centrale, suggerita dal titolo, è audace: una delle cause fondamentali del complottismo è una condizione di fragilità, unita al desiderio di definire la propria identità attraverso il riconoscimento di una comunità di pari. Indubbiamente, viviamo in un mondo complesso, che non è facile comprendere e inquadrare in categorie ordinatamente. Questa condizione produce secondo gli autori una fisiologica insicurezza: epistemica, perché in una realtà in cui nemmeno il più brillante di noi può conoscere tutto ciò che l’umanità ha scoperto in millenni è necessario affidarsi ad altri – gli esperti – per sapere cosa fare; ed esistenziale, dato che non è semplice costruirsi un’identità solida senza la speranza di poter controllare e spiegare ciò che accade intorno a noi. È proprio a partire da queste preoccupazioni (che tutti noi condividiamo, in una certa misura) che, per gli autori, alcuni soggetti cadono vittima del cospirazionismo.
Le teorie del complotto sono un lenitivo di queste ansie in almeno due sensi. In primis, danno una spiegazione consolante della realtà. Molti dei problemi che affrontiamo sono complessi e più grandi di noi: possiamo impegnarci a gestire pandemie, crisi economiche e cambiamenti climatici, ma non ne abbiamo un totale controllo. Pensare che la causa di questi fenomeni sia la malvagità di un gruppo di cospiratori – invece di una molteplicità di fattori incontrollabili e una certa dose di casualità – ci fa sentire meno impotenti. In secondo luogo, aderendo a teorie bizzarre, il complottista si costruisce una specifica identità e ottiene riconoscimento sociale. È vero che, per definizione, si contrappone al mainstream (alle «spiegazioni ufficiali» della scienza o delle istituzioni), differenziandosi dalla maggior parte della popolazione; ma, così facendo, si guadagna la stima di piccole comunità di persone scettiche quanto lui. In questo modo, il complottista può costruirsi un’identità che soddisfa due tendenze opposte dell’essere umano: il desiderio di distinguersi e spiccare dalla massa (perché è tra i pochi «illuminati» a scorgere il marcio di cui gli altri sono ignari) e quello di conformità, ossia il bisogno di trovare rassicurazione identificandosi in un gruppo buono.
Secondo Loria, Iacone e Meini, perciò, l’adesione a teorie del complotto non è tanto (o solo) una questione di cattivo uso della ragione, come un filosofo o uno scienziato sarebbero tentati di pensare. Si tratta piuttosto di un modo per affermare la propria identità in risposta a una condizione di incertezza e vulnerabilità. Per sottolineare questo fatto, gli autori distinguono il pensiero basato sull’informazione da quello basato sull’identità. Mentre il primo è attento, realistico e sistematico, il secondo sfrutta ogni scorciatoia di pensiero e qualunque associazione a portata di mano per arrivare a conclusioni che rafforzano la propria identità individuale e sociale. Detto altrimenti, chi adotta uno stile di pensiero basato sull’identità non è alla ricerca della spiegazione migliore dei fatti a sua disposizione; il suo obiettivo primario è supportare quelle tesi che lo definiscono in quanto persona.
Una volta legata la propria identità alla teoria del complotto, risulta molto difficile abbandonare le proprie convinzioni, anche quando il mondo esterno suggerirebbe il contrario
L’importanza dell’identità nell’ostinazione a sostenere teorie del complotto anche di fronte a evidenza contraria diventa evidente nel quarto capitolo – il più avvincente del volume –, in cui gli autori analizzano 5 casi di studio. Attraverso le storie di 5 persone in psicoterapia che hanno aderito a qualche teoria del complotto (il più delle volte legate al Covid-19), Loria, Iacone e Meini mostrano come, spesso, la testardaggine di no-vax e filo-putiniani sia una questione di identità personale piuttosto che di analisi della realtà. I protagonisti del loro racconto si avvicinano a posizioni eterodosse in virtù di idiosincrasie personali. Ma, una volta legata la propria identità alla teoria del complotto, risulta molto difficile abbandonare le proprie convinzioni, anche quando il mondo esterno (e un mero calcolo utilitaristico nelle relazioni sociali) suggerirebbe il contrario: cambiare posizione non sarebbe unicamente la smentita di un’opinione; vorrebbe dire rinnegare ciò che sono stati fino a quel momento.
L’approccio «psicoanalitico» è l’aspetto più originale del volume, che lo distingue sia dai libri filosofici, incentrati sulle norme del ragionamento scientifico violate dai complottisti, sia dai testi psicologici che si focalizzano sui bias cognitivi che affliggono il pensiero intuitivo di tutti gli esseri umani e di cui sono particolarmente preda i teorici della cospirazione. Complottisti vulnerabili propone invece un ritratto psicologico di questa bistrattata categoria. Lo fa osservando le storie di persone in psicoterapia, che evidenziano il ruolo dell’identità personale nell’aderire a teorie del complotto; ma anche rivolgendoci alla psicologia delle relazioni oggettuali. Gran parte del terzo capitolo esplora infatti l’ipotesi che lo scetticismo estremo dei complottisti nei confronti dell’autorità – e, come contraltare, la loro fiducia fideistica in santoni della cospirazione – dipenda da una disfunzionalità del sentimento di fiducia, che si costruisce normalmente nelle prime relazioni tra il bambino e la madre.
Difficile dire se questa sia la spiegazione migliore (o la principale) del cospirazionismo. Certamente, però, con il loro viaggio «psicoanalitico» nella mente dei complottisti, Loria, Iacone e Meini offrono uno sguardo interessante su uno dei fenomeni sociali più discussi del dibattito pubblico.

Riproduzione riservata