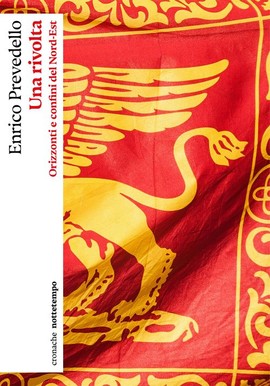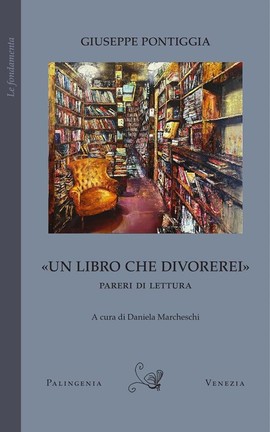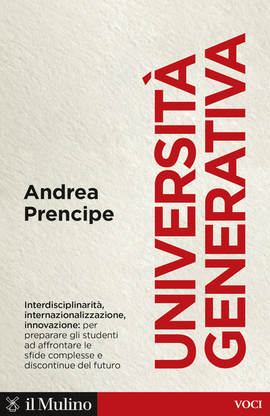Ogni biografia è, per definizione, il tentativo di far rientrare l’esistenza di qualcuno all’interno di una narrazione coerente. È per sua natura conseguenza della scelta di raccontare alcune cose e ometterne altre. È un punto di vista, insomma, e non potrebbe essere altrimenti. Nel caso specifico della biografia di Susan Sontag, il tentativo di farne un ritratto per il pubblico dei lettori è ancor più un’impresa ardua perché non è mai stato facile capire chi fosse realmente. A cominciare dal nome: Sontag era il cognome del secondo marito della madre Mildred. Sue Rosenblatt lo preferì, tra le altre cose, perché le suonava meno ebreo e aveva il presentimento le avrebbe aperto più facilmente la strada alla popolarità tanto desiderata. Susan Sontag, insomma, è praticamente già finzione. Inoltre, per tutta la vita intese l’esistenza come espressione del divario tra la realtà vera e la realtà percepita. Un gioco che si alimentava della tensione tra quello che si è e quello che si vuole raccontare di sé. In bilico tra verità e menzogna. Una condanna dell’interpretazione e al tempo stesso la ricerca di un rifugio sicuro nella metafora (parola che torna spessissimo).
Secondo Benjamin Moser – autore della biografia Sontag. Una vita (Rizzoli, 2023), che gli è valso il Premio Pulitzer nel 2020 – questa sua inclinazione alla finzione derivava dal contesto in cui era cresciuta. Figlia di un’alcolista e con la personalità tipica delle figlie di alcoliste, come la richiesta costante di essere guardata, era stata abituata a raccontare solo una parte della sua vita privata, a dover fare i conti ogni volta con quel «che poteva essere detto», tacendo tutto il resto: questo atteggiamento la contraddistinguerà fino alla sua morte. Indizi della sua persona sono però disseminati tra le sue opere: i personaggi dei suoi racconti spesso parlano indirettamente di lei; i suoi saggi sono una mappa per comprendere quali aspetti della realtà le stanno più a cuore; i suoi diari, pubblicati postumi dal figlio David Rieff, ne lasciano trasparire la sensibilità.
Sempre secondo il suo biografo, Susan Sontag «è stata l’ultima grande star letteraria americana». E immergendosi nelle pagine che la raccontano non si può che esserne d’accordo. Lei, capace di occupare brillantemente la scena come un’icona di Hollywood e caratterizzata da una profondità intellettuale non comune, ha attraversato i decenni del Novecento con la caparbietà di chi non vuole restare ai margini e coltiva idee precise sul suo futuro.
Capace di occupare brillantemente la scena come un’icona di Hollywood e caratterizzata da una profondità intellettuale non comune
Esattamente come Hannah Arendt, voleva essere «una donna, ma prima di tutto una scrittrice». Nelle parole di Moser: «Capì che diventare una scrittrice – una scrittrice vera, di successo, non più una giovane promessa, bensì una persona dotata del vigore e della concentrazione per creare una carriera durevole – era una questione urgente». E la stessa Sontag annota nei suoi taccuini nel 1957, a ventiquattro anni: «È soprattutto una questione di egotismo, suppongo. Perché voglio essere quella persona, una scrittrice, e non perché abbia qualcosa da dire. E tuttavia perché non anche quello?». Un desiderio che diverrà effettivamente realtà. La scrittura avrà un ruolo centrale nel corso di tutta la sua vita: alternando la parola letteraria e la parola filosofica.
Sontag aveva una passione per Thomas Mann, per gli scrittori europei e nel corso degli anni andò sempre alla ricerca di coloro che sapevano raccontare il mondo in modo nuovo. Scrisse per importanti testate americane come «Partisan Review» e frequentò circoli intellettuali. Studiò le opere di Sigmund Freud e iniziò a leggere la realtà e le relazioni con i criteri della psicanalisi. E poi c’era appunto la filosofia. Simone Weil, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jean-Paul Sartre per citare alcuni dei nomi che occuparono un posto di rilievo nelle sue letture e nelle sue riflessioni. Rifiutava un pensiero che «cercava di scoprire formule nel linguaggio secondo il modello matematico» (Judith Spink ebbe a dire «la filosofia analitica era troppo angusta e accademica per lei») mentre era interessata al concetto di «filosofia in mezzo alle rovine (di una cultura, di una vita)».
Un altro tipo di parola emerse in particolari occasioni: la parola politica. «La questione di come opporsi all’ingiustizia tormentava Susan sin dall’infanzia: sin da quando aveva letto I miserabili, sin da quando aveva visto le immagini dell’Olocausto nella libreria di Santa Monica», racconta il suo biografo. La sorte dell’umanità le era sempre stata a cuore e negli anni si interrogò su cosa volesse dire essere un’intellettuale in termini di responsabilità. Era convinta che la propria serietà si dimostrasse nell’«esserci» in determinate situazioni e nel «sentire il peso delle cose». Coltivò idee prima radicali e poi liberali, non si tirò indietro quando fu il momento di prendere posizione nei confronti della guerra del Vietnam, del conflitto in Bosnia o della risposta americana all’attentato alle Torri Gemelle.
Come intellettuale, però, non si concentrò solo sul linguaggio, per quanto fosse un tema che la affascinasse, ma si interrogò anche sul potere e sulla funzione delle immagini. Del resto, una delle sue opere più rappresentative, è certamente il saggio Sulla fotografia. «Non era un libro perfetto, come la stessa Sontag in seguito riconobbe. Ma era un grande libro, la cui grandezza non stava nella perfezione bensì nella fertilità: la capacità di provocare altri pensatori e spronarli a formulare nuove idee. Era l’inizio di una conversazione, non la fine; e se forse non sapremo mai se sia possibile scrivere di fotografia senza accennare a Susan Sontag, è perché quasi nessuno si è preso la briga di tentare».
Susan Sontag è stata certamente scrittrice, accademica, filosofa, giornalista ma è stata anche una donna alle prese con la sua omosessualità, una figlia fragile, una moglie che si sentiva "in gabbia", un’amante non facile, una madre non ordinaria
Il fatto di interrogarsi sulle immagini e sul modo in cui si mostra il reale può essere ricondotto alla sua convinzione che il mondo fosse innanzitutto un fenomeno estetico. «Dimostrò infinita ammirazione per l’arte e la bellezza. E infinito disprezzo per la volgarità intellettuale e spirituale […] Rappresentò il ruolo sociale dell’artista e mostrò come esso possa resistere alla tirannia politica. E tenne viva la speranza del valore permanente della cultura in un mondo assediato dall’indifferenza e dalla crudeltà». La sua vita, del resto, si è alimentata di cinema, musica e di libri: nella sua giovinezza erano la dimensione pronta ad accoglierla quando il mondo vero diventava troppo greve e lei sentiva di non riuscire a reggerne il peso. Persino la sua morte è stata estetizzata attraverso le fotografie della compagna Annie Liebovitz. Ci sono fotografie che la ritraggono in contesti diversi e ne mostrano il volto pubblico e quello privato. Perché Susan Sontag è stata certamente scrittrice, accademica, filosofa, giornalista ma è stata anche una donna alle prese con la sua omosessualità, una figlia fragile, una moglie che si sentiva «in gabbia», un’amante non facile, una madre non ordinaria.
Della sua persona, ci sono tre aspetti che vorrei, infine, richiamare. In primo luogo, la passione per le liste, che per chi ha avuto modo di leggere i suoi diari non è una novità. Questa tendenza le derivò dal protagonista di un’opera di Jack London: «Martin Eden teneva liste di vocaboli e altrettanto, per tutta la vita, fece Susan».
In secondo luogo, l’interesse per le persone impegnate in progetti di autotrasformazione. Susan Sontag provava simpatia per coloro che non si trinceravano dietro granitiche certezze ma si mostravano interessati a una continua ricerca e a una costante riflessione sul mondo.
In terzo luogo, una particolarità. Susan Sontag, quando viaggiava, non guardava mai fuori dal finestrino. Quasi come avesse un rifiuto nel soffermarsi sulla realtà in quanto tale, «al naturale», senza prima averci riflettuto. Nelle parole di Joanna Robertson, a suo tempo fidanzata del figlio: «Vietava a David di guardare fuori dal finestrino di autobus e treni quando viaggiavano […] Diceva che lui aveva bisogno di sapere tutto di un posto, in termini di fatti e storia, per poterlo capire, ma che guardare fuori dal finestrino non gli avrebbe detto niente. Lei non guardava mai fuori dal finestrino durante viaggi del genere…». Lo avrebbe fatto solo anni dopo. Nel 2004 quando il tumore comparso per la prima volta intorno alla metà degli anni Settanta era tornato. Il medico che la visitò stimò che le restassero da vivere all’incirca sei mesi. Durante il viaggio di ritorno in macchina, «guardava fuori dal finestrino. “Wow” disse. “Wow”».
Questo libro è a tratti racconto audace a tratti una testimonianza commovente. È una raccolta di voci su Susan Sontag ed è impossibile dare conto di tutti i tratti della sua persona che emergono: c’è e ci sarà sempre qualcosa che sfugge. Riassumere la vita, specie una vita come la sua, d’altronde, è una sfida già persa in partenza. Ne è consapevole lo stesso Benjamin Moser, che infatti ironizza:
«Aristotele aveva scritto che “la metafora consiste nel dare a una cosa un nome che appartiene a qualcos’altro” e Sontag dimostrò come la metafora formasse, e poi deformasse, l’io; come il linguaggio potesse consolare e come potesse distruggere; come la rappresentazione potesse confortare ed essere al contempo oscena; perché persino un grande interprete dovesse essere contro l’interpretazione. E mise in guardia dalle mistificazioni delle fotografie e dei ritratti: compresi quelli dei biografi».

Riproduzione riservata