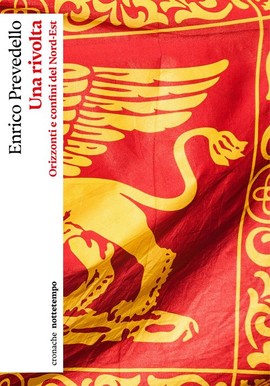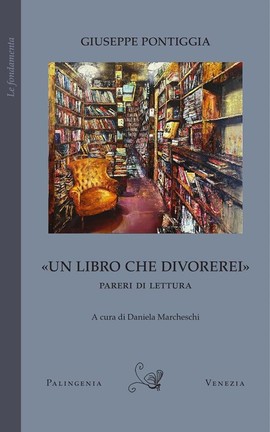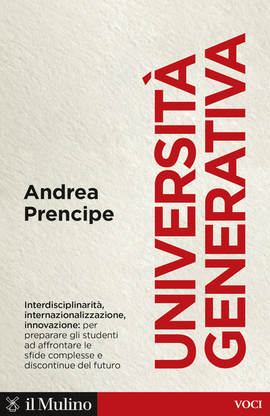Provo a immaginare Corrado Stajano nei giorni più cupi del lockdown della primavera scorsa, quando veniva sconsigliato di uscire di casa se non per le esigenze primarie. Proviamo dunque: legge i quotidiani, mette da parte gli articoli che più lo colpiscono, ascolta i bollettini tv e studia la fisiognomica dei nuovi personaggi che si affacciano sul piccolo schermo, telefona agli amici, fa qualche breve sortita nei dintorni di casa per capire l’aria che tira. Poi si mette al tavolo di lavoro e comincia a prendere appunti. Sta per compiere 90 anni ma nulla gli sfugge. La solita maniacale attenzione ai dettagli che abbiamo appreso leggendo i suoi libri. Il primo, Il sovversivo (1975), oggi un classico, ha inaugurato un genere dove la letteratura, le buone letture, sono al servizio della curiosità giornalistica. Il risultato sono una serie di libri che, nell’ultimo mezzo secolo, hanno disegnato un ritratto del nostro Paese attraverso i suoi eroi civili e le sue ricorrenti miserie. La pandemia è qualcosa di nuovo anche per lui e da lì prende avvio Sconfitti (Il Saggiatore), titolo sferzante per un libro di congedo dal Novecento, nel quale l’autobiografia si mescola a cronaca e storia.
Nelle prime pagine registra il comportamento della popolazione, i canti e le bandiere che presto lasciano posto al silenzio, interrotto solo dalle sirene delle ambulanze. Non tutti possono restare a casa, anzi. I rapporti tra le classi sociali sono ancora più definiti: resta a casa chi può permetterselo, ma molti sono costretti a uscire per mandare avanti i servizi necessari (e sono tanti). Non stanno ferme nemmeno le mafie, che approfittano degli squilibri creatisi per fare nuovi affari. Stajano è d’accordo con la prospettiva storica di Aldo Schiavone: «è una emergenza, grave e rischiosa», non una guerra, parola che tuttavia risuona dappertutto. Il libro offre attraverso le sue pagine un’antropologia degli italiani e così lo scrittore annota (l’ironia, a volte beffarda, è un’altra delle sue caratteristiche) che già verso maggio, mentre i morti sono ancora centinaia ogni giorno, i principali quotidiani sono soprattutto preoccupati di capire come si prospettano le vacanze e quale sarà il distanziamento minimo da tenere in spiaggia.
La prima parte del volume si chiude interrogandosi se «il funereo contagio del secolo nuovo» sia la coda di quello finito ormai da oltre vent’anni.
La prima parte del volume si chiude interrogandosi se "il funereo contagio del secolo nuovo" – la pandemia – sia la coda di quello finito ormai da oltre vent’anni
E allora riprende il filo dell’autobiografia, partendo dagli anni dell’ultima guerra, vissuti tra la fine dell’infanzia e l’inizio dell’adolescenza. Il padre, ufficiale dell’esercito, è prima nella campagna di Russia, poi prigioniero di un lager nazista, ma Stajano ha troppo pudore per raccontarne le vicende. Piuttosto si affida ai resoconti di uno dei suoi attendenti: Nesi Domenico, classe 1917. Il tempo di guerra è gravido di angosce, ma per un ragazzo anche pieno di avventure quotidiane. Si cresce più in fretta. I giorni della Repubblica Sociale («la repubblichetta», come veniva chiamata con scherno) sono una mascherata tragica, con i compagni di classe di 14-15 anni in camicia nera. Non basta l’esplosione di gioia della Liberazione, i balli nelle piazze e nei cortili, per liberarsi del passato. Riprende le parole dell’amico Cesare Garboli sul fascismo: «un male forse geneticamente inseparabile dalla natura degli italiani, i quali, per atavica sindrome imperiale, si sentono fascisti appena si sentono italiani».
Ci sono, per fortuna, anche altri italiani. Uno di questi è Nuto Revelli, per Stajano una figura che è una via di mezzo tra un padre (colui che gli racconta la guerra di Russia, cosa che il padre non riuscì mai a fare con lui) e un fratello maggiore a cui volgersi nel momento del dubbio. «Lo studio di Nuto a Cuneo gli assomigliava. Essenziale e severo». E poi, alle pareti, due grandi foto: l’immagine di tre partigiani condotti a morte dai fascisti e un ritratto di Ferruccio Parri, «un crisantemo sopra un letamaio», come lo definì Carlo Levi nell’Orologio. Quando, a mia volta, ho visitato lo studio di Revelli, oggi sede della Fondazione a lui intitolata, ho pensato che se ogni capoluogo di provincia avesse potuto contare su una figura di tale statura morale, il nostro sarebbe un Paese di gran lunga migliore. Attraverso Revelli, Stajano rievoca la campagna di Russia, la guerra di Liberazione, il difficile reinserimento tra una popolazione che aveva solo voglia di dimenticare, la ripresa nel dopoguerra. Nuto, come Stajano, «non dimentica niente» e da lì nascono i suoi libri, ancora oggi strumenti indispensabili per capire la nostra storia «dal basso» e le trasformazioni della nostra società.
Nel ricordo di Stajano gli anni Cinquanta furono soffocanti, con una società ingabbiata dalla gerarchia ecclesiastica presieduta da Pio XII. Agitando lo spettro del comunismo, non ci fu cesura tra fascismo e la nascente Repubblica. Le cose cambiarono attorno al 1960, quando un rigurgito di fascismo – un governo monocolore della Dc con l’appoggio esterno del Msi – viene bloccato dalle proteste nelle strade di Genova («i ragazzi dalle magliette a strisce») e dai morti di Reggio Emilia. Siamo agli anni del «miracolo economico», quando è la rivoluzione dei consumi più che le riforme, quasi sempre rimaste a metà, a cambiare la società. Bastano due flash per illuminarli: il cavalier Borghi, proprietario della Ignis, col suo familismo aziendale, e Mina, concittadina di Stajano, «colonna sonora dell’Italia del boom». Sono anche gli anni in cui le campagne si spopolano. Non so se si possa attribuire un valore simbolico al fatto che la bomba di piazza Fontana venne fatta esplodere nella Banca dell’Agricoltura un venerdì pomeriggio, quando restava aperta più a lungo del solito per consentire agli agricoltori calati in città per il mercato agricolo di depositare assegni e denaro contante. Stajano è tra primi ad accorrere: «Vidi dietro i banconi degli impiegati l’orologio della banca di cui non mi ero accorto. Si era fermato alle 16.37. Quasi un notaio della strage. Farà il giro del mondo, alla tv e in fotografia». Seguono giorni indimenticabili: i funerali delle vittime in piazza del Duomo sotto un cielo plumbeo, la morte di Pinelli, il suo funerale. Non si crede più alle verità dello Stato. I giornalisti, sotto l’impulso di Camilla Cederna, allora davvero una leonessa, presidiano la Questura, incalzano i funzionari chiedendo chiarimenti sulla morte di Pinelli. «Chiesi a Calabresi perché non era sceso in cortile a vedere un uomo che pochi minuti prima era vivo nella sua stanza. Nessuna risposta. Rifeci testardamente la domanda, accolta anch’essa con il silenzio. Mi sembrò già allora un agire umanamente inqualificabile. Era mancato quasi un barlume di pietà».
Stajano, pur avendo collaborato per più di mezzo secolo con la carta stampata, non ha mai fatto vita di redazione. Tuttavia, non gli è mai mancato l’istinto del cronista. Così, alla notizia dell’assassinio del generale Dalla Chiesa, prende il primo aereo per Palermo. Annusa l’aria e capisce rapidamente che il generale è stato lasciato solo. Non è stato protetto, nonostante le rassicurazioni di chi l’aveva mandato lì. Dalla Chiesa, nei suoi 100 giorni a Palermo, ha assistito a una mattanza, quasi un morto al giorno, ma la Dc siciliana è un tradizionale serbatoio di voti di Giulio Andreotti e chi tocca certi equilibri se la va a cercare, per utilizzare un’espressione del futuro senatore a vita. Da un funerale all’altro. Ogni tanto Stajano si autoantologizza: è il caso del pezzo sul funerale di Falcone: «Poi avviene un fatto eccezionale e bellissimo. L’annuncio di una piccola Giovanna d’Arco, dolce e innocente furia cristiana», e riprende le frasi memorabili di Rosaria Schifani: «Io vi perdono, però voi dovete mettervi in ginocchio se avete il coraggio di cambiare. Ma non cambiano, non cambiano...». Stajano aveva conosciuto Falcone tredici anni prima, nel 1979, e i due si erano intesi subito, entrambi abituati a capire con un colpo d’occhio chi si ha davanti. Del magistrato ammira il metodo («follow the money»), la sagacia investigativa, l’abilità di attraversare i veleni della politica e della magistratura. Ma il suo assassinio, e quello di Borsellino che segue, sono una pugnalata per le speranze di molti.
Il rinnovamento, allora così sembrava, della classe dirigente nel passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica spingono Stajano ad accettare l’offerta di candidarsi come indipendente al Senato nelle fila del Pds. A quell’esperienza ha dedicato un libro molto bello, Promemoria (1997), e, dagli scranni di Palazzo Madama, ha potuto assistere al debutto in politica di Silvio Berlusconi. Ne ricostruisce le gesta, l’opacità dei primi finanziamenti, l’iscrizione alla P2. Ne ricorda, attraverso la biografia che gli ha dedicato Giuseppe Fiori (Il venditore, titolo azzeccatissimo) le caratteristiche salienti: «la spregiudicatezza, l’ambiguità, il passo sicuro nel dedalo dei segreti, la furbizia, il senso del clan, l’attitudine ad accentrare e il gusto del comando, lo smisurato concetto del proprio io, il ritenere impossibile non avere sempre ragione, l’attrazione costante per i gesti accattivanti, la cordialità esibita, il desiderio di piacere a tutti». Memorabile uno scontro tra i due in Senato. A futura memoria, per chi lo vorrebbe come capo dello Stato, Stajano ricorda i processi in cui Berlusconi è ancora coinvolto, le prescrizioni ottenute schierando batterie di avvocati.
Stajano, pur avendo collaborato per più di mezzo secolo con la carta stampata, non ha mai fatto vita di redazione. Tuttavia, non gli è mai mancato l’istinto del cronista
Il libro si chiude, a specchio, con i giorni della pandemia dell’ultima primavera, il limbo in cui siamo vissuti e che, italico more, abbiamo prontamente dimenticato. Si insedia il governo Draghi e l’impressione è che un maestro severo sia entrato in una classe di asini, ma che presto riprenderà il frinire di un popolo di cicale. Il finale, affidato a due versi di Montale, è molto amaro. Sconfitti? Preferisco chiudere con due citazioni ben note: «Il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà», un motto che Antonio Gramsci riprende da Romain Rolland; e «Fai quel che devi, accada quel che può», una frase che si ritrova in Kant e poi in Tolstoj, quasi uno slogan per Gaetano Salvemini, che visse in tempi più cupi dei nostri e morì, dopo una vita di lotte, nel suo letto a Sorrento, circondato dall’affetto di persone care. Non da sconfitto.

Riproduzione riservata