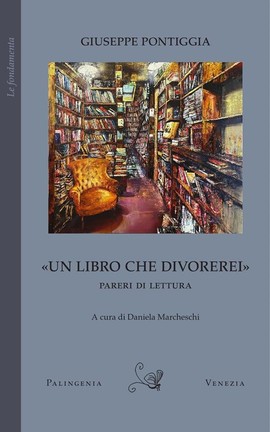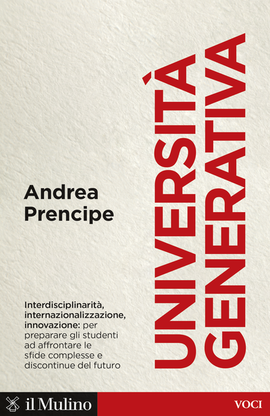C’è, nel discorso pubblico intorno alla cultura e alle arti, l’abitudine a indulgere ai riflessi, a reagire cioè automaticamente, di fronte a certi oggetti, con entusiasmo o costernazione, come se il pacato consiglio di Spinoza (non ridere, non piangere, cercare di capire) non si applicasse ai libri, alle canzoni o al cinema come a tutto il resto. Così capita che Zerocalcare pubblichi un nuovo fumetto, Quando muori resta a me, e nel giro di qualche giorno una ventina di elzeviristi si prodighi in elogi, da un lato certificando la trasformazione di Zerocalcare in un feticcio culturale, dall’altro cogliendo l’occasione soprattutto per definire la propria identità pubblica, per rivendicare uno status collettivo, un’appartenenza.
Riflessi, appunto. Solo che discuterne così è un peccato: un po’ perché un autore che ormai da qualche anno è stabilmente in cima alle classifiche di vendita va preso sul serio (e insomma è il caso che alle opinioni esagitate dei fan o superciliose degli snob se ne aggiungano altre, meglio argomentate); un po’ perché Zerocalcare non è Akira Toriyama, l’autore di Dragon Ball: a essere diverse sono le intenzioni, le aspirazioni, perciò l’orizzonte entro cui vanno giudicate le cose che fa non può essere quello del puro intrattenimento (a cui uno può anche non chiedere nulla); e un po’ perché ragionare sul successo di Zerocalcare significa anche, mi pare, ragionare sul modo in cui ci stiamo abituando a giudicare libri, fumetti o serie TV, e più in generale su quello che chiediamo alla cultura. Insomma, passata qualche settimana, e registrati i riflessi, vale la pena occuparsi di Quando muori resta a me.
Per cominciare, il plot. La storia è quella di Zerocalcare e di suo padre, del loro difficile rapporto, delle barriere costruite negli anni e diventate un’abitudine. L’occasione per raccontarla è data da un viaggio a Merìn (dove c’è la vecchia casa del padre da sistemare); un viaggio che innesca una serie di domande più o meno pressanti, costringendo Zerocalcare a rimestare nella memoria e a macerarsi di fronte a un passato di cui sente confusamente di non possedere la chiave. C’è un ricordo in particolare che affiora con una certa insistenza: è tardi, piove molto; il padre rientra a casa bagnato fradicio, chiaramente turbato per qualche ragione. Zerocalcare un po’ si preoccupa: si è dimenticato l’ombrello, gli dice, non è da lui; e poi ha una faccia terribile: va tutto bene? Silenzio. Ma dura un attimo, giusto il tempo di svicolare inventando una storia: che c’entra l’ombrello, non è mica zuppo di pioggia, è che a combattere sulle sponde dell’Aniene contro Merman – il cattivo cattivissimo di Master of the universe (cioè il cartone animato preferito dal figlio seienne) – succede che ci si bagna. Incredulità, ammirazione, sipario. Sembra uno di quei momenti di tenerezza che non si ripetono spesso nell’arco di una vita; e invece, si scopre, è un modo per nascondere il divorzio dei genitori, e la paura del padre che tutto possa guastarsi irrimediabilmente. E la scoperta, insieme al ricordo, cambia anche tutto il resto, a partire dall’idea che Zerocalcare si è fatto del padre e del loro rapporto – e della loro distanza, anche. Cioè, non proprio tutto: l’ammirazione resta, come la tenerezza; a cambiare sono le ragioni di questi sentimenti. Ma tutto questo in realtà è quasi secondario, perché il fumetto, più che su una serie di eventi, è costruito intorno alla ripetizione di un unico motivo: l’impossibilità di parlarsi. Per questo ai ricordi è lasciato così tanto spazio: perché sono l’unico piano cui è ancora possibile affidarsi per capire meglio, per scoprire almeno un pezzetto di verità.
Una delle prime cose che si notano leggendo i fumetti di Zerocalcare è la presenza vischiosa dell’io narrante. Il fatto è che, così ostinatamente ripiegato sui suoi crucci reali e immaginari, Zerocalcare sembra più interessato a guardarsi vivere che a scomporre i sentimenti profondi dei suoi personaggi, a capirne le ragioni, i conflitti, le ambiguità – con il risultato che le figure che emergono qua e là nei suoi fumetti finiscono per perdere concretezza, inchiodate come sono a ruoli da interpretare. Inoltre, anche nelle rare occasioni in cui l’io smette di stare sul proscenio, le vite degli altri esseri umani – anziché accendere l’immaginazione dell’autore – vengono appena registrate, e solo in quanto sineddochi di appartenenza, ossia per marcare l’adesione a un certo orizzonte politico-culturale, a una causa, a un set di ideali o valori che trovano così spazio e rappresentanti sulla pagina; sicché sembra davvero che a Zerocalcare il mondo appaia diviso tra compagni solidali nella lotta e filistei antidemocratici, in una visione tribale della realtà, in cui ogni episodio concreto, ogni presa di coscienza, ogni crescita si riduce a sintomo. C’entra forse un ambiguo senso di inadeguatezza, che un po’ resta appeso a languide autocommiserazioni e un po’ costringe a cercare delle soddisfazioni vicarie (l’anedonia che Zerocalcare esibisce spesso nei suoi fumetti fa da pendant all’esaltazione per i successi dell’impegno politico, delle cause di cui si fa promotore); salvo che se nei romanzi questo narcisismo un po’ depresso è solo spiacevole, nei reportage diventa imperdonabile, per la buona ragione che quando si racconta di cose tremende come la guerra, la vita degli altri è quasi l’unica cosa che conta. Insomma, è una perdita (di complessità certo, ma anche di qualità), e però bisogna prenderne atto, perché una buona parte dei prodotti culturali che negli ultimi anni hanno avuto più fortuna di pubblico sono costruiti così, con personaggi incapaci di sentimenti profondi, che restano incollati al proprio stereotipo (M di Scurati, ma anche i Bridgerton di Shonda Rhimes).
Leggendo non si riesce mai davvero a sbarazzarsi dell’idea che Quando muori resta a me ricordi certi pretenziosi memoir in cui al racconto delle umiliazioni, dei fallimenti, delle privazioni di una vita si sostituisce il racconto di una fantasmatica crisi
A proposito di sentimenti, leggendo non si riesce mai davvero a sbarazzarsi dell’idea che Quando muori resta a me ricordi certi pretenziosi memoir in cui al racconto delle umiliazioni, dei fallimenti, delle privazioni di una vita si sostituisce il racconto di una fantasmatica crisi, tramato però di minimi intoppi, di ostacoli che non sembrano, che non sono, davvero insormontabili, nell’illusione che il rapporto sia di uno a uno. Salvo che le cose ovviamente non stanno così: altrimenti LMVDM di Gipi – che parla appunto di un’esistenza consumata nel dolore, senza alcun esito – non sarebbe quel capolavoro che è. Ora, in realtà nel fumetto almeno una ragione di attrito ci sarebbe, anche se non esce dal perimetro della vita intima del narratore, vale a dire il senso di colpa di Zerocalcare – è il basso continuo che lega il racconto di moltissimi ricordi. Ma intanto questo senso di colpa sembra posticcio, cioè più che dipendere dal comportamento del padre (che non è veramente crudele e non trae piacere dal vessare il figlio) va attribuito alle insicurezze e, soprattutto, alle ubbie di Zerocalcare stesso; e poi resta quasi sempre sullo sfondo, e le poche volte in cui sembra aggallare insieme ai ricordi viene puntualmente aggirato o sedato a colpi di ironia e buon senso, prima che possa trasformarsi in qualcosa di più spaventoso come il rimorso, il risentimento, un falso sé.
E insomma manca al tono e al ritmo del racconto quella corrosività che rende perfetti, per esempio, certi romanzi a fumetti di Will Eisner (su tutti, Contratto con Dio). Ma di nuovo: questa vocazione alla medietà – nello stile, nei contenuti, nei personaggi – è precisamente ciò che fa vendere a Zerocalcare la montagna di copie che vende: un po’ perché asseconda l’idea puerile che i prodotti culturali siano interessanti nella misura in cui parlano di noi, della nostra vita, dei nostri malanni; e un po’ per la facilità con cui questa medietà rassicurante cade nell’esagerazione, nel melò.
Ma ciò che si perde in profondità si può recuperare in ampiezza. Così, per tenere in piedi un racconto che altrimenti franerebbe per i movimenti troppo superficiali dei personaggi, per i loro modi elusivi di fronte alla realtà che li circonda, Zerocalcare ricorre, da un lato, alla storia ominosa degli avi, che serve a proiettare sul rapporto col padre l’ombra di un destino, intrecciando presente e passato a rancori antichissimi che però c’entrano ben poco con la vicenda raccontata nel romanzo; dall’altro usa la propria vita per affrontare temi più o meno caldi, sincronizzati sul dibattito corrente e capaci di mobilitare il pubblico sul piano morale – dalla questione demografica a quella di genere.
Senza entrare nel merito di quest’abitudine a fare da cassa di risonanza alle buone cause, su cui si è già scritto e argomentato molto, il vero problema dei fumetti di Zerocalcare è il tono didascalico, che punta al massimo della semplificazione per ottenere il massimo della spendibilità crossmediale, condensando in una manciata di pagine una serqua di lezioni etico-politiche. E non bastano a rendere meno penosa la lettura le troppo frequenti dichiarazioni di essere in realtà un essere umano meschino, la sindrome dell'impostore esibita come una patente di sincerità o il fatto che, spesso, si possa anche essere d’accordo con la sostanza dei messaggi (certo che se uno non mette al mondo dei figli ha le sue buone ragioni; certo – con buona pace dei rant degli editorialisti di destra – che bisognerebbe lasciarlo in pace: ma resta il fatto che uno vorrebbe leggere una storia, non un sermone su come si deve stare al mondo).
Il nocciolo della questione è che i romanzi belli non si fanno con il senso di responsabilità, la correttezza politica o gli anatemi; si fanno curando lo stile, la forma, fissando sulla pagina la complessità dei sentimenti e delle passioni che ci interrogano di più, e con più urgenza, descrivendo con la giusta profondità certi commoventi paesaggi umani, percorrendo labirinti psicologici. Ma del resto sono proprio queste cose che ci stiamo disabituando a chiedere ai libri, all’arte (che si tratti di romanzi a fumetti o serie TV); solo che non sono così sicuro che ciò che otteniamo in cambio – la fregola di incidere, di schierarsi, i personaggi evanescenti, la poca cura dello stile – valga ciò a cui stiamo rinunciando.
I romanzi belli non si fanno con il senso di responsabilità, la correttezza politica o gli anatemi; si fanno curando lo stile, la forma, fissando sulla pagina la complessità dei sentimenti e delle passioni
Schivato il citazionismo pop, l’approccio tribale e il pedagogismo corrivo quello che resta in mano al lettore è, mi pare, troppo poco. In un articolo di qualche anno fa pubblicato su "Vice", Valerio Mattioli ha scritto più o meno che Kobane calling può anche non piacere ma è un fumetto riuscito perché ha fatto in modo che in Italia si parlasse di più e meglio del Rojava. Sospetto che argomenti del genere si useranno (e sono già stati usati) anche a proposito di Quando muori resta a me; del resto, se è vero – come a me pare vero – che è importante parlare del patriarcato, della mascolinità tossica come modello sociale e famigliare, perché non si dovrebbe apprezzare un fumetto che lo fa addirittura con il coraggio dell’autobiografia? Può darsi che questo rovesciamento di prospettiva sia davvero desiderabile (certe battaglie politiche, sociali, sindacali sono sacrosante). Può darsi.
Ma l’idea che un prodotto culturale vada giudicato basandosi su criteri esterni più che interni, e cioè sull’effetto che produce sulle coscienze, più che sulle qualità del racconto o sulla sottigliezza delle idee messe in campo, non è una buona idea. Perché in genere questo moralismo finisce per diventare l’ennesima reincarnazione dello zdanovismo; perché i valori hanno confini fluidi – che le traiettorie di vita degli individui attraversano a seconda delle occasioni, dei tempi, delle comunità di appartenenza –; e perché le posizioni virtuose producono più che altro conformismo e retorica, soprattutto quando hanno bisogno della condanna del vizio per essere esibite con più forza o evidenza.

Riproduzione riservata