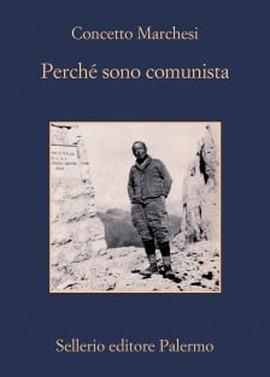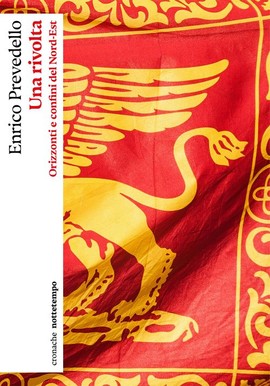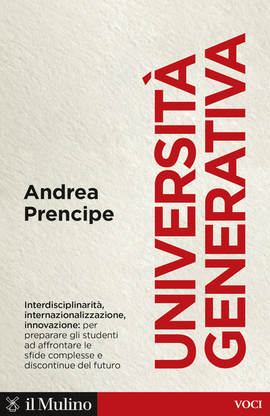«Parlare di sé è impresa ambiziosa e fastidiosa e mortificante spesso»: così esordisce Concetto Marchesi il 5 febbraio 1956 al Teatro Nuovo di Milano, dinanzi agli Amici della rivista «Rinascita». È questo un topos al quale Marchesi, studioso degli antichi uomini della parola e «uomo della parola» egli stesso, non si sottrae. Dieci anni prima, il suo compagno di partito e collega costituente Emilio Sereni, nel licenziare uno scritto autobiografico destinato alla collana Dirigenti comunisti aveva scritto: «Ma accidenti a quando bisogna dir bene di sé: è quasi più piacevole, ancora, farsi l’autocritica».
In realtà, l’autobiografia dei comunisti – dai dirigenti ai quadri ai militanti – fu un vero e proprio genere letterario: non per caso, ma per la verità che da ogni autobiografia può scaturire. Nel prologo a L’età forte, Simone de Beauvoir osservava: «Mediocre o eccezionale che sia, se un individuo si descrive con sincerità, la cosa tocca più o meno tutti. Impossibile far luce sulla propria vita senza illuminare in qualche punto quella degli altri». Le autobiografie dei comunisti non furono prive di tagli, omissioni, aggiustamenti e adulterazioni; tuttavia, per molti aspetti, esse parlano al lettore di oggi, come al coevo al quale erano destinate.
L’autobiografia dei comunisti – dai dirigenti ai quadri ai militanti – fu un vero e proprio genere letterario: non per caso, ma per la verità che da ogni autobiografia può scaturire
La pratica autobiografica fu diffusa nel Partito comunista a tutti i livelli dell’appartenenza e della militanza. Nel libro Fabbrica del passato (ripubblicato da Quodlibet, 2021, con una prefazione di Carlo Ginzburg e una nuova introduzione), Mauro Boarelli ha raccolto le autobiografie dei militanti comunisti emiliani del secondo Dopoguerra, ricostruendone genesi, modelli e contesti. Mai studiate nel loro insieme, invece, sono le autobiografie dei dirigenti, come Sereni, e dei militanti più illustri, quale fu Marchesi. Boarelli ricorda, nella sua prefazione, che «la fine del Partito comunista italiano ha comportato l’abbandono della politica del ricordo», in una combinazione pericolosa di subalternità culturale e rimozione storica.
A cura di Luciano Canfora, Sellerio ha pubblicato un testo autobiografico di Concetto Marchesi, Perché sono comunista: e sotto questo titolo sono raccolti due ulteriori brevi testi che con il primo si incastrano e si illuminano vicendevolmente. I tre scritti costituiscono, in realtà, delle trascrizioni di discorsi che Marchesi tenne, rispettivamente, nel 1956 a Milano, come si è detto (Perché sono comunista, pp. 40-64); nel 1945, il 16 aprile, a Palazzo Capizucchi a Roma (La persona umana nel Comunismo, pp. 65-84); e ancora nel 1956, il 9 dicembre, all’VIII congresso del Pci (Testamento politico, pp. 85-102).
I tre discorsi erano stati pubblicati sparsamente, pertanto è utile ricordare qui le sedi delle prime edizioni per la praticità del lettore: gli Scritti politici di Marchesi (Editori Riuniti, 1958); la rivista «Rinascita» (vol. 2, 4, aprile 1945); gli Atti e risoluzioni dell’VIII Congresso (Editori Riuniti, 1957).
Canfora riflette da oltre trent’anni intorno alla figura di Marchesi, a partire da La sentenza (Sellerio, 1985), dove indagava il ruolo di Marchesi nell’assassinio di Giovanni Gentile, fino al recente e monumentale Il sovversivo (Laterza, 2019). Il volume Perché sono comunista si può leggere isolatamente come summa della «fede» comunista di Marchesi; tuttavia, il commento più ampio ai tre scritti si trova nelle pagine del libro di Laterza, al quale il lettore curioso potrà ricorrere.
Nell’Introduzione a Perché sono comunista, Canfora illustra il primo dei tre pezzi. L’autore getta luce sul contesto storico e politico dello scritto, ne ricostruisce la genesi e ne isola i nuclei principali: gli autori e le opere che Marchesi cita come fondamentali nella propria formazione (Proudhon, Mazzini, e soprattutto il Manifesto); la vitalità del socialismo; l’unità d’azione e d’intenti dei mesi della Resistenza; la figura di Silvio Trentin, alla quale dedica un ricordo ampio e commosso, con una riflessione sul rapporto non ovvio e non necessariamente conflittuale fra comunismo e cristianesimo e una conclusione che insiste sulla nozione del comunismo come «fede». Infine, significativamente, Canfora ritrova la traccia del pensiero di Marchesi nell’ultimo Togliatti, che a Marchesi fu legato da rispetto e forse devozione.
Nella sua struttura e per molta parte dei contenuti, il primo dei tre scritti di Marchesi riflette molti dei topoi che si incontrano nelle autobiografie dei suoi compagni di Partito: dall’informazione, spesso parziale e ritoccata, intorno alle origini familiari, fino alla menzione dei libri e degli studi decisivi; dalla ricostruzione del contesto geografico (il Sud della campagna siciliana) entro il quale maturò la passione e l’ideologia, all’evocazione degli amici caduti nei mesi della battaglia resistenziale. Quando ricorda il nome di Silvio Trentin, Marchesi sembra tornare a rivestire la toga del rettore che era stato, all’Università di Padova, nei tre mesi dal settembre alla fine di novembre 1943: «Centro, cuore, cervello dell’agitazione e dell’organizzazione militare veneta era l’Università». Del resto Marchesi, quando morì, portava con sé, come sempre, un biglietto in cui pregava di avvertire il Partito e l’Università di Padova, i due poli entro i quali si era svolta la parte più significativa del suo operato. Nel rievocare dinanzi ai compagni della federazione milanese la figura di Trentin (e di conseguenza il movimento Giustizia e Libertà), egli precisa: «E al Partito comunista [Trentin] tese la mano, come mai prima era avvenuto fra uomini di varie posizioni politiche».
«Commilitone diletto e perduto», Trentin «oggi sarebbe al fianco del popolo lavoratore contro le forze coalizzate del capitale e della Chiesa». Di qui, Marchesi ragiona intorno al cristianesimo come forza non inconciliabile con il socialismo: è questo il filo che lega – a me pare – il primo e il secondo testo di questa raccolta. Nello scritto La persona umana nel comunismo, Marchesi insiste sulle forze intellettuali e spirituali della persona umana, in realtà – egli argomenta – non inculcate dal comunismo. Le parole di Marchesi (che risalgono, come si è detto, al 1945) sollevano questioni ancora urgenti: egli ricorda che, grazie alla scuola, «l’individuo prende nel mondo quel posto che la natura gli ha consentito e che la mala sorte non gli può negare»; si duole che il nostro Paese abbia saputo «somministrare» al ceto popolare e operaio solo «una letteratura di volgarissima curiosità, frivola e vuota e bene adatta a mantenere basso il livello morale di una classe destinata allo sfruttamento»; riflette sulla moderna schiavitù economica, diversa dall’antica solo in quanto «ha catene meno vistosamente legali ma più paurose: perché lo schiavo antico ha un padrone, lo schiavo moderno ha dovuto anche mendicarlo e chiederlo come un beneficio». Contesta una lettura unicamente economicistica dei valori intellettuali e l’identificazione dell’«utile personale» come solo «stimolo al miglioramento della produzione», e osserva: «domandatelo ai laboratori scientifici dove giovani e vecchi, senza altra avidità che quella del conoscere, attendono all’assidua, quotidiana ricerca di un’umana provvidenza»; riflette sul privilegio immutabile di quanti «nell’alterna vicenda del prevalere e del soccombere, arrivano prima degli altri e sopra gli altri». In questo testo, pronunciato pochi giorni prima del 25 aprile 1945 e animato da una «fede» fervida e progressista, Marchesi conclude che la necessaria ricostruzione è anzitutto «risuscitare la persona umana».
I lavoratori non ci intenderanno se non sentiranno nelle nostre parole quello che è contenuto nell’animo loro
È una fede che Marchesi, poche settimane prima della morte, squaderna dinanzi ai compagni riuniti nell’VIII congresso. Una fede che si spinge fino alla difesa dell’intervento sovietico in Ungheria e alla riflessione – dove parla l’antichista prima, più che il comunista – sulla parola «democrazia», che «sin dai tempi dell’antica Grecia ha gettato gli uomini in un mare di guai»: non a caso, egli osserva, lavoratori e contadini continuano «a sostenere con il loro voto democratico gli interessi dei propri sfruttatori». Ma, a un tempo, Marchesi invita i compagni a essere democratici nel rendere consapevoli «codesti cittadini di ciò che giovi all’interesse loro e della comunità lavoratrice». In un passaggio di questo celebre discorso, egli profetizza: «I lavoratori non ci intenderanno se non sentiranno nelle nostre parole quello che è contenuto nell’animo loro».
Qui sembrano riecheggiare le frasi che, pochi mesi prima, aveva pronunciato al Teatro Nuovo: evocando le vendemmie e le falciature della sua campagna catanese, «filari e filari di viti dentro un’ampia cerchia di mandorli e ulivi», le vendemmiatrici e i lavoratori scalzi e coperti di stracci, sentiva crescere in sé – egli scrive – «un rancore sordo verso l’offesa che sentivo mia, che era fatta a me e gravava su di me come una insensata mostruosità». La conclusione è maestosa: «Avevo l’animo dell’oppresso senza averne la rassegnazione». È una sorta di homo sum del quale l’aristocratico e dotto professore sembra farsi carico – almeno nella rappresentazione autobiografica – fin dall’infanzia.
In dicembre, all’VIII congresso, Marchesi dichiara di parlare «in nome degli intellettuali comunisti: giacché a me spetta questa gravosa qualifica». Qui è forse il motivo più vitale di questi scritti, e insieme un tratto più che mai significativo della sua singolare figura di studioso e di politico, di antichista e comunista: l’umanesimo profondo di chi nulla di umano trova alieno da sé, e come intellettuale lo dichiara e ne fa materia di battaglia. Questo volume sembra, a tratti, un’unica riflessione intorno al ruolo dell’intellettuale; è forse questa una delle ragioni per cui Luciano Canfora non ha mai smesso di lavorare intorno a Concetto Marchesi.
A Marchesi, Indro Montanelli rimproverò di aver vissuto – in quanto «insigne latinista» – di null’altro che di «morti». Dinanzi a queste pagine, che raccolgono tormenti e domande ancora urgenti nell’agonia della sinistra, è forse necessario chiedersi se non si debba invece proprio allo sguardo lungo dell’antichista che era in Marchesi – il Marchesi comunista, partigiano e uomo politico – la risonanza durevole delle sue parole, che parlavano ai vivi e parlano a noi che siamo venuti dopo.

Riproduzione riservata