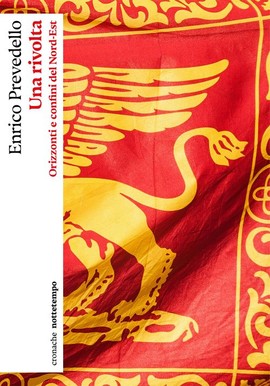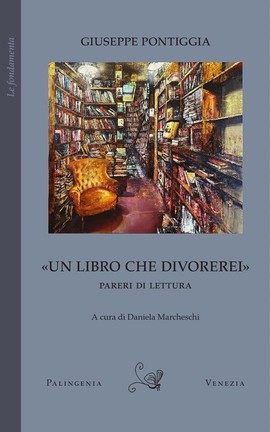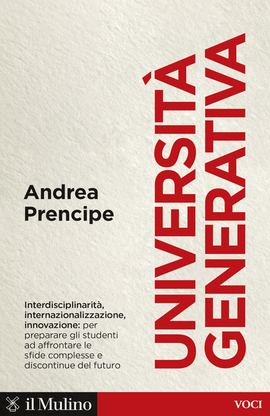“Piazze piene, urne vuote”: queste celebri parole di Pietro Nenni, pronunciate all’indomani del 18 aprile 1948, nel corso degli anni sono state spesso evocate per smorzare i troppo facili entusiasmi, dinanzi ai più vistosi momenti di mobilitazione popolare. È vero, tuttavia, per restare in Italia, che in alcuni passaggi storici, le piazze “piene” (della sinistra) hanno trovato anche un riscontro nelle urne. Per alcuni decenni non è più accaduto: le piazze si sono riempite sempre meno, e anche le urne piangevano. Qualche piazza, tuttavia, anche recentemente, è apparsa tornare ad affollarsi, a segnalare il fatto che l’assenza di movimenti collettivi non è un destino ineluttabile del nostro tempo. Il punto di partenza, allora, non può che essere un’analisi realistica dei processi maturati in questi anni.
Il rapporto tra i livelli e le forme della partecipazione politica e il loro rifrangersi nel sistema della rappresentanza politica è profondamente cambiato. Da un lato, non sono mancati movimenti collettivi che, in modo carsico, esplodono e poi si inabissano; dall’altro, la politica tende a muoversi secondo logiche sempre più chiuse, e i partiti svolgono un ruolo tuttora rilevante, ma come mero anello funzionale all’interno di un sistema di governo, abbandonando la loro originaria natura bifronte, che li vedeva agire dentro le istituzioni ma con i piedi ben saldi nella società. Tra l’uno e l’altro versante, i sentieri di comunicazione sono quasi interrotti: bisogni e domande sociali trovano i propri modi di esprimersi, ma sempre più spesso attraverso due canali: o la contrattazione micro-corporativa con pezzi delle istituzioni; o, all’opposto, manifestandosi all’interno di cerchie di socialità e di impegno civico che non solo non hanno rapporti con la politica, ma spesso ne diffidano apertamente. E la politica, a sua volta, non sa alimentarsi delle pratiche associative che pure continuano a essere diffuse, in modo frammentario, nel tessuto sociale.
Sulle cause alle origini di tutto ciò, naturalmente, le interpretazioni possono essere varie: il libro di Filippo Barbera (Le piazze vuote. Ritrovare gli spazi della politica, Laterza, 2023), da poco uscito, propone un’ottica originale, per guardare all’insieme di questi fenomeni.
Il tema degli spazi, dei luoghi fisici della politica, viene in genere oggi sottovalutato: la politica (una politica che si proponga obiettivi di trasformazione e di giustizia sociale), non può che essere azione collettiva e, come tale, ha bisogno di luoghi in cui possa esprimersi. I bisogni individuali non possono tradursi in soluzioni “generali” se non trovano modo di manifestarsi come bisogni che accomunano ad altri, che creano condivisione e costruiscono legami sociali. La dimensione della prossimità rimane un terreno cruciale su cui possano formarsi orientamenti comuni. Viviamo nell’epoca in cui tutto, anche la politica, sembra oramai poter vivere nella dimensione immateriale delle piattaforme digitali: ma è proprio vero che anche una politica democratica possa fare a meno di una dimensione pubblica, e spazialmente situata, in cui individuo e collettività si possano incontrare? E il “senso comune”, che si traduce in orientamenti politici, davvero nasce solo dai canali mediatici, vecchi e nuovi, utilizzati in modo atomizzato?
Il libro di Barbera intreccia una chiave analitica-interpretativa sul presente (la contrazione degli “spazi della politica”) e una chiave “prescrittiva”: non per dettare ciò che bisogna fare, ma per indicare alcune pre-condizioni di una politica che torni a organizzare “il bisogno di futuro”, per tutte quelle parti della società che oggi vivono in uno stato di deprivazione e subalternità. Il lavoro si articola in tre parti: nella prima, si affronta “la dimensione spaziale della sfera pubblica quotidiana”, e qui l’autore esplicita le premesse teoriche del suo approccio, attingendo ad alcuni classici della sociologia, come Durkheim e Mead, e ad altri autori contemporanei; nella seconda, si guarda agli “spazi intermedi dell’elaborazione politica”; nella terza, agli “spazi dei luoghi di vita o alle persone-nei-luoghi”. “Domanda di futuro”, “offerta di futuro” e costruzione dell’egemonia si legano attraverso questi tre livelli.
È proprio vero che anche una politica democratica possa fare a meno di una dimensione pubblica, e spazialmente situata, in cui individuo e collettività si possano incontrare?
Non si possono costruire strategie di riattivazione di quegli spazi collettivi della politica (che l’ideologia neoliberista dell’homo oeconomicus ha rarefatto), se non si considera la costitutiva dimensione antropologica sottesa a tutto ciò: “siamo corpi in azione nello spazio: corpi che scambiano, promettono, mentono, agiscono, negoziano, discutono, confliggono e cooperano attraverso l’organizzazione fisico-spaziale dell’interazione sociale” (p. 4). E qui possiamo cogliere, per parte nostra, una consonanza con la teoria habermasiana dell’agire comunicativo, e della sua concezione del discorso performativo, così come con la sua idea che i presupposti etici e pragmatici della comunicazione contengano sempre un potenziale emancipativo e una proiezione universalista (non a caso, anche Habermas si confrontò lungamente con l’opera di G.H. Mead e la sua nozione di “Altro generalizzato”). I rituali dell’interazione sociale sono dunque decisivi: ma essi, evidentemente, possono assumere contenuti molto diversi, da quelli più chiusi e regressivi a quelli più aperti e inclusivi. Il punto è che, laddove si forma negli individui e in alcuni gruppi sociali “senza voce” una qualche domanda di giustizia, essa può esprimere un “bisogno di futuro” e alimentare una ricerca di soluzioni comuni solo se assume le forme di un’azione collettiva e comincia a farsi propriamente “politica”: dalle forme più classiche delle manifestazioni di massa a quelle più innovative e sperimentali (ad esempio, la co-progettazione territoriale o la gestione condivisa di beni comuni: e su molte di queste esperienze Barbera si sofferma, a più riprese, specie nella terza parte del suo libro).
Di particolare rilievo appare il secondo livello sopra indicato: gli “spazi dell’elaborazione politica e intellettuale”: partiti, associazioni, gruppi e centri di ricerca, rappresentanze di interessi ecc., costituiscono “spazi fisici e organizzativi intermedi” delle classi dirigenti. E sono spazi (luoghi, strumenti) che si sono drammaticamente contratti: ne è derivato un generale impoverimento e abbassamento della qualità dei discorsi politici correnti. Il confronto tra il presente e quanto accadeva al tempo della cosiddetta “Prima Repubblica” è impietoso: allora, “il discorso politico era il terminale ultimo di un lungo percorso preparatorio di elaborazione dove politici, intellettuali e pezzi della classe dirigente lavoravano alla messa a punto di temi e argomenti in tempi e spazi dedicati” (pp. 44 s.). Oggi, all’esaurirsi degli spazi fa da contraltare anche la tirannia dei tempi: una immediatezza, un’apoteosi dell’accelerazione, dettata da una politica mediatizzata, che fa svanire un solido retroterra di analisi e di valutazioni. Conta solo il capitale mediatico che si è in grado di accumulare. E si annulla ogni vera dimensione dialogica e argomentativa nel discorso pubblico: la logica pervasiva delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione vanifica ogni pretesa di preservare spazi fisici e sociali in cui si possano produrre forme di mediazione, relazioni tra individui, legami sociali di solidarietà e di condivisione.
Ora, non c’è dubbio che sia stata soprattutto la sinistra ad aver pagato il prezzo più alto di questa involuzione, sia per la forza dei processi “oggettivi” sia, non in misura minore, per la debolezza delle sue risposte politiche e strategiche (e della cultura politica che ne era un presupposto). A cominciare dalla smobilitazione, subìta ma anche teorizzata e consapevolmente praticata, del luogo principe della funzione intermedia della politica: il partito. Quella funzione intermedia che ha permesso ai partiti, nei loro momenti migliori, di agire come anello di congiunzione tra i livelli “alti” dell’elaborazione intellettuale, la cultura politica di dirigenti e militanti, e il più largo “senso comune” che si costruisce nei luoghi sociali. Era inevitabile che questo accadesse e, soprattutto, è davvero impossibile oggi ripensare e ricostruire questo ruolo?
Se bisogna sollecitare un mutamento all’interno delle forme e delle strutture politiche che la storia ci ha consegnato, un compito non meno impegnativo spetta al variegato mondo della cittadinanza attiva
Solo se si rovesciano queste tendenze, ricercando e sperimentando nuovi strumenti e spazi, la politica (quella democratica e di sinistra) potrà trovare le ragioni e le forme del suo futuro. Non è facile, come dimostra il fatto stesso che Barbera non ha fatto in tempo a dare alle stampe il suo libro che già alcune esperienze europee di “nuova politica”, che egli cita ancora come esempi positivi o promettenti (da Syriza a Podemos, fino alla Nupes francese) sono entrate in crisi. L’impressione è che gli spazi e gli strumenti della politica hanno anche una loro forza inerziale, che sia molto difficile inventarle ex novo, e che la memoria storica abbia il suo peso: non a caso, forse, una delle migliori realtà europee è quella spagnola di un partito socialista che continua, senza problemi, a definirsi obrero. Ma se bisogna sollecitare un mutamento all’interno delle forme e delle strutture politiche che la storia ci ha consegnato, un compito non meno impegnativo spetta al variegato mondo della cittadinanza attiva.
Barbera dedica alcune pagine importanti (72-73) a quella che potremmo definire la “trappola” di un’“antipolitica” che si annida anche dove meno te lo aspetti. La responsabilità del “baratro” che divide i partiti dalle pratiche associative di quel mondo è senza dubbio dei partiti; ma questa, scrive Barbera, “è anche una tesi parziale”:
“il distacco tra partiti e fermento sociale è anche dovuto a un meccanismo di auto-esclusione dovuto all’intrinseca gratificazione che queste esperienze trasmettono a chi le anima… È, in altri termini, il buon funzionamento della micro-politica che può contribuire a disincentivare la presa in carico in prima persona dell’azione nella politica istituzionale”.
Si potrebbe aggiungere anche un fattore di ordine culturale alla base di questo fenomeno: si è fatta strada l’idea che disuguaglianze e ingiustizie sociali si manifestino oramai solo in forme plurali e non ricomponibili, e questa idea è passata anche tra coloro che non accettano lo stato delle cose presenti, portando a ritenere che reazioni e opposizioni si possano esprimere solo in forme micro-conflittuali, o costituendosi come micro-poteri che al massimo possano inceppare il Potere, o ritagliando una nicchia di autonomia dalle logiche sistemiche, in una sorta di “zona franca”, come uno spazio di auto-organizzazione sociale libera dal dominio. Ed è da questa doppia “trappola” che bisogna provare a uscire.

Riproduzione riservata