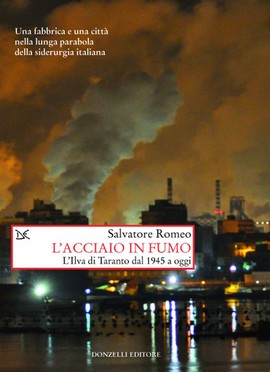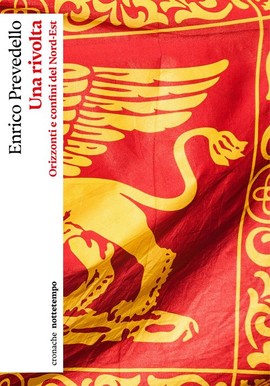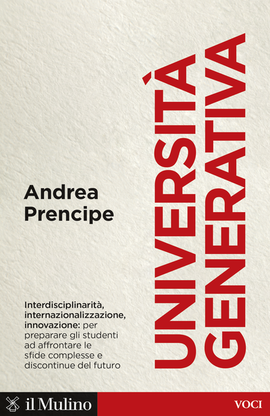La “questione Taranto” è diventata centrale nel dibattito pubblico e argomento di cronaca pressoché quotidiana dopo il sequestro nel 2012 da parte della magistratura dell’area a caldo del polo siderurgico, quando iniziavano a emergere fratture profonde nel tessuto civile e sociale della città. La salute e il lavoro, la difesa dell’ambiente e la tutela dell’occupazione cominciarono a essere percepiti sempre più come aspetti irriducibili e inconciliabili. Ma la “questione Taranto” come la viviamo oggi è l’esito drammatico di un percorso storico lungo e complesso, che Salvatore Romeo ricostruisce in L'acciaio in fumo, libro denso e appassionato, colto e profondamente sentito, in cui si dà conto in sette capitoli delle vicende che hanno caratterizzato lo stretto rapporto tra città e industria così come si è configurato nel lungo periodo.
Fin dalla fine del XIX secolo, con l’insediamento dell’Arsenale lungo le sponde del Mar Piccolo e successivamente della cantieristica navale Tosi, Taranto si andava definendo come una delle principali città industriali del Mezzogiorno d’Italia. Il legame tra realtà urbana e attività produttive che si era costituito fin dalla fine dell’Ottocento si sarebbe accentuato agli inizi degli anni Sessanta del Novecento, grazie all’insediamento dell’industria siderurgica in un’area agricolo-costiera estesa più di cinquecento ettari (per la sua realizzazione furono estirpati 20.000 ulivi), vicina alla città e a ridosso del quartiere Tamburi. Si trattava di cogliere le opportunità offerte al sistema produttivo italiano nell’ambito del nuovo panorama europeo, caratterizzato dalla costituzione della Ceca (Comunità economica del carbone e dell’acciaio), dall’espansione della domanda mondiale di beni siderurgici e, al contempo, di orientare le scelte dell’industria pubblica e delle partecipazioni statali verso il riequilibrio del gap tra il Nord e il Sud del Paese.
Negli anni Sessanta, la comunità locale e i ceti dirigenti guardarono positivamente alla decisione delle istituzioni nazionali di insediare a Taranto il quarto polo siderurgico italiano, accanto a quelli di Cornigliano, Piombino e Bagnoli, e potenziare così il sistema produttivo locale. La fabbrica avrebbe garantito un miglioramento del reddito e dell’occupazione, e influenzato positivamente l’economia e il benessere dell’intera provincia ionica. Basti pensare che gli addetti allo stabilimento siderurgico passarono da 4.500 nel 1965 a 22.000 all’inizio degli anni Ottanta, a cui si aggiungevano i dipendenti dell’indotto. Un numero destinato a dimezzarsi nel secondo decennio degli anni Duemila.
All’inizio degli anni Settanta, la decisione del “raddoppio”, che prevedeva un’estensione dell’industria fino a ridosso della città e del porto per consentire a Taranto di soddisfare la domanda crescente di beni siderurgici, introdusse nuovi elementi dialettici nel rapporto tra città e industria. Oltre al conflitto tra l’amministrazione comunale e l’industria relativo al progetto di ampliamento dello stabilimento e all’insorgere della “questione ambientale”, questa fase segnò l’avvio di grandi mobilitazioni. Anche grazie al buon andamento della “vertenza Taranto”, promossa dai sindacati per il ricollocamento dei lavoratori dell’appalto, in quegli anni si costituirono nuovi gruppi dirigenti all’interno del movimento operaio e sindacale, e venne profondamente compromesso il potere democristiano, tanto che sia le amministrative del 1975 sia, soprattutto, le politiche dell’anno dopo furono segnate dall’avanzata netta della sinistra.
Nel decennio successivo, le vicende di Taranto e il rapporto tra città e industria sono inserite dall’autore in uno scenario più ampio. Per rispondere agli effetti prodotti sul lungo periodo dalla deindustrializzazione e dalla deregolazione dei mercati, Finsider decise di avviare un processo di ristrutturazione del comparto siderurgico italiano, che avrebbe spostato su Taranto la funzione di soddisfare quasi interamente la domanda nazionale di beni. Per la debolezza finanziaria e la limitata innovazione tecnologica l’impresa non riuscì a frenare il processo di crisi, che comportò la riduzione della manodopera con il 20% di prepensionamenti. Il passaggio al gruppo Ilva fu inevitabile.
La crisi non ebbe solo effetti di tipo economico. Romeo evidenzia che produsse ricadute ben più profonde, che riguardarono anche fattori di tipo culturale e politico. Iniziò a cambiare il modo in cui la città guardava alla fabbrica: l’industrializzazione di Taranto non fu più percepita con orgoglio, non fu più vista come il contributo allo sviluppo e al benessere del Mezzogiorno e del Paese, ma come un atto di sottomissione e di subalternità, che la città aveva dovuto subire ed alla quale erano stati richiesti immensi sacrifici. Si iniziava a leggere e valutare la scelta industrialista come un’imposizione. In questa nuova dimensione, caratterizzata da un crescente malessere e senso di frustrazione, si deve collocare il profondo cambiamento politico che interessò Taranto nel corso degli anni Novanta: l’elezione a sindaco nel 1993 di Giancarlo Cito, ex militante del Msi ed ex picchiatore fascista, che di questi nuovi sentimenti si era fatto portavoce.
La parabola, iniziata con la crisi degli anni Ottanta, condusse nel 1994 alla privatizzazione con la vendita dell’Ilva al gruppo Riva. Si trattò della fine della siderurgia pubblica, che l’autore vede come la conclusione anche di un rapporto più profondo e, nonostante gli aspetti controversi rappresentati in primo luogo dalla questione ambientale, sostanzialmente positivo tra l’economia e la politica, tra le finalità dell’impresa e lo sviluppo del Paese, tra gli obiettivi di profitto dell’azienda e il superamento dei divari regionali.
Questa svolta aprì un capitolo davvero oscuro e doloroso per Taranto, raccontato con grande efficacia da Romeo nell’ultima parte del volume. Si attuò una sorta di “restaurazione padronale”, per la più accentuata precarizzazione e intensificazione dei ritmi di lavoro, l’allontanamento della manodopera più sindacalizzata e la contrazione del numero dei dirigenti, lo spostamento degli impiegati a mansioni differenti e l’incapacità di poter adottare tecnologie per contenere le emissioni di diossine. L’era dei Riva si concluse di fatto con il sequestro dell’area a caldo e nel 2018 Ilva passò al gruppo Arcelor-Mittal. La siderurgia italiana diventava, per dirla con l’autore, “la propaggine locale di un grande gruppo multinazionale”.
Il libro di Salvatore Romeo è innanzitutto un libro originale, che tratta di un periodo poco affrontato dagli storici dell’età contemporanea, ed è sicuramente uno dei migliori che sia stato scritto negli ultimi anni su argomenti legati al Mezzogiorno d’Italia. I processi di trasformazione e i loro passaggi cruciali sono rappresentati in tutta la loro problematicità e complessità, senza cadere mai in facili semplificazioni. Il testo si fonda su un solido e ricco apparato di documenti e fonti di varia natura e tratta una grande varietà di temi, come il rapporto tra città e industria e la storia della siderurgia pubblica, le politiche per il Mezzogiorno e la storia del movimento sindacale e operaio, le ricadute della deindustrializzazione e l’insorgere della questione ambientale, gli effetti della deregulation dei mercati e il dissolversi del sistema di valori che avevano caratterizzato il lavoro operaio. L’acciaio in fumo è un libro “paradigma”, modello di come si può fare storia incrociando scale diverse e differenti prospettive di analisi storica (sociale e politica, economica ed ambientale). Ma è soprattutto un libro che invita a riflettere sul rapporto tra la storia del sistema produttivo e la storia d’Italia nel suo complesso, sul ruolo dell’industria pubblica al di là delle troppo facili e sommarie valutazioni negative, sulle drammatiche ricadute culturali e sociali della fase liberista e su come il nostro Paese abbia costruito la sua casuale e sciagurata risposta alla globalizzazione.

Riproduzione riservata