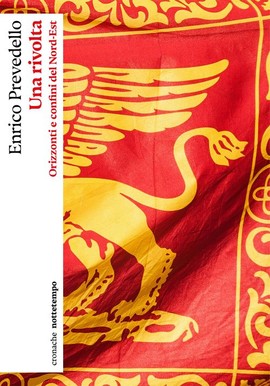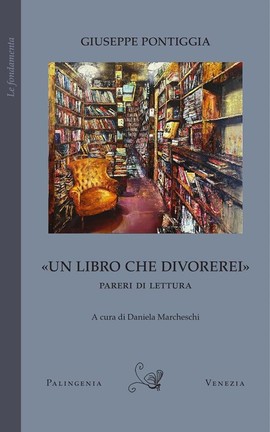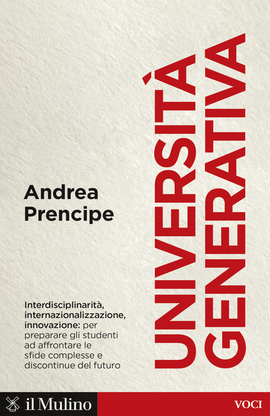«Si potrebbe scrivere un libro sugli usi e abusi fatti del termine zona grigia; probabilmente si scoprirebbe che nessuna espressione ha avuto tanta fortuna ed è stata tanto travisata», ha scritto nel 2011 la storica torinese Anna Bravo, amica e studiosa di Primo Levi, scomparsa nel 2019. Questo libro forse non è stato ancora scritto, ma un capitolo significativo lo si deve a Maurizio Catino, professore di Sociologia delle organizzazioni all’Università di Milano-Bicocca. In un importante e originale volume, Le organizzazioni mafiose. La mano visibile dell’impresa criminale (Il Mulino, in inglese presso Cambridge University Press), Catino ricorda al lettore come l’espressione «la zona grigia» serva solo a confondere, piuttosto che a capire, il rapporto tra le organizzazioni mafiose e coloro che operano all’esterno, come professionisti, imprenditori, politici e funzionari pubblici.
Che cosa intendeva Primo Levi con l’espressione «la zona grigia»? Ne I sommersi e salvati (1986), lo scrittore torinese la descrive come una realtà «dai contorni mal definiti, che insieme separa e congiunge i due campi dei padroni e dei servi». In questa area liminale operano i prigionieri-funzionari. L’universo concentrazionario nazista non potrebbe operare senza di loro. Per sopravvivere nel lager alcuni accettano la protekcja (un termine yiddish e polacco) del sistema. Levi distingue i funzionari di basso rango – gli scopini, i lava-marmitte, i controllori di pidocchi – insomma «i poveri diavoli» che non causano danno ad altri prigionieri, da coloro che detengono posizioni di potere, i cosiddetti Kapos, i quali possono «commettere… le peggiori atrocità». Spinti dalla fame, dal terrore oppure da motivazioni egoistiche, alcuni oppressi – scrive Levi – subiscono il contagio degli oppressori. Una delle descrizioni più toccanti del libro riguarda la partita di calcio tra gli addetti alle camere a gas e le SS. Per un attimo gli aguzzini fanno credere alle loro vittime di essere eguali, ma allo stesso tempo vogliono dimostrare loro che essi hanno tradito il proprio popolo, e l’umanità, per aver accettato quel tragico compito e quindi, in fondo, non sono migliori. Come è noto, i membri di queste squadre non avevano alcuna possibilità di scelta e venivano a loro volte condotti nelle camere a gas dopo tre mesi di «servizio». Vittime e carnefici non erano affatto uguali.
Catino ricorda al lettore come l’espressione "la zona grigia" serva solo a confondere, piuttosto che a capire, il rapporto tra le organizzazioni mafiose e coloro che operano all’esterno
Primo Levi fa una riflessione ancorata strettamente al lager, dove viene esercitata una forma di coercizione assoluta fondata sul terrore omicida, e su come essa possa corrompere e disumanizzare le vittime. Diversi interpreti hanno poi stravolto questa interpretazione introducendo l’idea che la zona grigia sia un’area di irresponsabilità generalizzata, di impotentia judicandi. «L’oppresso diventa oppressore e il carnefice appare a sua volta come vittima», commenta Agamben in Quel che resta di Auschwitz (1998). Agamben estende il paradigma del lager fino a «scoprire che ciò che il male sa di sé lo troviamo facilmente anche in noi». Non stupiscono quindi le recenti esternazioni di questo autore, che paragona il destino degli ebrei a quello dei novax (contro questa banalizzazione, vedi, ad esempio, Sofia Ventura). Levi, al contrario, non nega la possibilità di giudicare, anche all’interno del lager, ma tale giudizio non deve mai confondere le vittime e i carnefici. E, per quanto non sappia dire se nel suo profondo si annidi un assassino, Levi sa «che vittima incolpevole sono stato ed assassino no». Continua Levi: «So che gli assassini sono esistiti, non solo in Germania, e ancora esistono, […] e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale o un vezzo estetistico o un sinistro segnale di complicità; soprattutto, è un prezioso servigio reso (volutamente o no) ai negatori della verità».
Una confusione quasi altrettanto dannosa e diametralmente opposta emerge in chi usa l’espressione «zona grigia» in riferimento ad una generica collusione tra professionisti e criminalità organizzata. Qui la vittima (presunta) ha un margine di scelta che non fu mai concesso a chi venne rinchiuso nei lager. Ad esempio, la consulente finanziaria bolognese Roberta Tattini, condannata in via definitiva nel 2018 a otto anni e otto mesi per concorso esterno in associazione mafiosa, si mise «a completa disposizione» della cosca calabro-emiliana di Grande Aracri per aumentare il fatturato del suo studio, come scrivono i giudici del processo Aemilia. In una telefonata al padre, che le raccomanda di fare attenzione, la professionista risponde: «Oh ragazzuoli, funziona così eh!». Tattini e altre figure simili ricercano il contatto con le cosche, offrendo un contributo «consapevole e volontario» all’organizzazione, senza subire alcuna minaccia. E che dire di quell’ex sindacalista impiegato presso la provincia di Milano, che addirittura accetta di essere sottoposto ad un periodo di prova pur di collaborare con il clan catanese dei Laudani? In questi e moltissimi altri esempi vi è una scelta consapevole, uno scambio di favori e servizi, in un contesto dove si può benissimo agire in maniera diversa. Il concetto di «zona grigia» non serve a cogliere i diversi ruoli ricoperti da coloro che operano all’esterno delle organizzazioni mafiose, come gli intermediari che intenzionalmente facilitano operazioni complesse, gli agenti di pubbliche relazioni, o i funzionari che vendono atti pubblici invece di denunciare.
Oltre alla riflessione sugli abusi di questo concetto, il libro di Catino ha almeno altri tre meriti. Innanzi tutto, applica la teoria organizzativa a questa materia. A suo tempo Angelo Panebianco (Modelli di partito, Il Mulino, 1982) ci insegnò che i partiti politici, al dì là delle affermazioni di principio e di quanto scritto negli statuti e pronunciato nei comizi, sono anche delle organizzazioni: ad esempio, socialisti e democristiani, ideologicamente diversi tra loro, possono avere una struttura organizzativa identica. Oggi Catino ci ricorda che le mafie sono anche delle organizzazioni, e raccoglie e sistematizza i principali risultati raggiunti dalla letteratura scientifica. Il secondo grande merito del volume è quello di essere un’analisi comparativa. Esistono moltissimi studi di caso, ma molto pochi sono comparativi. Lo sforzo di comparare tra loro la mafia russa, la mafia italo-americana, le triadi di Hong Kong, la yakuza giapponese e le tre principali mafie italiane ('ndrangheta, Cosa nostra e Camorra) permette a Catino di giungere ad una conclusione molto importante: la struttura di questi gruppi, nati in tempi diversi e in luoghi lontanissimi tra loro, è molto simile. Tutte le organizzazioni mafiose sono caratterizzate da una struttura gerarchica a livello della Famiglia (per usare l’espressione mutuata da Cosa nostra) e da un sistema di coordinamento tra Famiglie noto col nome di Commissione nel contesto italiano e italo-americano. Fuori d’Italia, la Commissione è detta skhodka (Russia), kanto (Giappone) oppure il Sistema del quartiere generale (Hong Kong). Cambia l’etichetta ma non la sostanza. Nel mio libro Vita di mafia (Einaudi, 2017) sostengo una tesi simile e mi spingo oltre, fino a mostrare che le stesse regole recitate al momento del rito di iniziazione dalla recluta sono in grandissima parte identiche. Tale somiglianza non dipende certo da un processo di emulazione (il famoso problema di Galton). Tutte le mafie sono organizzazioni che aspirano a governare un territorio e, per portare a termine questo compito, hanno bisogno di una struttura di comando e di certe regole operative minime, come quella di obbedire agli ordini, di non fraternizzare con la polizia e di non generare tensioni interne andando a letto con la moglie di un altro affiliato. Ma queste sono anche organizzazioni speciali: le Famiglie riconoscono la legittimità reciproca, hanno regole condivise e, entro certi limiti, coordinano le loro attività attraverso strutture di raccordo sovraordinate alle Famiglie stesse. Questo aspetto rende le mafie sui generis rispetto alla gran maggioranza delle gang urbane.
Un merito del volume è lo sforzo, serio e sistematico, di quantificare ove possibile. È luogo comune dire che quantificare in questo campo di studi è difficile. In realtà sappiamo molto di queste organizzazioni
Un terzo merito del volume di Catino è lo sforzo, serio e sistematico, di quantificare ove possibile. È luogo comune dire che quantificare in questo campo di studi è difficile. In realtà, grazie alle tante inchieste e alle dichiarazioni dei pentiti, sappiamo molto di queste organizzazioni (Catino suggerisce che abbiamo meno dati su certe multinazionali legali, come Apple e Facebook). In particolare, l’autore presenta delle serie storiche degli omicidi per le tre organizzazioni italiane, e così facendo scopre che le mafie che hanno organi sovraordinati di coordinamento, al di sopra della Famiglia, commettono più omicidi eccellenti (di magistrati, giornalisti e politici) e meno omicidi di altri mafiosi. La Camorra – con l’eccezione del clan dei Casalesi – è un esempio dove non esistono tali organi di coordinamento: ne segue che gli omicidi tra camorristi sono numerosi e quelli eccellenti rari. Si potrebbe però obiettare che la mancanza di organi sovraordinati di coordinamento fa dei clan di camorra non delle mafie ma piuttosto dei fenomeni di gangsterismo urbano e quindi, a rigore, non equiparabili, ad esempio, a Cosa nostra. In ogni caso, l’autore ha il grande merito di generare una tesi testabile e quindi confutabile. Le scienze sociali progrediscono in questo modo, piuttosto che attraverso infinite disquisizioni infarcite di filosofia mal digerita, dove la lunghezza della bibliografia è inversamente proporzionale alle conoscenze empiriche prodotte.
La chiarezza dei concetti, l’attenzione a teorie analitiche, lo sforzo di generare ipotesi testabili, l’impianto comparativo e la quantificazione fanno di Le organizzazioni mafiose un testo che dovrebbe essere letto non solo dagli studiosi della criminalità organizzata, ma anche da chi sia interessato alla metodologia delle scienze sociali. La limpida e per certi versi coraggiosa polemica contro la deriva banalizzante del concetto di «zona grigia» ne fanno anche un contributo al dibattito civile di questo paese, un contributo che sarebbe piaciuto – credo – a Primo Levi e ad Anna Bravo.

Riproduzione riservata