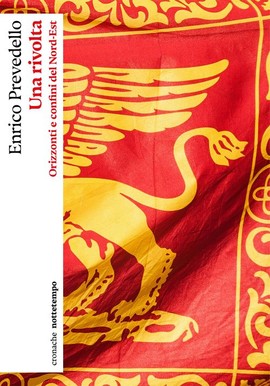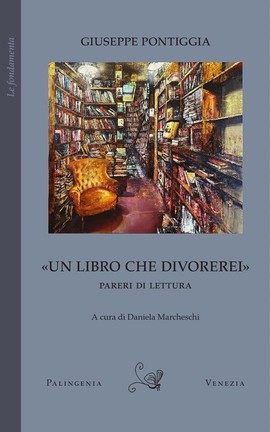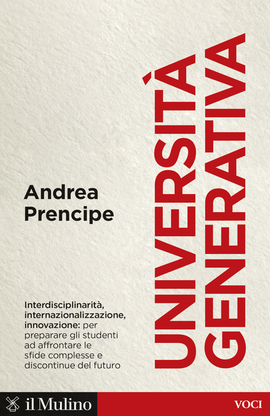L’ultimo libro di Ernesto Galli della Loggia, Credere, tradire, vivere. Un viaggio negli anni della Repubblica (Il Mulino, 2016), è un saggio di storia politica degli intellettuali italiani nell’ultimo trentennio del Novecento, ma è anche un volume autobiografico, partigiano e pungente come sono di solito i suoi scritti. Condivido la scelta fatta dall’autore di dedicare una grande attenzione alle élite intellettuali in quel periodo; meno convincente è invece il fatto che ne restringa il focus alla cultura di stampo azionista, anche se i suoi stereotipi divennero prevalenti nella sinistra dagli anni Ottanta in poi.
Galli della Loggia fa risalire alla metà di quel decennio il coagularsi della critica delle narrazioni che avevano sostenuto a lungo l’impianto della «Repubblica dei partiti» e ripercorre i principali capitoli della «guerra della memoria» di cui è stato egli stesso protagonista. In verità, già in un saggio premonitore del 1976 (Ideologie, classi e costume, in L’Italia contemporanea 1945-1975, a cura di V. Castronovo, Einaudi, 1976, pp. 379-434) aveva individuato le debolezze della cultura di governo della sinistra in un’Italia che sembrava aver compiuto il ciclo della modernità e invocava un ricambio delle classi dirigenti. Dalla riflessione sul fallimento di quelle aspettative nacque il «revisionismo storiografico» del decennio successivo, di cui Galli della Loggia riprende i temi che hanno contraddistinto il suo impegno: le ambiguità dell’antifascismo e la fragilità della nazione repubblicana a cui esso aveva impresso il proprio sigillo. Attratto dal tema dell’identità italiana, egli sembra ignorare le condizionalità internazionali in cui si è sviluppata la storia d’Italia dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi. La Guerra fredda non era solo un «vincolo esterno», ma anche il paradigma del sistema politico, segnato da una tensione fra anticomunismo e antifascismo che fino alla metà degli anni Settanta fu particolarmente propizia all’Italia. Galli invece assume nei confronti del comunismo italiano un atteggiamento che ricorda quello storiografico di Croce nei confronti del fascismo, mentre sul cattolicesimo democratico, che è stato la cultura politica egemone nell’Italia repubblicana, il suo giudizio appare elusivo.
Ma il punto saliente del suo libro è nella conclusione. «La guerra della memoria italiana – scrive – può essere considerata conclusa», ma «nel frattempo, quasi senza che ce ne accorgessimo, è sopraggiunto un altro presente. Quello di oggi, che sembra volere, e potere, fare a meno di qualunque passato, addirittura sul punto di troncare ogni rapporto con esso. Assai più che custodirne o accreditarne qualche versione, il compito attuale perciò appare quello puro e semplice di difendere la dimensione stessa del passato, il suo significato perché possa esserci un futuro. Questo dopo tanto combattere è il dovere che oggi ci resta, il solo vero lascito per chi verrà dopo» (pp. 344-345).
Condivido queste considerazioni. «La guerra della memoria» è davvero finita. Negli ultimi decenni il fascismo è stato ricollocato nella storia d’Italia e questa nella storia mondiale del Novecento. A chi potrebbe tornare in mente che per scrivere la storia del fascismo sarebbe necessaria una professione di fede antifascista? La democrazia repubblicana ha superato sfide tremende nel secondo Novecento e oggi accomuna gli italiani al di là delle vecchie divisioni fra chi aveva combattuto per instaurarla e chi non voleva riconoscerne i meriti. Non sono riproducibili figure di «venerati maestri» che si provino a dissociare la sconfitta del fascismo dalla catastrofe della nazione italiana nella Seconda guerra mondiale e le perentorie negazioni della cultura fascista, che ancora accendevano gli animi negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, appaiono surreali. Chi se la sentirebbe di ripetere che il fascismo, in quanto totalitario, non poteva avere per principio una grande cultura? Ma intanto, ammonisce Galli, «è sopraggiunto un altro presente che sembra volere, e potere, fare a meno di qualunque passato». Egli pone così quello che a molti pare il tema nodale della catena del tempo che il «mondo globale» sembra avere irrimediabilmente spezzato. Tuttavia l’immaginario globale in cui sono immerse vecchie e nuove generazioni non è una incommensurabile bolla in cui tutto sia sospeso, ma un intreccio di grandi narrazioni in cui quelle egemoniche annebbiano qualunque percezione spazio-temporale che oltrepassi la dimensione dell’esperienza vitale immediata più o meno consapevolmente vissuta e occasionalmente condivisa. L’esortazione alle historiae con cui Galli della Loggia conclude il suo libro non mi pare quindi né riduttiva, né velleitaria.
Da dove cominciare? A più di cent’anni da quando furono scritte, le parole di Antonio Labriola appaiono un punto di partenza illuminante per mettere a fuoco il problema storico della nazione italiana anche nel mondo multipolare e interdipendente del XXI secolo: «Quante garanzie di Stato moderno offre ora l’Italia in quanto a mantenere un posto di utile ed efficace concorrente nella gara internazionale?». Le condizioni odierne della competizione internazionale non sono comparabili a quelle del primo Novecento, ma ora come allora determinano i parametri con cui affrontare le ragioni della nostra fragile unità e decadenza interna. Oggi più di ieri la domanda fondamentale è: «La vecchia nazione italiana, componendosi a Stato moderno, di quanto si è trovata adattabile e di quanto s’è trovata difettiva di fronte alle condizioni della politica mondiale?» (A. Labriola, Da un secolo all’altro, in Id., Scritti filosofici e politici, a cura di F. Sbarberi, vol. II, Einaudi, 1973, p. 855).
La pertinenza e utilità delle domande sono ben presenti a Galli, che già le aveva riprese da Franco De Felice nel 1998 concludendo il suo saggio su L’identità italiana (Il Mulino, 1998, pp. 140-141). In Credere, tradire, vivere egli indica negli anni Settanta il periodo in cui il nesso fra la vita italiana e la politica mondiale subì uno scarto da cui il Paese non si è più ripreso. È una diagnosi che condivido, del resto largamente confermata dalla storiografia più recente. Conviene dunque soffermarsi sulle sue parole che giovano anche a determinare il programma di ricerca invocato nella pagina conclusiva del suo saggio che prima ho citato. «Ormai da molto tempo, scrive nel prologo (p. 8), l’Italia è un Paese paralizzato» per «non aver voluto o saputo cambiare quando era necessario farlo. Cioè quando negli anni Ottanta-Novanta divenne evidente che alcune importanti misure prese in tutta fretta nel decennio precedente stavano creando una voragine nei conti pubblici e al tempo stesso mandando in rovina due ambiti fondamentali della vita italiana: l’ossatura amministrativa dello stato unitario e il sistema d’istruzione dei suoi cittadini».
Se, lasciataci alle spalle la «guerra della memoria», «il compito attuale» è di impedire che venga cancellata l’esigenza stessa del nesso fra passato, presente e futuro, il problema non è quello di giungere a una chimerica narrazione condivisa della storia nazionale, bensì di individuare i punti nodali della crisi della nazione italiana che l’indagine storiografica potrebbe aiutare a risolvere. I punti sono quelli indicati da Galli e riguardano l’impalcatura dello Stato unitario, lesa soprattutto dalla deriva del regionalismo, e «il sistema d’istruzione» dei cittadini. In altre parole, le filiere istituzionali da cui dipende non solo l’unità della nazione, ma anche la consapevolezza della sua necessità e dei suoi significati. Sono temi sui quali Galli della Loggia conduce operosamente la sua battaglia pubblicistica, ma sono anche capitoli mancanti o disordinatamente affastellati nell’agenda politica del Paese. Organizzare le forze culturali necessarie a promuovere la consapevolezza storica delle ragioni del nostro «declino» forse gioverebbe a conferire vigore ricostruttivo alla vita politica, mutandone il passo, che sembra inseguire la cronaca delle patologie piuttosto che diagnosticarne l’origine e apprestarne la cura.

Riproduzione riservata