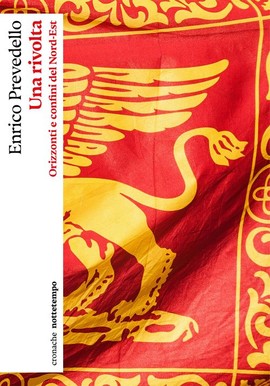Mi immagino il Reparto 77 come un giardino segreto, con una porta a dividere quello che succede dentro e il mondo fuori. Per accedervi, serve avere la chiave giusta.
Paolo Milone, autore de L’arte di legare le persone (edito da Einaudi lo scorso gennaio), possiede quella chiave, la tiene in tasca e – come scrive – ogni tanto la tocca per assicurarsi che sia ancora lì. Questo gli permette di avere accesso al reparto di Psichiatria e di accompagnare i lettori all’interno di un metaforico giardino, abitato da piante robuste e fiori fragili.
Sono i pazienti che ha incontrato nel corso della sua professione («sono quasi quarant’anni di vita e di psichiatria», racconta lui stesso in una nota conclusiva) e che ora chiama per nome
Si rivolge a loro direttamente, risvegliando ricordi, sottolineando stranezze e ribadendo legami profondi. C’è Filippo, che non riesce a trovare le parole per spiegare quello che ha dentro e che sembra ricordare quel matto cantato da De André e prima ancora messo in versi da Edgar Lee Master. C’è Lucrezia, che ha vent’anni, il sorriso beffardo e gli occhi «più saggi di tutti»: la incontreremo spesso nelle pagine, fino al momento in cui si farà vento. E ancora: Danilo con i suoi abbracci potenti, Enrica che non smette di chiedere scusa e Chiara, capace di far innamorare. Non importa chi ci sia dietro a questi personaggi e se corrispondano a pazienti realmente incontrati. Sono scorci di quel mondo, capaci di interrogare e attrarci a sé, di suscitarci un sorriso a metà tra la simpatia e la complicità, così come di avvicinarci al loro dramma esistenziale.
La sapienza che lo scrittore ha imparato sul campo, grazie al tempo trascorso in reparto, non emerge solo dai volti e dalle storie che si avvicendano nel libro: la si coglie in quegli elenchi che Milone stila dando prova di riconoscere le patologie dei pazienti dai loro odori («tu saresti capace di fare una diagnosi usando solo l’olfatto?») o dal modo di calzare le scarpe oppure attraverso la distanza.
Il libro segna l’esordio di Milone come scrittore: il suo è uno stile semplice, schietto e profondo. E un aspetto dell’originalità dell’opera è proprio la sua forma. Ogni capitolo è suddiviso in paragrafi, più o meno lunghi, più o meno intrecciati tra di loro. Frammenti di una vita, flashback separati da una dissolvenza in nero. Una scrittura non giustificata, quasi a ricordare che non si tratta di uniformare i pensieri ma di lasciarli liberi, imperfetti e scomposti. Potrebbe essere un tentativo di omaggiare la diversità anche nella forma e non solo nel contenuto.
Di fatto Milone vuole ribadire l’importanza dell’accettazione dell’altro e della malattia, ma la riflessione che ne nasce è più ampia: se a livello spaziale è un muro a dividere i sani dai malati, da un punto di vista ontologico questa distinzione è sfumata
Perché di fatto Milone vuole ribadire l’importanza dell’accettazione dell’altro, della malattia: «Negare l’esistenza della follia dicendo che siamo tutti uguali è annullare la diversità dell’altro, rendendo tutto grigio. […] Non bisogna dire che siamo tutti uguali, bisogna conoscere le differenze». Ma la riflessione che nasce dalla lettura è molto più ampia: se a livello spaziale è un muro a dividere i sani dai malati psichiatrici, da un punto di vista ontologico questa distinzione è sfumata e traballante.
L’arte di legare le persone non è solo un racconto di persone. È anche un racconto di luoghi, interiori e fisici. C’è il mare, innanzitutto. Rigenerante, terapeutico, che «ti incanta, ti ipnotizza […] ti dà una spruzzata d’acqua sui piedi». Chi con quelle vaste distese blu sente sussistere un legame viscerale, non tarderà a compiacersi, annuire e provare un’emozione leggendo le righe che Milone gli dedica. «I genovesi, quando sono pesti e tristi, salgono su uno scoglio e vanno a parlare al mare». Le sue acque permettono di fare chiarezza, la vista dell’andirivieni delle onde restituisce fiducia nella possibilità che lo scorrere del tempo possa recare con sé le risposte. Il mare come oracolo, ma anche come il luogo dove terminano le corse affannate a inseguire i pazienti che riescono a trovare una via di fuga dal reparto.
Un altro luogo che si respira leggendo il libro è la città di Genova, «città storta», con i suoi caruggi e gli spazi angusti. Lei che abbraccia e contiene tutti, senza fare distinzioni. A volte, i folli li nasconde, rendendoli quasi invisibili agli occhi delle persone; altre volte, li mostra nei loro atteggiamenti più bizzarri.
Fin qui, la vita a cielo aperto. Ma vengono tratteggiati anche luoghi chiusi, l’ospedale e le residenze private. L’ambiente del reparto è quello della fisicità, degli sguardi, della drammaticità e della cura. Poche caratterizzazioni, se non le porte, le luci sul soffitto, il via vai di medici e infermieri. A fare da contraltare alla Psichiatria sono alcune abitazioni, capaci di rispecchiare le abitudini di coloro che per anni le hanno abitate. La descrizione della casa in un passaggio è resa, in modo quasi esilarante, attraverso l’immagine delle tazzine scolorite e impolverate, riposte da tempo in una vecchia credenza e ora utilizzate per rendere più elegante la pausa caffè, emblema del gesto di accoglienza. Accanto a biscotti e caramelle, finiti in un barattolo da chissà quanto tempo. Ma ci sono anche case con quadri, mobili antichi e pavimenti in marmo. La biblioteca e il ricordo della servitù. Questa volta le tazzine per servire il caffè sono impeccabili, trasportate su un carrello, in ceramica olandese. In altre abitazioni ancora, l’attenzione viene attirata da lettere d’amore mai spedite ma conservate come si conservano le cose preziose.
Tra le pagine di Paolo Milone non si percepisce solo il profumo di salsedine, del glicine fiorito e delle erbe aromatiche, ma ci si lascia coinvolgere dall’ironia e dallo sguardo gentile che emerge nel raccontare la relazione con la follia.
Il 12 marzo di quarantacinque anni fa nelle sale italiane usciva Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, basato sul romanzo di Ken Kesey. Tra questi e l’opera di Milone sembra essere racchiuso molto del percorso fatto nella società rispetto a questo tema
Era il 12 marzo di quarantacinque anni fa e nelle sale italiane usciva un film che pure si proponeva di raccontare il mondo della psichiatria: la pellicola è Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, sceneggiata da Lawrence Hauben e Bo Goldman, uscita negli Stati Uniti l’anno precedente. Il lungometraggio, insignito di cinque premi Oscar e numerosi altri riconoscimenti, si basa sul romanzo di Ken Kesey. Certamente non sono l’unico film e l’unico romanzo a rappresentare la malattia mentale, ma tra questi e l’opera di Milone sembra essere racchiuso molto del percorso fatto nella società rispetto a questo tema. Siamo di fronte a due mondi diversi che pure dialogano tra loro e – a tratti – si muovono in parallelo. Qualche esempio. Siamo all’inizio del romanzo di Kesey e pare di udire lo stesso rumore di chiavi che evocano le pagine de L’arte di legare le persone. Solo che quelle chiavi non sono in mano a chi ha compreso negli anni che si è insieme ad affrontare la malattia, ma a chi evidenzia con atteggiamenti algidi la linea netta di separazione tra chi cura e chi è curato. «Sto lavando il pavimento accanto alla porta della corsia quando una chiave viene infilata nella toppa dall’altro lato ed io capisco che si tratta della Grande Infermiera da come gli intagli della serratura si adattano alla chiave». Il riferimento è a Mildred Ratched, personaggio simbolo del film, cui anche Netflix di recente ha dedicato una serie tv. Un altro punto di contatto è rappresentato da uno dei dialoghi certamente più suggestivi della trama: mi riferisco a quando McMurphy, interpretato da Jack Nicholson, scopre che i compagni sono ricoverati in clinica in modo volontario. Nel romanzo, il protagonista si rivolge a loro con queste parole: «Volevo dire… diavolo, mi ha stupito constatare quanto siete sani tutti voi. Da quanto posso arguire non siete più matti dello stupido uomo qualunque medio». Come detto, anche Milone si addentra nel tema delicato del confine tra normalità e follia, così come affronta un’altra questione di enorme sensibilità e controversa, quella che dà il titolo al suo libro, ossia l’opportunità di contenere i malati laddove «la ragione e il cuore [non] possano comprendere e placare tutto».
Paolo Milone non vuole insegnare niente a nessuno. Racconta la sua professione con le sue miriadi di sfaccettature, e noi lo leggiamo attenti e curiosi, quasi accostassimo delicatamente l’orecchio alla sua voce, come si fa con le conchiglie per ascoltare il rumore del mare.

Riproduzione riservata