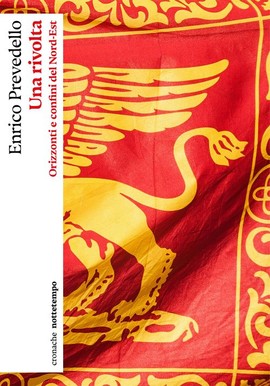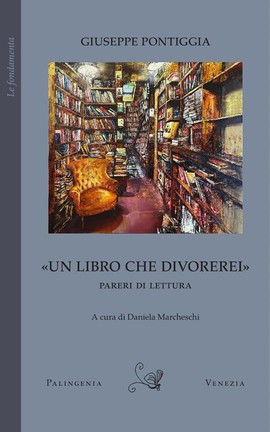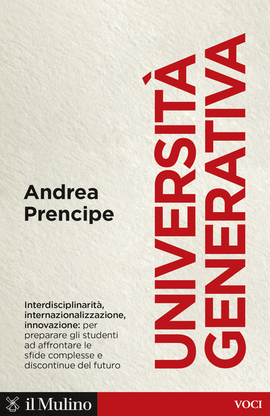Che cosa potrebbe accadere se un giorno, nemmeno troppo lontano, i giudici fossero sostituiti da semplici app che fanno ricorso ad algoritmi predittivi? Se i contratti fossero sottoscritti, impugnati e risolti su piattaforme on line? Se le trascrizioni nei pubblici registri fossero soppiantate da sistemi di registrazione blockchain? Dopo la sanità sarà il diritto il prossimo territorio colonizzato dalla tecnologia digitale?
È nelle acque agitate da simili questioni che si colloca un recente studio di Antoine Garapon e Jean Lassègue dedicato alla Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique (Puf, 2018). Gli strumenti di cui si dotano gli autori per siffatta "navigazione" – il lemma cyber ha un etimo greco-antico: kyber, che ha precisamente il significato di "timone" – sono complessi e variegati: provengono dal mondo del diritto, della filosofia, dell’antropologia e dell’informatica.
Il ricorso incrociato a tali discipline risulta evidente già nella prima parte, delle tre di cui si compone il volume, dedicata a Cosa sia la giustizia digitale. È certamente quella di meno agevole lettura, ma è anche – a parere di chi scrive – quella più innovativa perché ispirata a una pura, originale, intuizione: che il digitale, «questo oceano di 0 e di 1» (p. 35), sia innanzitutto una "rivoluzione grafica", di scrittura.
In effetti se confrontata con la scrittura alfabetica, le numérique (come definito in francese) non emette alcun suono, perché non è stato concepito per essere letto, né compreso, da un uomo. Inoltre se nella scrittura alfabetica esiste una simultaneità tra la percezione dei segni grafici e la relativa comprensione, con la scrittura numerica questa simultaneità si perde. In sintesi nel numérique abbiamo due momenti: dapprima la scrittura e solo a seguire, attraverso il ricorso a un programma di lettura (software), la comprensione della prima che altrimenti resta, oltre che muta, opaca.
La scrittura digitale, insomma, non è in grado di «registrare il mondo ma solo di trattare informazioni» (p. 55), ovvero «una massa digitale muta che non ha alcun senso» e che facciamo parlare solo «attraverso il ricorso ad algoritmi» (p. 87). Per questa ragione essa deve contenere termini univoci non suscettibili di diverse interpretazioni, ma operando in tal modo si perde una delle funzioni fondamentali del linguaggio: quella di "produrre senso" attraverso l’adattamento ai diversi contesti. La parola Roma, per dire, «designa un luogo geografico, la Capitale d’Italia, ma anche il Vaticano e per estensione la Chiesa Cattolica» (p. 48).
Premesse tali considerazioni, appare innegabile che l’ingresso della scrittura numerica nel campo del diritto determini una mutazione politica, sociologica, cognitiva. Oggi gli individui sono portati a credere più agevolmente ai risultati di una funzione algoritmica che non a un’interpretazione. Benché una simile constatazione stia provocando più di una «ferita narcisistica» tra i giuristi (p. 103) essa merita di essere affrontata con il più grande rispetto e senza inconcludenti levate di scudi. D’altra parte è difficile immaginare che si possa tornare indietro.
Vengo così alla seconda parte del volume dedicata a Ciò che la giustizia digitale sta facendo all’idea di giustizia, con particolare riferimento al concetto di verità «oggetto di un trattamento piuttosto che di un’interpretazione» (p. 174).
Nel contesto di un giudizio digitale le tre unità di tempo, di luogo e d’azione – adottate nel processo tradizionale e ispirate al teatro classico – risultano superate. L’algoritmo non ha bisogno di una successione temporale in cui le parti si alternano nella presentazione degli argomenti e nemmeno di una prospettiva d’insieme. L’aula composta ad emiciclo dove tutti possano vedere e tutti possano simultaneamente sentire (perché «una parola si comprende anche attraverso i propri silenzi, oltre che attraverso i silenzi che essa è in grado di produrre: "un silenzio di morte"», p. 185) appare, in tale contesto, superata. Nel modello di giustizia digitale e non figurativa «è la massa delle correlazioni – e non il ragionamento o l’autorità dei principi – a determinare il diritto» (p. 226).
Ma si può davvero sostituire la casualità con la correlazione? Per rispondere a tale quesito gli autori distinguono – come ha fatto la scienza nel corso del Novecento – tra determinismo e predittività. Infatti giacché anche la più infinitesimale modifica alle condizioni di azione può ripercuotersi in modo imprevedibile sul risultato finale, trarre forza normativa dalla capacità predittiva – e cioè far discendere la legge da un algoritmo – significa partire dall’assunto, erroneo, che il futuro possa derivare dal passato riconoscendo le due dimensioni – passato e futuro – come omogenee, eternizzate in un presente continuo e in un certo senso "aumentato". Così non è, per ragioni facilmente intuitive. Per dirla con Raymond Aron: «Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font» (cit. a p. 100).
In conclusione, le numérique è una tecnica trasversale applicabile a qualsiasi contesto, ivi compreso il diritto. Tuttavia, non si tratta di un processo – mi sia concesso il gioco di parole – neutro, poiché la giustizia digitale sostituendo il «terzo simbolico» con il «terzo algebrico» non elimina la rappresentazione simbolica, ma si limita a sostituire un mito con un altro (p. 109).
È questo il centro della terza parte del volume dedicata a Ciò che l’idea di giustizia impone alla giustizia digitale. Ivi gli autori esprimono l’esigenza di «uscire dal mito della delegazione alla macchina» (p. 327) al fine di valutare la giustizia digitale non sulla base di quanto essa sia funzionale o meno – l’arida querelle che oppone i tecno-entusiasti ai tecno-scettici – ma sullo sfondo di valori eminentemente politici, come la libertà (p. 336) oppure la dignità (p. 342).
In fin dei conti si tratta di consentire la sottoposizione dell’idea stessa di giustizia digitale al… giudizio di un terzo! Un terzo senza il quale la società può deteriorarsi, tanto sul versante della «prossimità non regolamentata» quanto su quello della «distanza incolmabile» tra i consociati (p. 340).
L’uomo, animale simbolico, sociale, politico deve vivere nell’ambiente che gli è proprio. D’altronde è solo in quest’ultimo che è possibile cogliere la raffinata sottigliezza di osservazioni come questa: «Chiedersi se un computer possa pensare è tanto interessante quanto chiedersi se un sottomarino possa nuotare» (E. W. Dijkstra, cit. in L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, trad. it. Cortina, 2017, p. 160).
[Del volume, che sarà presentato il giorno 20 novembre in Università Cattolica (Milano), non è stata ancora approntata una versione in italiano. Pertanto le traduzioni riportate in virgolette sono mie.]

Riproduzione riservata