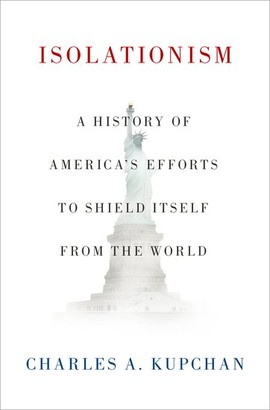Questo articolo fa parte dello speciale 20 anni dopo l'11 settembre
Nei giorni convulsi di metà agosto, con la presa di Kabul da parte dei talebani, si è consumata la fine di un’utopia, il sogno degli Stati Uniti di presentarsi come «nazione indispensabile» in grado di plasmare il mondo sulla base dei valori di libertà, diritti e tolleranza religiosa. Così, amaramente, commentava l’editoriale del «New York Times» del 15 agosto. A vent'anni anni dall’11 settembre 2001, il drammatico esito della guerra più lunga combattuta dagli Stati Uniti nel corso della sua storia, segnato dal caos e dal disordine gestionale, ha richiamato alla mente le immagini di una delle ferite più laceranti della coscienza americana e tutt’altro che rimarginata, quella del Vietnam. Quando la situazione si sarà raffreddata e le reazioni emotive lasceranno il campo ad analisi più ponderate, si valuterà meglio se gli accadimenti dell’oggi hanno segnato la fine di un ciclo storico iniziato negli anni Quaranta del Novecento con l’apertura di un’era contraddistinta dai principi dell’internazionalismo liberale o se, invece, non si debba considerare il periodo che va dalla Seconda guerra mondiale fino alla fine della Guerra fredda e all’11 settembre 2001 come la «grande eccezione» all’interno della storia plurisecolare della potenza statunitense.
È questa la tesi sostenuta da Charles A. Kupchan nel suo ultimo volume Isolationism. A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World (Oxford University Press, 2020) che può offrire un contributo interessante al dibattito odierno. Kupchan – docente alla Georgetown University, membro del Council on Foreign Relations che ha fatto parte, con la presidenza Obama, del National Security Council – intraprende uno studio storico che ambisce a fornire anche indicazioni per il rilancio della leadership statunitense. Lo fa attraverso l’analisi di un termine controverso, «isolazionismo», entrato in uso negli anni Trenta del Novecento con connotazioni negative e che si associava a una varietà di posizioni che invocavano il ritiro statunitense da possibili coinvolgimenti internazionali all’indomani della Prima guerra mondiale, il rifiuto della Società delle nazioni e dell’internazionalismo propugnato da Woodrow Wilson. Posizioni che spingevano per un ripiegamento strategico statunitense all’interno del proprio emisfero e che furono poi fortemente discreditate dall’attacco giapponese a Pearl Harbor.
E tuttavia, sostiene Kupchan, una politica di tipo isolazionista aveva caratterizzato le scelte della nazione americana dalla sua fondazione ed era stata prevalente (e di successo) fino alla sua progressiva marginalizzazione a partire dal 1898 e poi più decisamente dopo il 1945.
Kupchan si pone, quindi, tre obiettivi principali. Prima di tutto, ritiene che si debba colmare un vuoto storiografico, fornendo una «comprehesive political and intellectual history of the subject», ritenendo che raramente questo concetto è stato affrontato da una prospettiva di lunga durata. Inoltre, egli intende rivalutare il termine «isolazionismo», mettendo in evidenza gli elementi positivi di una strategia che ha, a suo avviso, accompagnato l’ascesa della potenza americana. Questo non significa, ribadisce, invocare un ritorno all’isolazionismo, ipotesi che ritiene antistorica e impraticabile nel contesto odierno. Gli Stati Uniti devono continuare a portare avanti gli impegni strategici soprattutto in Europa e in Asia, ma la lezione che si può trarre dal passato, in virtù di quelli che ritiene successi della «grande strategia isolazionista», è quella di ridimensionare un eccesso di obbligazione strategica, soprattutto in aree che potrebbero essere considerate periferiche.
L’isolazionismo non fu il frutto di una "delusion", ma di una "sound strategic logic", fondata sulla consapevolezza che stare fuori dalla logica di potenza era vitale per il perseguimento degli obiettivi di costruzione della potenza americana
Ripensare alla stagione isolazionista permetterebbe quindi di valutare meglio l’entità e la portata degli impegni e degli obiettivi strategici. Da questo punto di vista, «rehabilitating isolationism will help ensure that grand strategies of restraint again enter the mainstream of American debate» (p. 9), perché l’isolazionismo non fu il frutto di una delusion, ma di una sound strategic logic, fondata su un senso di sicurezza garantito dagli oceani e sulla consapevolezza che stare fuori dalla logica di potenza era vitale per il perseguimento degli obiettivi di costruzione dello Stato e della potenza americana. Questo non significava stare fuori dal sistema internazionale. Il concetto di interdipendenza, ci ha ricordato David Armitage in La Dichiarazione di Indipendenza: una storia globale (trad. it. Utet, 2008), era al centro del progetto di fondazione del nuovo Stato al pari dell’affermazione dell’indipendenza dall’impero britannico. Stare dentro la comunità degli Stati, condividendone le logiche, ma allo stesso tempo prendere le distanze dalla politica di potenza, costituiva l’ambizione che si rintracciava fin dai Padri fondatori. Una posizione non priva di contraddizioni e ambivalenze come Kupchan lascia intravedere anche se non sempre ne coglie tutte le implicazioni teoriche.
Infine, il terzo obiettivo del volume è quello di proporre un’analisi delle fonti intellettuali dell’isolazionismo, indagarne le radici ideologiche, per mostrare le ragioni profonde non solo della sua lunga durata, ma di quelle che portano al consolidarsi di un «ambitious brand of internationalism» (p. 13). Una delle radici ideologiche più forti e pervasive è stato l’eccezionalismo, vale a dire quel concetto che ritiene che gli Stati Uniti rappresentino un esperimento unico di libertà politica ed economica, destinato a essere condiviso (e poi esportato) al resto del mondo. Il carattere eccezionale dell’esperimento americano è ciò che alimenta il fondamento ideologico del ruolo globale statunitense, la sua legittimità e responsabilità. Come osserva Kupchan, non sempre la storia e la prassi della politica statunitense sono state all’altezza delle sue ambizioni e tuttavia l’eccezionalismo è stato in grado di plasmare il discorso pubblico e politico americano, pur di presidenti diversi come Obama e Trump. È l’eccezionalismo a produrre l’idea degli Stati Uniti come «nazione indispensabile» (espressione usata da Madeleine Albright nel 1998), che non solo si impone come modello da seguire, ma si erge anche ad artefice della diffusione della democrazia (Kennedy aveva parlato della «diffusione della malattia della libertà»). Allo stesso tempo, sostiene Kupchan, l’eccezionalismo è stato un ingrediente chiave dell’isolazionismo: proprio perché il suo era un esperimento unico ed eccezionale, gli Stati Uniti dovevano proteggersi, rimanendo distanti dai pericoli e dalle influenze perniciose provenienti dal di là dei loro confini.
L’isolazionismo americano si fonda, in particolare, su sei dispositivi logici distinti anche se interconnessi: la centralità del concetto di sicurezza nazionale, l’ambizione di presentarsi come nazione «redentrice», la priorità data all’avanzamento dell’idea di libertà e prosperità all’interno dello spazio politico, la necessità di preservare agli Stati Uniti la libertà d’azione nel contesto internazionale, la volontà di difendere l’omogeneità sociale della nazione e la promozione del pacifismo. Sei elementi che hanno contraddistinto e dato spessore, con articolazioni diverse al proprio interno, alla narrazione isolazionista ed eccezionalista statunitense. Come si è accennato sopra, l’isolazionismo come scelta naturale di una nazione «provvidenziale» venne espresso in termini chiari dai Padri fondatori della nuova Repubblica. Nel Federalista n. 2 John Jay scriveva come gli Stati Uniti e il popolo americano fossero espressione del disegno della Provvidenza. Il popolo americano come popolo scelto, nuovo Israele era ciò che permetteva, secondo Thomas Jefferson, la costruzione di quell’impero della libertà che si poteva dare per essere separati dall’oceano dall’Europa in preda alla corruzione e alla tirannia.
La separazione dalle potenze europee – con il rifiuto delle entangling alliances – era ciò che avrebbe permesso, come affermò George Washington nel suo Farewell Address, documento fondante la narrazione isolazionista, la promozione della libertà e la prosperità economica con l’ampliamento dei mercati e la conquista di quello spazio ritenuto naturalmente votato all’espansione della nazione americana. Espansionismo e isolazionismo quindi hanno in modo tutt’altro che incoerente contraddistinto l’azione politica statunitense all’interno di un obiettivo che era quello di creare un cordone di sicurezza – annientando i popoli nativi ed estromettendo le nazioni europee dall’emisfero americano sulla base dei principi della dottrina Monroe del 1823 – necessario per il progetto di costruzione della democrazia americana. Un progetto che fin dalle origini presenta connotazioni razziali molto precise: la whiteness e la preservazione della «bianchezza» del popolo americano divenne parte integrante del discorso isolazionista fin dagli albori della Repubblica. Nonostante le spinte espansionistiche di chi avrebbe voluto che il progetto di allargamento della Repubblica riguardasse anche i Caraibi e il Centro America, in realtà una delle motivazioni che, ricorrentemente, portarono il Congresso, nel corso dell’Ottocento, a respingere l’annessione di Paesi come Cuba, Haiti e Santo Domingo era quello di non inglobare popolazioni razzialmente miste considerate inassimilabili e unfit per la democrazia. Il destino manifesto di una nazione provvidenziale riguardava la popolazione bianca di origine anglosassone e protestante e non poteva includere soggetti incapaci di autogoverno o per motivi religiosi (il cattolicesimo come espressione dell’oscurantismo) o per motivi etnico-razziali.
Questi aspetti non vengono messi in discussione neppure quando, con la guerra del 1898 contro la Spagna, gli Stati Uniti cominciano a deviare dal corso isolazionista del passato, per poi suggellare la sterzata con l’entrata in guerra nel 1917. Tuttavia, nonostante la visione internazionalista promossa dal presidente Wilson, la decisione di entrare nella Prima guerra mondiale come «potenza associata» dimostrava, per Kupchan, la persistenza della visione eccezionalista e la volontà di non rinnegare il monito di Washington sulle entangling alliances. Il progetto wilsoniano quindi doveva fare i conti con un passato ingombrante che non poteva essere rinnegato così facilmente e che faceva sentire il suo peso grazie alla forza di alcuni movimenti e gruppi che, dentro e fuori i partiti, cercavano di frenare l’idealismo wilsoniano.
Sono l’eccezionalismo e il suo rinnovamento che permettono, quindi, il passaggio dalla nazione «esemplare» alla nazione crusader, che porta al rigetto dell’isolazionismo perché, alla fine dell’Ottocento, da un lato si era compiuto il destino manifesto con la fine della frontiera, vale a dire l’espansione in tutto il Nord America, e dall’altro emergevano le esigenze di un capitalismo industriale e corporate per il quale era vitale individuare «nuove frontiere», necessarie per salvaguardare il sogno americano.
Kupchan è consapevole che la soluzione non può essere quella del ritorno all’isolazionismo. Occorre semmai trovare un middle ground fra un isolazionismo che deve essere riscoperto nella sua logica razionale e un internazionalismo che non è più in grado di ergersi come perno dell’ordine politico internazionale
Saranno però soprattutto Franklin Delano Roosevelt e i suoi successori a mettere definitivamente ai margini l’isolazionismo, attraverso un’elaborazione dell’internazionalismo che fondava istanze realiste e impulsi ideali, senza tuttavia rigettare quella missione eccezionalista propria della redeemer nation. Senza entrare qui nel merito delle diverse implicazioni dell’internazionalismo liberale e delle sue articolazioni nel contesto di Guerra fredda, per capire, secondo Kupchan, il risorgere degli impulsi isolazionisti occorre comprendere i mutamenti della politica statunitense a partire dagli anni Novanta del Novecento. La fine della Guerra fredda e quindi dell’esistenza di un competitor in grado di temperare gli impulsi interventisti e unilateralisti e impedire l’overreach, e la crescente polarizzazione politica che mette fine a quel consenso bipartitico che aveva guidato la costruzione egemonica del secolo americano, sono due tra i fattori più importanti alla base dell’impasse di oggi: se l’internazionalismo liberale, formulato da Roosevelt, aveva avuto l’ambizione di tenere assieme politica di potenza e cooperazione (power and partnership), adesso i due obiettivi si sono separati e sono giocati in chiave antagonistica all’interno dello scontro ideologico fra i due partiti.
Come si è detto prima, Kupchan è consapevole che la soluzione non può essere quella del ritorno all’isolazionismo. Occorre semmai trovare un middle ground fra un isolazionismo che deve essere riscoperto nella sua logica razionale e un internazionalismo che non è più in grado di ergersi come perno dell’ordine politico internazionale. Purtroppo non è una sfida semplice e Kupchan non fornisce gli strumenti per andare oltre gli auspici d’occasione.

Riproduzione riservata