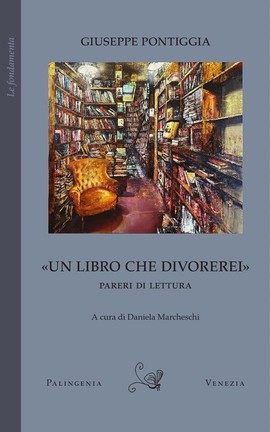Ci sono libri che offrono molto più di quanto il titolo prometta. Così, il lettore che aprisse lo studio di Celenza (Il Rinascimento perduto. La letteratura latina nella cultura italiana del Quattrocento, Carocci, 2014) potrebbe attendersi una dotta disquisizione sulla produzione letteraria in lingua latina tra Quattro e Cinquecento. Che è ovviamente quello che troverebbe. Ma insieme troverà altro ed è questo che fa la differenza: una riflessione complessiva su cosa sono Umanesimo e Rinascimento e su cosa essi significano per noi – o meglio una discussione sulle ragioni del crescente oblio che sta avvolgendo quel periodo della nostra storia, e una spiegazione dei rischi che questo comporta.
Nessuno lo nega: Umanesimo e Rinascimento costituiscono per tutti una pagina gloriosa della storia umana, una vetta dello spirito, che ha prodotto opere meravigliose. Ma una pagina gloriosa di cui, una volta che gli si è tributato l’omaggio di convenienza, ci si dimentica in fretta, presi come si è da problemi più seri. Si potrebbe pensare che questo sia il destino inevitabile che attende tutte le epoche del passato; e magari è così. Ma almeno dovrebbe essere chiaro che questo avviene non per ineluttabili leggi naturali, bensì in conseguenza di decisioni umane, decisioni su cui è giusto riflettere, almeno per chi resista alla mistica dell’hegelismo, per cui quello che accade è giusto per il semplice fatto che accade. Di queste decisioni tratta il libro di Celenza.
Una prima questione riguarda le politiche accademiche. Sintetizzando al massimo, il problema del Rinascimento è in effetti semplice e concreto: questo periodo non ha uno spazio disciplinare ben definito e questo significa che chi ad esso si dedica ha sempre meno possibilità di trovare un posto in università. Il che innesca un circolo vizioso deleterio, dalle conseguenze facilmente prevedibili. Celenza parla del sistema americano, ma le cose da noi non vanno troppo diversamente. Data l’importanza di questo periodo per la nostra storia, quello che sta succedendo dovrebbe dunque suggerire qualche riflessione. Si arriva così al punto più importante.
Il problema saliente non è infatti la denuncia accorata dei rischi a cui va incontro una disciplina accademica. Quello su cui è interessante riflettere sono le ragioni teoriche che stanno alla base di questa tendenza. Il Rinascimento è ormai associato alla storia dell’arte (e ci mancherebbe!), a qualche capolavoro letterario e allo studio di argomenti sempre suggestivi come ad esempio la magia. Ma tutti questi fenomeni, per quanto importanti, erano visti dai contemporanei come sviluppi di un problema più sostanziale. Un problema sostanziale che è la filosofia. Per i contemporanei, la novità del Rinascimento è una novità che ha a che fare con una nuova concezione della filosofia, intesa come un sapere eminentemente pratico e politico, che si contrappone al sapere speculativo della scolastica medievale. Chi, ai giorni nostri, sarebbe d’accordo con questa idea di un Rinascimento eminentemente filosofico? Ma il punto è proprio questo: il problema del Rinascimento è un problema filosofico.
La marginalizzazione dello studio del Rinascimento è infatti il risultato di una storia di lungo corso: dipende da una concezione della filosofia che si è progressivamente imposta nel sistema universitario tedesco nell’Ottocento e che da lì si è diffusa negli altri Paesi. Naturalmente, i motivi che hanno prodotto un simile risultato sono molteplici, e non vanno sottovalutati. L’importanza che nell’Ottocento veniva accordata alle lingue nazionali cospirava contro il modello rinascimentale che si fondava su una lingua franca come il latino: per chi era convinto che la lingua esprimesse «il genio di un popolo», è evidente che la scelta di scrivere in una lingua estranea aveva di fatto impedito lo sviluppo di una cultura autonoma e capace di parlare dei problemi reali; il mondo degli umanisti è eine Welt des Scheines, aveva scritto il filologo Georg Voigt, «un mondo di apparenze», in cui gli umanisti si muovevano come «meri sofisti, persuasi che il mondo che avevano fondato con il linguaggio fosse il proprio mondo reale» (p. 34). Più in generale, non bisogna poi dimenticare, sottotraccia, il ruolo non indifferente giocato dalla graecomania tipica del mondo tedesco e protestante; anche questo ha giocato contro una valutazione equilibrata della cultura umanistica latina.
Ma la vera ragione della marginalizzazione di Umanesimo e Rinascimento come campo disciplinare autonomo ha a che fare in ultima istanza con la filosofia. L’appiattimento progressivo dei saperi umani sul modello dei saperi scientifici ha imposto con forza crescente una nozione di filosofia intesa come "scienza rigorosa" e teoretica, con la conseguente esclusione di autori e periodi che in questo schema non potevano rientrare. Ecco spiegato il problema del Rinascimento – lo sfasamento di prospettiva tra come noi valutiamo quel periodo e come esso fosse valutato dai suoi protagonisti.
Naturalmente, l’obiettivo di Celenza non è quello di preconizzare un improbabile ritorno ai bei tempi che furono. Piuttosto si tratta di prendere coscienza del fatto che il sapere umano segue un percorso meno lineare, e dunque molto più interessante, di cui vale la pena essere consapevoli. Tra Quattro e Cinquecento la filosofia è esperienza di vita più che sistema dottrinale; s’interessa più alle tecniche argomentative, alla retorica, che ai problemi epistemologici; ha una dimensione pratica, etica e politica, dominante, che la conduce al continuo confronto con lo studio della storia (cfr., ad esempio, pp. 83 e 117). A partire dall’età moderna a contare sempre di più sarà invece la philosophia naturalis, vale a dire il confronto con la scienza: è una lunga ondata che ancora produce i suoi effetti e che oggi, di fronte ai progressi immensi della ricerca scientifica, rischia di togliere tutto il terreno sotto i piedi della filosofia. Negare l’importanza, storica e teorica, del confronto con le scienze sarebbe ridicolo; ma non meno ridicolo è dimenticarsi che la filosofia non è necessariamente solo questo. L’interesse della polemica di Celenza è in fondo tutta qui: in questo invito a ricordarci che la filosofia è una disciplina più ricca, più ambigua, più complicata, di come spesso si tende a credere. E questo suggerisce qualche considerazione su di noi.
Il contributo che lo studio del pensiero rinascimentale può offrire a una concezione più ricca della filosofia diventa infatti particolarmente significativo proprio se consideriamo il caso italiano. In fondo, se si accetta una nozione teoretica e sistematizzante della filosofia, è forte la tentazione di concludere che non ha molto senso parlare di una filosofia italiana, così come invece si parla di filosofia tedesca, francese, inglese o americana. Ma non si tratterebbe di un giudizio affrettato? Un giudizio che riflette inconsapevolmente una nozione parziale, troppo ristretta, della filosofia, di cui sarebbe ormai ora di liberarsi? Che la tradizione dell’Italian thought offra strumenti interessanti per pensare la complessità del mondo contemporaneo, proprio in virtù della sua vocazione non sistematica e pratico-politica, è opinione sempre più condivisa, confermata dal successo di numerosi autori italiani all’estero. Quello che vale la pena di ricordare in questa occasione è che è proprio sulla radice rinascimentale che si sono sviluppati questi rampolli moderni.
È una convinzione espressa con chiarezza negli studi recenti di Roberto Esposito, in particolare in Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana del 2010, che trova ora una conferma, dotta e ben articolata, in uno studio recentemente pubblicato in America. In The Other Renaissance. Italian Humanism between Hegel and Heidegger (University of Chiacago Press, 2014) Rocco Rubini (assistant professor all’Università di Chicago) ricostruisce il dibatitto sul Rinascimento che si sviluppò intorno agli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, mostrandone la rilevanza filosofica: non si trattava semplicemente di dibattiti storiografici, ma della rinnovata difesa di una concezione del sapere capace di conseguenze pratiche. In questo contesto un ruolo di primo piano spetta senza ombra di dubbio a L’umanesimo italiano di Eugenio Garin, inizialmente pubblicato in tedesco nel 1947 presso l’editore Francke di Berna in una collana curata da Ernesto Grassi, insieme – come a farne da contrappunto – alla Lettera sull’umanesimo di Martin Heidegger. Non si potrebbe dare dimostrazione più plastica di due modi diversi, probabilmente incompatibili, ma entrambi legittimi e interessanti, di intendere la filosofia (e non si potrebbe trovare un esempio più illuminante dell’opposizione culturale tra la Germania “grecomane” e l’Italia rinascimentale e latina). E se la tradizione metafisica di cui Heidegger, volente o nolente, fa parte è nota, non sarebbe ora di tornare a occuparci anche della tradizione alternativa, secondo cui la filosofia non è più ricerca di verità assolute e intemporali, ma anche «tempo e memoria, e senso della creazione umana e dell’opera terrena e della responsabilità», come scriveva Garin? Integrare Heidegger (ma anche i metafisici analitici contemporanei) con Coluccio Salutati e Leonardo Bruni, i due cancellieri che nella filosofia di Platone e Aristotele avevano trovato un pensiero capace di guidarli nell’amministrazione di Firenze? Perché no, perché non interessarsi anche a una concezione "romana" della filosofia, in una linea di pensiero che dall’umanesimo ci condurrebbe ad esempio all’illuminismo?

Riproduzione riservata