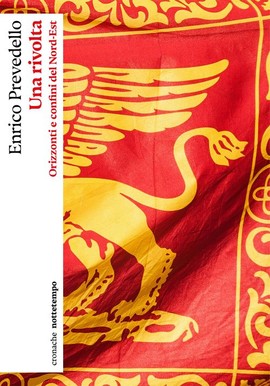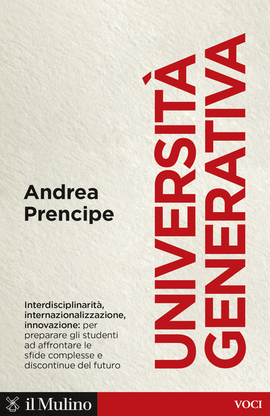Nessuna nostalgia per il passato, nessuna paura per il futuro. Capire il presente per costruire il futuro. Queste sono le due considerazioni che hanno guidato la mia lettura del denso, stimolante, efficace volume di Ferruccio Capelli, Il futuro addosso. L’incertezza, la paura e il farmaco populista (Milano, Guerini e Associati, 2018). Ho anche pensato che il presente è il prodotto del passato, di scelte, errori e responsabilità personali che bisogna individuare e criticare, superare. Differentemente da Capelli, credo che il presente non sia tutto populismo. È molto diversificato, non ha bisogno del "farmaco" populista, ma di politica e già contiene non pochi anticorpi che debbono e possono essere sollecitati. La grande trasformazione degli ultimi trent'anni è stata innescata, secondo Capelli, da due possenti motori: la globalizzazione (finanziaria e delle comunicazioni) e l’innovazione tecnologica. È stata giustificata e sostenuta dall’ideologia neo-liberale. Si è manifestata in tre ambiti, ovvero secondo tre modalità: la disintermediazione, la solitudine (involontaria) e lo spaesamento (culturale). L’esito complessivo è stato quello di aprire grandi spazi – vere e proprie praterie – alle incursioni populiste. Il populismo, o meglio, i populisti offrono una risposta che definirò ricompositiva: mettono insieme il loro popolo (gli altri, quelli che non ci stanno a farsi mettere insieme e continuano a essere molti, si meritano la definizione di "nemici del popolo" e come tali sono trattati), lo utilizzano contro le élite (l’establishment che Capelli sembra identificare con i potenti che si riuniscono a Davos, con coloro che definisce il "Senato virtuale", ma – di volta in volta – bisognerebbe specificare quale sia loro presenza e influenza dentro ciascun sistema politico e coglierne anche le contraddizioni), applicando politiche escludenti. Nazionalisti, forse, sovranisti di sicuro, quasi tutti i populisti, anzi, le élite (!) populiste appartengono a un passato del quale, però, non rivelano particolare nostalgia, tranne quella per un'omogeneità etnica, sicuramente non più recuperabile.
Disintermediazione vuole dire, secondo Capelli – e sono d’accordo – la scomparsa di capacità associative e, al tempo stesso, l’indebolimento di tutte le associazioni intermedie che avevano costituito il tessuto connettivo dei processi di democratizzazione e di consolidamento delle democrazie. A sostegno di ciò potrei citare alcuni importanti politologi che hanno scritto e argomentato che le democrazie sono inconcepibili senza partiti. Preferisco ricordare che – secondo Palmiro Togliatti – i partiti sono "la democrazia che si organizza". Giustamente, Capelli chiama in causa Alexis de Tocqueville e il suo elogio con sorprese delle propensioni associative degli americani, forse sottovalutando il pericolo del conformismo che l’aristocratico francese intravedeva in democrazie basate sull'uguaglianza di condizioni. Sotto dirò di più su uguaglianza e disuguaglianze.
Certo, la solitudine non conduce a interesse politico, a partecipazione politica, a solidarietà. La folla solitaria del sociologo americano David Riesman, pubblicato nel 1950, con un sottotitolo rivelatore: A study of the changing American character, precede di quasi cinquant'anni il – forse triste forse no – "andare a giocare a bowling da soli" (ossia senza una squadra di amici), best seller di Robert Putnam relativo al capitale sociale, vale a dire alle reti di rapporti sociali e affettivi che rendono la vita migliore. Naturalmente un conto è rimanere/ritrovarsi soli, un conto è il volere essere soli e non curarsene poiché si è convinti di possedere le risorse intellettuali, culturali, professionali per cavarsela senza l’aiuto di nessuno e per attivarsi esclusivamente con l'obiettivo di proteggere e promuovere i propri interessi. Sono i "post-materialisti" intelligentemente individuati e studiati da Ronald Inglehart, prodotti e produttori di una rivoluzione silenziosa nei costumi e nei comportamenti.
"Lo spaesamento del cittadino, senza mediazioni e senza cornici culturali, è un altro volto della solitudine dell’uomo [e della donna!] contemporaneo. Egli è libero, svincolato dalle tradizioni e da vincoli predefiniti con gli altri esseri umani, ma l’esercizio della sua libertà si rivela quanto mai problematico" (p. 177). Nel 1941, il grande psicologo Erich Fromm colse nel desiderio di fuggire dalla libertà – ossia dalla necessità di scegliere e dalla corrispondente responsabilizzazione – una delle ragioni per le quali uomini e donne si assoggettarono ai fascismi e al nazismo. Oggi, forse, è il leader populista a offrire questa protezione dalla libertà che, però, il cittadino esercita "nella galassia infinita del mercato" (p. 117).
Dietro o intorno a tutto questo stanno, da un lato, l'irresistibile globalizzazione, cioè un processo forse ingovernabile, certamente non governato; dall’altro, la vittoria su tutta la linea, sostiene Capelli, dell’ideologia neo-liberale. Le capacità di ciascuno e di tutti si misurano attraverso la competizione nei mercati. Il merito viene premiato. Gli sconfitti sono responsabili della loro condizione. Al massimo, lo Stato deve adempiere al compito di regolatore e valutatore. Non deve mai intervenire a favore di chicchessia, ma noi sappiamo – o forse no, sostiene Capelli – che esiste un Senato virtuale, fatto dai potenti in ciascun settore, che squilibra tutta la competizione e, quindi, che incide sugli esiti facendo diventare più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. "Il populismo è il sintomo [sosterrei, piuttosto, che è l’esito] più evidente della crisi della politica ridotta nella stagione neoliberale a tecnica di adattamento al mercato e di gestione del contingente" (p. 150).
Secondo Capelli, il populismo indica "un umore, uno stile, una mentalità" (p. 165). È mia opinione, invece, che il populismo debba essere letto e analizzato come un modo, uno dei modi possibili di fare politica nelle democrazie (Orbán è certamente un populista, mentre Putin e Erdogan praticano modalità populiste, ma sono due capi di regimi autoritari, nel caso turco con una spruzzata di fondamentalismo islamico). Dirò di più. In tutte le democrazie è insita una "striscia" di populismo, nel caso italiano accompagnata e pervertita da un cocktail di antipartitismo, antiparlamentarismo e anti-politica. Nelle democrazie più disintermediate – solitarie e spaesate – quella striscia s’ingrossa e confluisce nelle organizzazioni populiste. Non tutto quello che in politica non ci piace è populismo, ma il populismo non può piacere a chi ritiene che la democrazia abbia forme e limiti nei quali si esprime il popolo, funzioni tenendo conto di freni e di contrappesi, protegga e promuova diritti di tutti, delle minoranze di vario tipo, delle opposizioni. Ciò detto, non concordo con Capelli su un altro punto rilevante. La democrazia non ha mai promesso eguaglianza, meno che mai eguaglianza economica (né uguale soddisfacimento di aspettative, preferenze, obiettivi, bisogni). Sartori ha scritto che democrazia è soltanto, ma è moltissimo, isonomia: eguaglianza di fronte alla legge. Dal canto mio, sosterrò che la democrazia promette al popolo (demos) che potrà esercitare potere (kratos), nulla di più. Quel popolo e i singoli cittadini otterranno/eserciteranno influenza sulle decisioni politiche in base alla loro capacità di organizzarsi e di convincere – di volta in volta – le maggioranze. Quel popolo e i singoli cittadini hanno spesso chiesto uguaglianze (plurale) di opportunità e le socialdemocrazie sono spesso riuscite a dare e ridare quelle eguaglianze. Non ho qui lo spazio per indagare se la promessa di eguaglianze di opportunità non possa essere riproposta opportunamente riformulata.
Sostiene Capelli che la crisi della democrazia contemporanea dipenda da un elemento specifico: "mai tante promesse di eguaglianza e mai tante disuguaglianze". Non credo che sia così. La crisi affonda le radici proprio nei tre fattori da lui abilmente delineati all'inizio della sua analisi: disintermediazione, solitudine, spaesamento e in un quarto fattore da lui stesso accennato: il declino della rappresentanza politica. La soluzione sta in più democrazia, ma sicuramente nient'affatto in quella proclamata come "uno vale uno" (incidentalmente, in nessun ambito uno vale uno) che fa tutt'uno di masse disintermediate che si affannano ad osannare (qualc)uno. Più democrazia non significa neppure che tutte le decisioni di qualsiasi genere debbano essere sottoposte sempre a votazioni popolari attraverso Internet. Significa, invece, che è diventato imperativo esplorare tutte le potenzialità della democrazia deliberativa, delle modalità di istruzione di una decisione, di discussione di un problema, di diffusione delle conoscenze, di apprendimento, di coinvolgimento della cittadinanza fino alla decisione motivata. Qui s'incrociano la politica ("tutte le cose che succedono nella polis") e la democrazia (il potere dei cittadini sempre più istruiti in materia). No, il populismo non ha vinto e non vincerà. Altri futuri sono possibili.

Riproduzione riservata