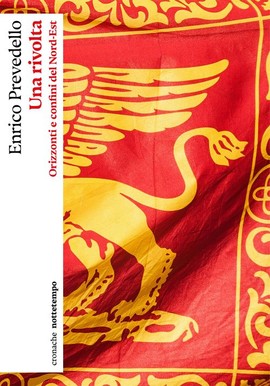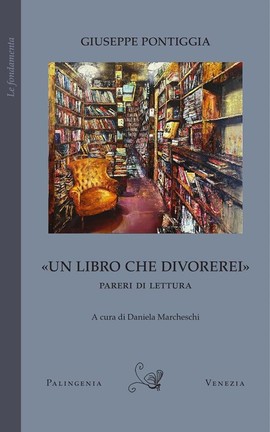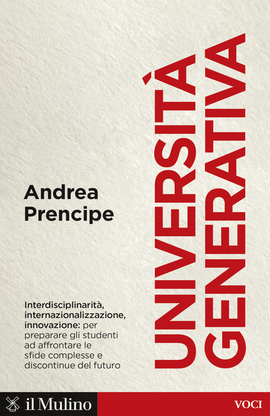Walter Veltroni negli ultimi anni ha pubblicato sul «Corriere della Sera» molte interviste a personalità politiche del Dopoguerra, spesso centrate attorno alla memoria del caso Moro. Ora ci torna con un libro, in cui ripresenta alcune delle stesse interviste con un’ampia introduzione, una sorta di saggio critico. Il parterre dei testimoni è apparentemente abbastanza bilanciato (tre democristiani: Rognoni, Pisanu e Segni; due comunisti: Tortorella e Occhetto; tre socialisti: Formica, Signorile e Martelli; una radicale: Bonino). Peraltro, le interviste, tutte interessanti, non sono identicamente legate al caso Moro (ad esempio lo toccano solo tangenzialmente Occhetto, Segni e Bonino). Prima di queste, l’autore ripresenta un più antico colloquio, condotto addirittura nel 1993, con Prospero Gallinari in carcere.
L’autore ricama quindi testimonianze e memorie, per presentarci alcune sue riflessioni sull’eredità della tragedia del 1978 nella storia del Paese. Merita discuterle per più ragioni, soggettive e oggettive. Le prime considerano la loro rilevanza nelle forme del dibattito pubblico. Veltroni è stato politico di primissimo piano, ma è ormai diventato anche una personalità mediatica a tutto tondo, con un importante ruolo creativo, giornalistico ed editoriale. Sono certo che le sue visioni lascino traccia. L’interesse oggettivo mi pare legato soprattutto ai meccanismi della memoria e a come questi condizionino, orientati in un modo o nell’altro, la coscienza collettiva. Il testo si muove, infatti, nel cuore di un nesso tra ricordi personali e memoria stratificata di un evento.
Il libro insiste sull’identificazione del caso Moro come spartiacque decisivo della storia della Repubblica. Il sequestro fu motivato dalla politica del leader Dc: «L’obiettivo del rapimento del 16 marzo era la funzione di cerniera che Moro aveva assunto in quel passaggio delicatissimo della storia nazionale» (pp. 23-24). Raccontando le origini degli orientamenti di Moro e Berlinguer per un’intesa, egli chiarisce anche che i due progetti non coincidevano negli sviluppi previsti dopo una fase di collaborazione. Veltroni sottolinea poi, efficacemente, la difficoltà della situazione creatasi dopo il 1976, con i contraccolpi subiti rispettivamente dai due protagonisti all’interno del proprio mondo. Il Pci dopo la grande avanzata doveva sostenere un monocolore Andreotti, la Dc che si era salvata dal declino elettorale doveva accettare di non poter governare senza l’assenso del grande avversario storico: questo snodo delicato portò a un clima di reazione da una parte e dall’altra.
In questo contesto delicato, il gorgo che si apre con via Fani. In primo luogo, riflettendo su quel passaggio si evidenzia il fallimento delle Br che «volevano il comunismo e hanno prodotto il pentapartito» (p. 34). Poi, la constatazione dei misteri irrisolti: «È tutto strano, è tutto sporco nella vicenda Moro» (due volte a p. 23). Quindi emergono i risvolti internazionali: «I veri trionfatori della vicenda Moro, va detto, sono stati i conservatori. I conservatori della Guerra fredda» (p. 35). Infine, la questione della fermezza: «Il Pci era onestamente convinto che le istituzioni non dovessero cedere al ricatto delle Brigate Rosse» (p. 48), nonostante il «disastro» della divisione con il Psi. Il concetto di chiusura: dopo la fine di Moro, la «Prima Repubblica» era finita, ma la Seconda nei fatti non è mai nata.
Queste riflessioni si inseriscono in un dibattito pluridecennale, che ha riempito ormai biblioteche intere, su tutti i risvolti della vicenda. Ma se si leggono congiuntamente alle sottolineature che emergono nelle interviste, portano acqua ad alcune concezioni diffuse di quel passaggio – sul piano della memoria collettiva – che non paiono affatto neutre. E che val la pena provare a misurare, anche alla luce delle acquisizioni della ricerca storica, che si basa sui documenti, aggiungendoli alla memoria o utilizzandoli per correggerla.
Il tema del sequestro come spartiacque è ampiamente sostenibile, anche se non da tutti accettato, poiché dipende soprattutto dall’interpretazione precisa delle mosse dei suoi due principali protagonistiIl tema del sequestro come spartiacque è ampiamente sostenibile (personalmente lo condivido), anche se non è da tutti accettato. Naturalmente, tale giudizio dipende soprattutto dall’interpretazione precisa delle mosse dei due principali protagonisti: soprattutto quelle di Moro sono state rilette anche recentemente in vari modi. Dobbiamo dire che una certa lacunosità delle fonti non aiuta ancora una sedimentazione precisa delle idee su cosa intendesse Moro parlando di «terza fase»: ancora recentemente qualcuno ha insistito sulla sua volontà di mantenere l’egemonia democristiana tenendo i comunisti «in mezzo al guado» per logorarli.
A me sembra convincente l’accentuazione di Veltroni sull’ipotesi per cui quell’iniziativa mirasse a una fase di legittimazione e maturazione reciproca tra i due maggiori attori del sistema, fino ad allora antagonisti, che avrebbe condotto poi a una nuova stagione dinamica (non venne mai peraltro chiaramente formulata in Moro l’ipotesi di una futura imminente «democrazia dell’alternanza», se non nella forma di un’assenza, nella constatazione problematica della «condanna a governare» della Dc a causa della «democrazia difficile» italiana). Veltroni ha anche ragioni da vendere a collegare il gesto delle Br a questa politica, mentre i brigatisti arrestati hanno sempre negato, sostenendo che avevano in mente di colpire «un simbolo del potere democristiano» e non la solidarietà nazionale.
La seconda questione, più intricata, è quella internazionale. Nel libro sono frequentissime le evocazioni delle incomprensioni Moro-Kissinger e degli scontri Berlinguer-Breznev. Ma a questo proposito occorre essere chiari: un conto è sostenere che evidentemente l’ipotesi della solidarietà nazionale in Italia non piacesse ai rispettivi governi delle due superpotenze. O anche che il suo fallimento (e magari la stessa uscita di scena di Moro) fosse benvisto dai «conservatori della Guerra fredda». Moro e Berlinguer non erano però degli ingenui: sapevano benissimo che la distensione internazionale (che era la condizione stessa di possibilità del loro incontro) giocava inizialmente in senso conservatore, per la necessità di Mosca e Washington di essere rassicurati sulla tenuta dei loro rispettivi «mondi»: entrambi i protagonisti del dialogo italiano però intravedevano la possibilità che proprio le condizioni nuove create dalla distensione in Europa (Ostpolitik, Helsinki), aprissero spiragli in senso innovativo, capaci di portare a un lento superamento delle rigidità dei due blocchi.
Questa la loro scommessa, che nel breve periodo si rivelò fallita (dieci anni dopo sarebbe stata vista diversamente). Il punto è però che da questa lettura non si può dedurre astrattamente che «il sistema di Yalta» sia la causa del caso Moro. In primo luogo, perché l’influsso delle superpotenze in Italia, lungo tutta la Guerra fredda, è sempre stato forte, ma prevalentemente indiretto, giocato attraverso la sponda con gli interlocutori interni italiani. Ma soprattutto perché le tracce di influssi diretti nel caso Moro della Cia o del Kgb (per semplificare con le rispettive icone), cercate con grande e anche comprensibile acribia, non si sono in effetti trovate. Non riesco qui a dare le prove di quanto affermo, ma la letteratura è ampia. Anche il citatissimo caso del consigliere americano Pieczenik (che si è vantato, trent’anni dopo, di essere riuscito a orientare la soluzione del caso verso la morte di Moro per sconfiggere le Br) è del tutto da ridimensionare in una ricostruzione solida dei fatti, dato che se ne tornò addirittura negli Stati Uniti tre settimane prima del 9 maggio.
Il terzo tema è quello di chi volesse Moro morto in Italia. Nelle interviste emerge una memoria di alcuni protagonisti che a questo proposito è veramente generalizzante: nessuno lo voleva salvare. Tesi discutibile, ovviamente. Che presenta, potremmo dire, due capitoli. Partiamo dal primo: Moro non lo si volle salvare, per scelta politica? Torniamo al dilemma «fermezza-trattativa»? Occorre anche su questo aspetto provare a essere precisi: il modo con cui nella memoria storica del Paese si è sedimentato questo confronto è del tutto improprio.
Moro non lo si volle salvare, per scelta politica? Torniamo al dilemma fermezza-trattativa? Occorre essere precisi: il modo con cui nella memoria storica del Paese si è sedimentato questo confronto è del tutto improprioDa una parte, infatti, la fermezza pubblica, il non cedimento, la difesa della logica dello Stato furono proprie di pressoché tutte le forze politiche (all’inizio anche del Psi). Per una banale ragione: trattare in pubblico non si può in casi di questo tipo, perché equivale a dichiarare una resa. Cosa che non era immaginabile da parte di nessuno: qui le Br hanno impolverato molto il discorso con la loro evocazione del «riconoscimento politico» come oggetto in gioco. Quale sarebbe stato il livello adeguato di questo riconoscimento non è mai stato chiaro (ci si provò con l’appello internazionale e il coinvolgimento di Amnesty o di Waldheim, clamorosamente snobbati dalle Br): occorreva forse che Andreotti o un democristiano importante andassero in tv a dire che le Br non erano una banda armata con cui lo Stato era in guerra, ma una parte politica rispettabile del Paese? Tanto è vero questo discorso, che la stessa svolta del Psi e di Craxi dopo il 20 aprile non riguardò mai pubblicamente l’ipotesi di una pubblica «trattativa», ma al massimo propose di uscire dalla staticità della fermezza con un «gesto umanitario». Ora, lungi da me negare gli aspetti problematici e a volte drammatici di questo compattamento pubblico sulla fermezza, tra cui il più evidente fu una strategia di depotenziamento e di delegittimazione dell’ostaggio, dolorosissima per Moro e inqualificabile per gli effetti sulla di lui memoria rimasta nel Paese (il lamentoso familista…).
Detto questo, era ovvio a tutti che in pubblico c’era una soglia che non si poteva superare. La conferma in negativo di questo discorso è che invece al di sotto della fermezza pubblica – e oggi lo conosciamo molto meglio di qualche tempo fa – una serie di tentativi di creare le premesse per una trattativa furono di fatto intrapresi. Quindi la inane staticità del sistema non fu proprio completa. Ne conosciamo almeno tre che cercarono freneticamente canali di comunicazione: l’iniziativa vaticana per un riscatto in denaro (tacitamente permessa dal governo e dal Pci); il tentativo di raggiungere le Br tramite il canale dei palestinesi (di cui sono emerse abbastanza recentemente le tracce); e infine i contatti Psi-Autonomia-Br «movimentiste»: per intenderci tra Piperno-Pace e Morucci-Faranda.
Il punto è: ma le Br volevano veramente trattare sulla vita di Moro? I fatti ci portano a dubitarne seriamente: a partire dal loro rendere pubblica, dileggiandola, la prima cruciale lettera di Moro a Cossiga del 29 marzo, in cui il rapito provava ad avviare un’iniziativa politica, pensando di rivolgersi riservatamente al collega di partito e ministro per ipotizzare la trattativa. Questo fu un primo macigno contro ogni possibilità di sviluppo concreto, proprio perché innescava l’irrigidimento ulteriore del Pci e di molti altri. E in seguito, con l’ondivago passaggio dei brigatisti che mutava il senso del rapimento: dal primato proclamato dopo via Fani del «processo» a Moro si passava a quello dello «scambio di prigionieri», con l’elenco palesemente provocatorio dei detenuti da liberare presentato il 24 aprile. Del resto, nelle interviste pubblicate da Veltroni gli esponenti socialisti presentano i loro contatti come quasi contenessero la soluzione del problema, che non volle essere perseguita.
Molte ricerche ci presentano invece un quadro ben più complicato: Craxi stesso fu molto dubbioso sulla possibilità di aver creato un vero canale, tanto da reiterare senza successo la richiesta di prove sull’esistenza in vita di Moro. Parla dei dubbi dei dirigenti socialisti anche il loro stesso silenzio con gli interlocutori a proposito di una situazione che non ritenevano affatto certa e risolutiva (Zaccagnini ricevette questa impressione dopo aver voluto andare apposta da Craxi per capire se c’era qualcosa di concreto, contro il parere di molti dirigenti democristiani, il 26 aprile). Quindi, oggi è difficile sostenere la tesi della via «sicura» volutamente non percorsa. I contatti non funzionarono, o forse lo sbandieramento della trattativa era per le Br solo un’altra forma di «propaganda armata». Per l’appunto.
Il secondo aspetto dello stesso discorso è che Moro sia morto a causa delle inefficienze dello Stato nelle indagini dei cinquantacinque giorni, che impedirono di trovare la prigione e battere i brigatisti sul piano poliziesco. Indiscutibili, a volte addirittura clamorose, tali inefficienze. Ma scavandoci dentro, chi se n’è seriamente occupato ha trovato di tutto: dalle ataviche approssimazioni italiane al periodo di transizioni dei servizi di intelligence, dalle divisioni tra le armi e nelle armi (Dalla Chiesa non gradito ad altri carabinieri). Fino a cose più inquietanti, come l’inquinamento esteso nelle istituzioni della P2, associazione politico-affaristica ovviamente contrarissima al progetto di Moro. Si può citare moltissimo a sostegno del fatto che nell’inefficienza ci fosse anche del dolo, ma non tutto: ad esempio sostenere che bastava «seguire Piperno e Pace» dopo i colloqui con i socialisti (Signorile, p. 161) implicherebbe che quei contatti fossero stati resi completamente noti alle autorità inquirenti, cosa dubbia a stare ad esempio a una reprimenda del giudice Priore nel corso dei processi successivi. Quindi, non si può accomunare tutte queste cose per approdare a una versione qualunquistica per cui «tutti» volevano la morte di Moro, compresi i vertici politici della Dc, del Pci e del governo, che avrebbero dato precise istruzioni agli apparati di non intervenire. Non c’è nessun elemento che indichi questa tesi suffragata da prove né da indizi.
Cedere a questa visione di un «sistema» compatto contro Moro – si badi bene Veltroni non la esplicita formalmente, ma in qualche passaggio generalizzante del discorso e soprattutto in qualche deformazione della memoria degli intervistati si va molto vicini ad adombrarla – fa pensare che le Br abbiano fallito su tutto, tranne su un punto propagandistico: l’aver fatto passare la convinzione che in fondo la responsabilità vera della morte di Moro non sia loro, ma appunto della Dc o del «sistema» che non ha voluto salvarlo seguendo le loro proposte. Se fate una piccola indagine di mercato, non sarete sorpresi su quanti italiani oggi condividano questa tesi. Portare ancora a essa acqua, in qualsiasi forma, non credo sia utile a nessuno.

Riproduzione riservata