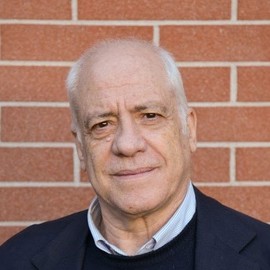“Quando noi andammo [a Parigi] al Commissariat au plan e poi al ministero delle Finanze dove c’era Edmond Malinvaud, che era un grande economista, lui ci domandò quanti esperti lavoravano con noi. Io dissi, esagerando un poco, che erano una quarantina (in realtà erano di meno); lui disse: - «Noi ne abbiamo seicento qui e seicento al Commisariat au plan». Poi riflettendoci ho pensato che, siccome la programmazione come obiettivo fondamentale è fallita sia da noi che da loro, noi in fin dei conti abbiamo speso di meno” (G. Ruffolo, Il libro dei sogni. Una vita a sinistra raccontata a Vanessa Roghi, Donzelli, 2007).
Oltre a un’intelligenza non comune che gli era riconosciuta da amici e avversari, a Giorgio Ruffolo non ha mai fatto difetto un’ironia acuta, che si faceva spietata quando la rivolgeva verso i risultati del suo percorso pluridecennale nelle istituzioni. Un’ironia che ha contraddistinto le sue preoccupate riflessioni sullo stato del Paese anche dopo l’abbandono della politica attiva e finché glielo ha concesso una lunga e impietosa malattia. Con Ruffolo se ne va un frequentatore di lungo corso della politica e delle istituzioni, che non ha mai smesso di lavorare dall’interno per la riforma di entrambe, riscuotendo (a suo dire) più sconfitte che successi, ma non per questo meno persuaso della necessità di un impegno diretto.
Cresciuto in una Roma capitale del fascismo e poi occupata dai tedeschi, ebbe due fratelli maggiori arrestati per attività sovversive e scampati miracolosamente all’esecuzione. Seguì il loro esempio da giovanissimo, con atti che definiva goliardici e provocatori, finché la Liberazione gli consentì di tornare agli studi in giurisprudenza. Più che il diritto, tuttavia, ad attrarlo furono l’economia e le opportunità di lavoro che questa gli avrebbe portato, in un ambiente familiare che non navigava nell’oro. Trovò un’occupazione all’Ufficio studi della Banca nazionale del lavoro, cui seguì una breve parentesi all’Oece (futura Ocse) a Parigi, infine il ritorno in Italia sotto l’ala protettrice di Enrico Mattei in quell’Ufficio studi dell’Eni diretto da Giorgio Fuà (su Fuà si veda il profilo scritto da Roberto Giulianelli pubblicato sul “Mulino” n.6/2019) che gli insegnò il valore e l’importanza della programmazione.
Venuto tragicamente a mancare il nume tutelare (Ruffolo ha affermato di non essersi trovato per puro caso sull’aereo precipitato), i forti dubbi sulla successione di Cefis e le aspettative per quanto stava maturando in ambito governativo lo spinsero a intraprendere la scelta che ne avrebbe condizionato il futuro politico e professionale. Nel 1962, nel pieno della tormentata gestazione del primo centrosinistra, Ruffolo fu chiamato da Ugo La Malfa a organizzare presso il ministero del Bilancio gli uffici che si sarebbero dovuti occupare della programmazione economica, intesa come spina dorsale dell’opera riformatrice degli anni a venire. Ruffolo vi giunse supportato dal Partito socialista, al quale era da tempo vicino, e soprattutto dal gruppo attorno ad Antonio Giolitti, che parve trovare nella prospettiva della “programmazione democratica” un valido sostituto per il comunismo appena abbandonato.
Ricoprì fino al 1975 il ruolo appositamente creato di segretario per la Programmazione economica presso il ministero del Bilancio e fu incaricato di coordinare gli studi e i lavori per il primo Programma nazionale
Fu così che Giorgio Ruffolo ricoprì fino al 1975 il ruolo appositamente creato di segretario per la Programmazione economica presso il ministero del Bilancio e fu incaricato di coordinare gli studi e i lavori per il primo Programma nazionale. In questo compito si avvalse della collaborazione preziosa di molti compagni stabili o occasionali (da Paolo Sylos Labini a Giorgio Fuà, dal recentemente scomparso Manin Carabba a Siro Lombardini, Severino Delogu, Franco Momigliano - quest'ultimo ricordato da Mario Dal Co in un articolo pubblicato su “Mulino” n.6/1988), ma subì anche il frequente ricambio dei ministri di riferimento e dei governi in generale. La programmazione avrebbe dovuto sfruttare la crescita economica del “boom” per porre rimedio, attraverso un maggiore impegno diretto dello Stato, a nuove distorsioni che lo sviluppo aveva sovrapposto a quelle già esistenti: non solo il divario Nord/Sud e il mancato decollo del secondo, ma anche gli sconquassi sociali e territoriali che il primo stava subendo a seguito del “miracolo”, dell’industrializzazione e dell’immigrazione; una gestione dissennata delle città e del territorio; la tragica penuria degli “impieghi sociali del reddito” (formula giolittiana per indicare il Welfare State) a fronte della poderosa crescita dei consumi privati. A condannare le aspettative che tutto ciò trovasse soluzione attraverso un’opera unica e coerente furono molti fattori, comunemente identificati dalla storiografia: il fragile accordo tra Dc e Psi perché la programmazione avesse la precedenza e la sottovalutazione delle differenze sui suoi fini ultimi non ressero l’impatto delle tante resistenze poste dagli interessi costituiti che essa avrebbe intaccato e dai timori per un suo sviluppo eccessivamente rivoluzionario.
Mentre l’opposizione al centrosinistra, anche dentro alle istituzioni, assumeva il suono minaccioso del “tintinnar di sciabole” e i contorni di un rischio concreto per le istituzioni democratiche, il peggioramento del clima economico (la famosa “congiuntura”) avrebbe offerto ai più timorosi all’interno della coalizione l’opportunità per ripiegare sull’urgenza di misure per il breve periodo e per allontanare indefinitamente le prospettive di una reale programmazione. Se Giolitti reagì rifiutando di tornare al governo nell’immediato per fare il “beccamorto della programmazione”, Ruffolo decise di rimanere e salvare il salvabile, producendo alla fine il primo Programma nazionale che sarebbe giunto al voto del Parlamento soltanto nel 1967 (dunque in ritardo sul suo naturale decorso 1966-1970). Come ultimo insulto ai “programmatori”, esso fu discusso, modificato e votato articolo per articolo, favorendo forse la convergenza tra le forze partitiche ma certamente contravvenendo allo stesso spirito ambizioso del Piano, pensato come unità coerente e calibrata di tutte le sue parti.
Dopo aver rassegnato le dimissioni nel 1975, Ruffolo avrebbe denunciato le responsabilità strutturali che avevano condannato il progetto al fallimento nel suo volume più duro e intransigente: in Riforme e controriforme egli si sarebbe scagliato contro lo Stato italiano, “garante del compromesso tra capitalismo e arretratezza”, “incapace di dare risposte ai requisiti politici di una democrazia di massa”; e contro l’amministrazione, baluardo della conservazione che avrebbe boicottato con la sua immobilità la gestazione del Programma. Più tardi, una volta presa la giusta distanza dagli eventi, egli avrebbe riconosciuto con l’onestà intellettuale che gli era propria anche le responsabilità degli stessi “programmatori” nel sopravvalutare le proprie forze e nel sottovalutare la necessità di un maggiore coinvolgimento della popolazione in un lavoro che, per tale ragione, non aveva saputo guadagnare supporto sufficiente nel Paese. Evidentemente scosso da un fallimento che sentiva come personale, Ruffolo sembrò accettare soltanto con il passare del tempo un’evidenza che altri suoi collaboratori dell’epoca furono più pronti a rivendicare. Se l’impianto complessivo della programmazione era fallito, nondimeno esso aveva dato un impulso decisivo per quanto diseguale a una serie di riforme che avevano realmente cambiato il Paese in meglio: dall’istituzione delle regioni a leggi importanti in materia di gestione del territorio, dallo Statuto dei lavoratori alla creazione del Servizio sanitario nazionale.
Soprattutto, tra il 1987 e il 1992 fu il primo politico a guidare con continuità e sostanza il ministero dell’Ambiente, nato soltanto un anno prima
La sua vicenda nelle istituzioni era tuttavia lontana dalla conclusione. Il Psi lo avrebbe candidato con successo alle prime elezioni dirette per il Parlamento europeo (1979) e successivamente a quelle nazionali per la Camera dei deputati (1983). Soprattutto, tra il 1987 e il 1992 fu il primo politico a guidare con continuità e sostanza il ministero dell’Ambiente, nato soltanto un anno prima. La nomina di Ruffolo parve un tardivo riconoscimento per il lavoro incredibilmente lungimirante del “Progetto 80”, Rapporto preliminare per il secondo Programma nazionale elaborato nel 1969-1971 sotto la sua guida e con il contributo fondamentale dell’economista, urbanista e amico fraterno Franco Archibugi: un documento che introduceva per la prima volta in Italia il concetto di risorse naturali come beni collettivi da tutelare, nonché quello di aree da proteggere nell’interesse nazionale; e che legava meticolosamente le necessità della protezione del territorio a quelle dello sviluppo economico e sociale, chiamando in causa una complessa architettura istituzionale che avrebbe dovuto comprendere tanto lo Stato quanto le regioni e delle apposite agenzie indipendenti (si veda la lunga intervista a Ruffolo inclusa nell’eccellente volume di Cristina Renzoni Il Progetto 80. Un’idea di Paese nell’Italia degli anni Sessanta, Alinea, 2012).
Se il documento aveva prodotto ben poche conseguenze all’epoca della sua estensione, a causa dell’esaurimento del centrosinistra e della definitiva rinuncia alla programmazione, l’arrivo di Ruffolo al ministero dell’Ambiente sembrò offrire l’opportunità per il recupero di alcune sue parti. Pur tra molte difficoltà congiunturali, come la gestione delle conseguenze del referendum sul nucleare, le mucillagini nell’Adriatico, le crisi periodiche per lo smaltimento di rifiuti tossici, Ruffolo rivendicò di aver posto le basi per una politica di più lungo periodo in materia di risanamento di aree come il bacino del Po e la laguna veneta, così come con la prima legislazione organica sui rifiuti industriali e con quella sui parchi naturali; più in generale, la crescente sensibilità in materia trovò riscontro in un’idea nuova di ecologia e di ambiente che sottraeva il settore da una nicchia per inserirlo all’interno delle necessità primarie del Paese.
Il crollo della Prima Repubblica e del Psi, il cui corso craxiano lo aveva visto sempre critico, spinse Ruffolo ad aderire ai Democratici di sinistra, persuaso fino alla fine che soltanto un partito di massa e di stampo socialdemocratico potesse salvare le sorti della sinistra in Italia. Una sinistra riformista cui, finché ebbe voce, Ruffolo ha imputato la colpa di aver abbandonato quell’idea ambiziosa di progettualità che, tra successi e fallimenti, ha costituito la vera nota caratterizzante della sua traiettoria di impegno e di vita. “Devo dire che non ce l’ho affatto con la destra, che fa il suo mestiere, ma con quelle cingallegre della sinistra che non perdono occasione per ironizzare sulle «anime belle», sulle «utopie astratte», in nome di una concretezza e di una serietà che fino a oggi non hanno prodotto neppure una riforma degna di questo nome”. Uno slancio programmatico che ha continuato a perorare fin dentro al nuovo millennio come unica risposta possibile alla china di una decomposizione politica e sociale del Paese in un pulviscolo di privilegi e particolarismi.

Riproduzione riservata